Sergio Givone e Padre Boetti
Si è formato in una grande scuola di pensiero, Sergio Givone: quella di Luigi Pareyson all’Università di Torino, dove sono cresciuti talenti di diversa ispirazione, da Umberto Eco a Gianni Vattimo, da Giuseppe Riconda a Mario Perniola. Una scuola di libertà.
Per Luigi Pareyson, la libertà è il grande tema che compendia l’itinerario del pensiero moderno fino a Martin Heidegger e oltre. La libertà e la sofferenza, che della libertà è il “ritmo”, la segreta “pulsazione”. È la sofferenza ad animare la vita; la sofferenza è il suo fulcro dinamico. E dunque a caratterizzare il filosofo non può essere una quieta saggezza, o una esaustiva discorsività, ma un travagliato, impaziente interrogare, di cui Luigi Pareyson è stato un significativo testimone.
In questa cornice, il pensiero si sviluppa come una sfida o come una lotta. Con il mondo e con la vita. Qui si muove Sergio Givone, superando spesso la linea sottile che sembra separare la filosofia dalla letteratura. In Il bibliotecario di Leibniz (Einaudi, 2005) esprime le ragioni del suo spostarsi tra l’una e l’altra: “è nelle infinite storie degli uomini che la filosofia trova i suoi contenuti essenziali”. Così a partire da La favola delle cose ultime (Einaudi, 1998), dove Givone torna al mondo delle sue origini, una cascina tra le risaie del vercellese, si china sulle storie degli uomini, le ascolta e le raccoglie, ne bracca il senso, collocandosi nel punto in cui la filosofia arretra e la diseguale sonorità delle parole della vita comincia a riecheggiare. Lungo questa strada, incrocia esistenze dai contorni indefiniti, le esili tracce di traballanti identità, dove la relazione tra verità e menzogna si fa sfuggente.
Consideriamo la bellissima pagina che fa da avvio a Tutto è grazia, l’ultimo libro di Sergio Givone (appena pubblicato dall’editore “Il Melangolo”), dove le identità sono ben più che traballanti, profili instabili, che vertiginosamente si moltiplicano, emigrano verso altri nomi, fittizi involucri di un vuoto:
“Che nella sua vita il padre Giambattista Boetti sia stato Sheik Mansur è un fatto. Ma un fatto è che sia stato tanti altri personaggi, e abbia indossato tante altre maschere. Lui era sempre lui naturalmente. Ma se, almeno in cuor suo, lui restava se stesso, in pubblico assumeva ruoli e nomi diversi. E per giunta conferiva ad altri precisamente i ruoli e i nomi che aveva scelto per sé: Almansur, il vittorioso, ma anche lo Stenebrante, e non soltanto. E così accadde che di Mansur in giro per il mondo ce ne fosse più d’uno. Con tanto di scambio. Scambio continuo”.
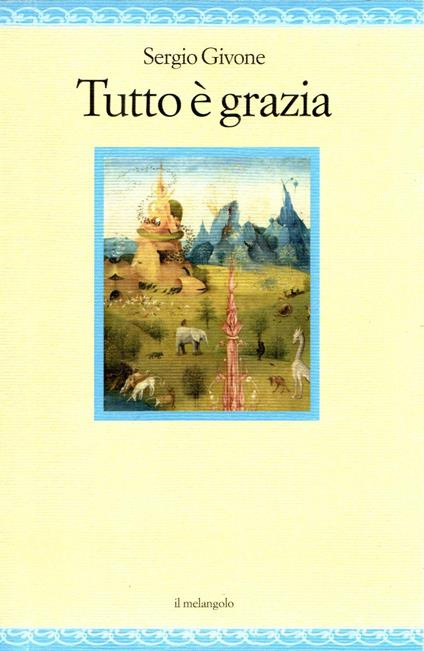
Giambattista Boetti (il pittore Alighiero Boetti, protagonista della pittura italiana del secondo Novecento è un suo successore) è un padre domenicano originario di un piccolo paese del Monferrato, Piazzano di Camino, dove nasce nel 1743 in “una bella casa agli inizi dell’abitato”. Famiglia aristocratica, padre notaio, con cui entra ben presto in conflitto, vita assai agitata, studi di medicina a Torino, viaggi in tutta Europa, condotta libertina, e un discreto patrimonio accumulato nell’arco di pochi anni in modi non del tutto chiari. Nulla, d’altra parte, è chiaro nella vita del padre Boetti, che procede, con disinvoltura, su un terreno in continuo sommovimento, linee spezzate, e vaste zone d’ombra. Personaggio naturalmente romanzesco il padre Boetti, incline a scambiare fantasia e realtà, mostrando quanto sia labile il loro confine.
Lo ha ben capito Sergio Givone seguendo, per quanto sia stato possibile, i suoi labirintici percorsi di vita: “Il ruolo scelto per la recita sulla scena nel mondo sembra adattarsi assai bene a un frate piemontese che si è fatto missionario in Medio Oriente, di cui ha presto imparato le lingue e anche gli usi e i costumi, ma soprattutto le fantasticherie più allucinate”.
Recita appunto, scena, teatro, ma dai ruoli mobili, maschere, e gioco di apparenze, orchestrazione d’inganni. Ne è autorevole maestro Giambattista Boetti. Un giocoliere, e un seduttore di anime, ma non solo di anime.
Lo abbiamo lasciato al suo ritorno in Italia dopo il lungo viaggio in Europa. C’è ovviamente molto altro, c’è una vita in continua ebollizione, che s’inventa via via. E avanza camminando sulle strade del mondo. Con i molti nomi dentro di sé che si porta appresso, costante bagaglio delle sue avventure.
Studia teologia a Ferrara. Il severo noviziato dell’ordine domenicano lo impegna per cinque anni. Giovanbattista Boetti evidentemente si adatta: corpo e anima sono plastici. Negli anni a venire, impetuosi, si troverà a maltrattare la dottrina acquisita a Ferrara, intreccerà cristianesimo e islam, con un pizzico d’illuminismo utopistico, approdando poi a “un nuovo vangelo, il vangelo della libertà, in base al quale diventa lecito ogni atto che sia compiuto ‘in piena avvertenza e deliberato consenso’, come recitava la formula scolastica che il padre domenicano non aveva dimenticato”. E di questa nuova religione si farà predicatore e profeta.
Dopo gli studi teologici comincia un movimento senza apparente direzione, una cieca frenesia: sarà missionario in Iraq, medico del Pascià di Mossul, diventerà responsabile della sua comunità, con la quale però entrerà in collisione per cattiva amministrazione e condotta immorale: questa l’accusa dei confratelli. Sarà allora costretto a tornare in Italia, ormai sotto la sorveglianza delle gerarchie ecclesiastiche.
Ma nulla lo ferma. Si dispone a uscire dall’ordine domenicano, e, disobbedendo alle disposizioni ricevute, riprende la strada dell’Oriente. Qualche anno dopo chiederà di essere riammesso, entrando nel monastero di Trino Vercellese, ma troppe cose ha per la testa. Tornerà in Oriente: questa è la terra dove respira il suo spirito, l’Oriente delle “fantasticherie più allucinate”. E alle “fantasticherie” Giambattista Boetti dà consistenza di realtà. Sbriciola la realtà, manomette l’identità, la altera, all’una e all’altra Boetti non dà legittimità. Per lui sono reali solo gli impeti del cuore.
Qui la vita di Giambattista Boetti compie un’altra piroetta, la più ardita, ma non l’ultima: lasciata la tonaca bianca dei domenicani indossa la maschera del profeta, e addirittura del condottiero alla testa di un esercito di 80.000 “derelitti”. Si mette contro l’Impero ottomano agitando lo spirito di riscatto del Caucaso. È “guerra santa”. Boetti cerca di formare il suo regno, raccogliendo qualche vittoria, schiantandosi poi contro il muro dell’Impero Russo. Le “fantasticherie” sono finite. Giambattista Boetti, o Almansur il vittorioso, o altri, si spegne nel 1798 in una prigione delle isole Solovki, dove 185 anni dopo verrà costruito il primo gulag sovietico.







