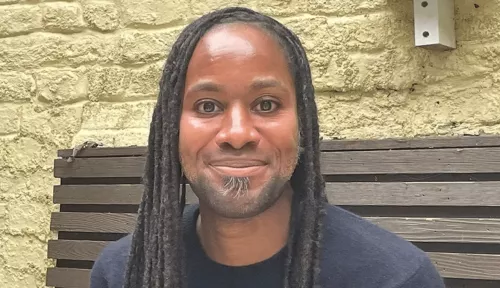Diversi da chi? Autismo e alterità
È innegabile che al concetto di autismo sia capitata in sorte la stessa “fortuna” sociale che hanno avuto espressioni come “narcisismo” e “borderline” che hanno trasceso la dimensione clinica per divenire fenomeni culturali in progressiva espansione; metafore, più o meno pertinenti, di tratti comportamentali o di aspetti della personalità – in questo caso dell’autoreferenzialità, poiché autismo deriva dal greco αύτός, “se stesso”.
Contemporaneamente, sul versante strettamente clinico, le diagnosi di autismo, un tempo piuttosto rare, hanno conosciuto una proliferazione che ha spinto alcuni a parlare di epidemia autistica con le immancabili associazioni libere di stampo paranoico-complottista sulle ragioni delle cause che potrebbero aver inciso su questa impennata di casi (vaccini, inquinamento da metalli e via dicendo). Recenti ricerche hanno dimostrato come l’autismo abbia in realtà una matrice biologica ma che sia importante considerarlo anche un costrutto culturale – come del resto ogni fenomeno umano – che chiama in causa i criteri e gli standard che definiscono ciò che comunemente chiamiamo “normalità” e che distinguiamo dalla malattia, intesa come devianza da un modello funzionale, sano.
Mi viene in mente Corpo e anima, uno splendido film del 2017, Orso d’oro alla 67° edizione del festival del cinema di Berlino, scritto e diretto dalla regista ungherese Ildikó Enyedi, la cui protagonista femminile è una donna autistica che s’innamora, per la prima volta in vita sua, di un uomo con una paralisi ad un braccio (naturalmente questi due aspetti, per entrambi, sono solo una parte della loro identità che non va confusa con il tutto). La storia racconta un tragi-comico, e commovente, processo di alfabetizzazione psico-affettiva che esaspera una verità esistenziale che ci riguarda tutti: non sappiamo come si ama, ce ne facciamo un’idea per tentativi e errori, quasi sempre su base mimetica, certamente in maniera irriducibilmente relazionale, e siamo spesso disorientati – e talvolta anche spaventati – dalle conseguenze emotive e dalle ricadute identitarie di questa esperienza così personale, e potenzialmente individuativa, da rendere vano ogni riferimento a un canone normativo di come si dovrebbe amare.

Gli individui che si trovano a diverso titolo in quello che viene definito “lo spettro autistico” – specie Asperger e individui autistici ad alta funzionalità – rivendicano con forza l’idea di non essere malati ma di essere persone che sentono, pensano, agiscono e dunque vivono, semplicemente in maniera diversa dai cosidetti individui neuro-tipici, ossia dalle persone i cui neuroni funzionano secondo modelli più comuni e condivisi. Tra gli aspetti che differenziano le persone autistiche dalle altre, ci sono alcune costanti quali la difficoltà a sviluppare alcune aree di funzionamento cognitivo e comportamentale che potrebbero essere causate da una scarsa attivazione dei cosiddetti “neuroni specchio”. Si tratta, come noto, di neuroni che svolgono un ruolo fondamentale per quanto riguarda l’imitazione, lo sviluppo del linguaggio, la lettura e la comprensione delle azioni, delle emozioni e del comportamento altrui, e che si rivelano fondamentali per lo sviluppo non solo cognitivo e affettivo ma anche sociale dell’individuo e che spiegherebbero, tra l’altro, la difficoltà di molte persone autistiche a relazionarsi, rispondendo in maniera considerata scarsamente empatica.
Lo dimostrerebbero le risonanze magnetiche funzionali che hanno evidenziato come nei soggetti autistici, a differenza dei soggetti neuro-tipici, non si presenti alcuna attivazione nel giro frontale inferiore del cervello mentre osservano o imitano alcune espressioni facciali. Questa incapacità di rispecchiamento renderebbe estremamente difficile “mettersi nei panni dell’altro” ed entrare in sintonia con esso, comprenderne le azioni e farsi comprendere a propria volta, e dato che la comprensione delle intenzioni e delle azioni altrui si forma proprio sulla capacità di riconoscerle e di imitarle, il malfunzionamento in questo campo può avere conseguenze molto deleterie per un soggetto in via di sviluppo e per la sua vita sociale.
Per comprendere cosa si provi a vivere privi di questa funzione può essere interessante leggere il libro di John Elder Robison, Professore associato all’Elms College di Chicopee, nel Massachusetts, e imprenditore di successo nell’ambito degli strumenti musicali e dei sistemi di amplificazione (ha lavorato, tra gli altri, per i Pink Floyd e i Kiss): Siate diversi. Storie di una vita con l’asperger Armando editore, 2023, pp. 208, euro 20.
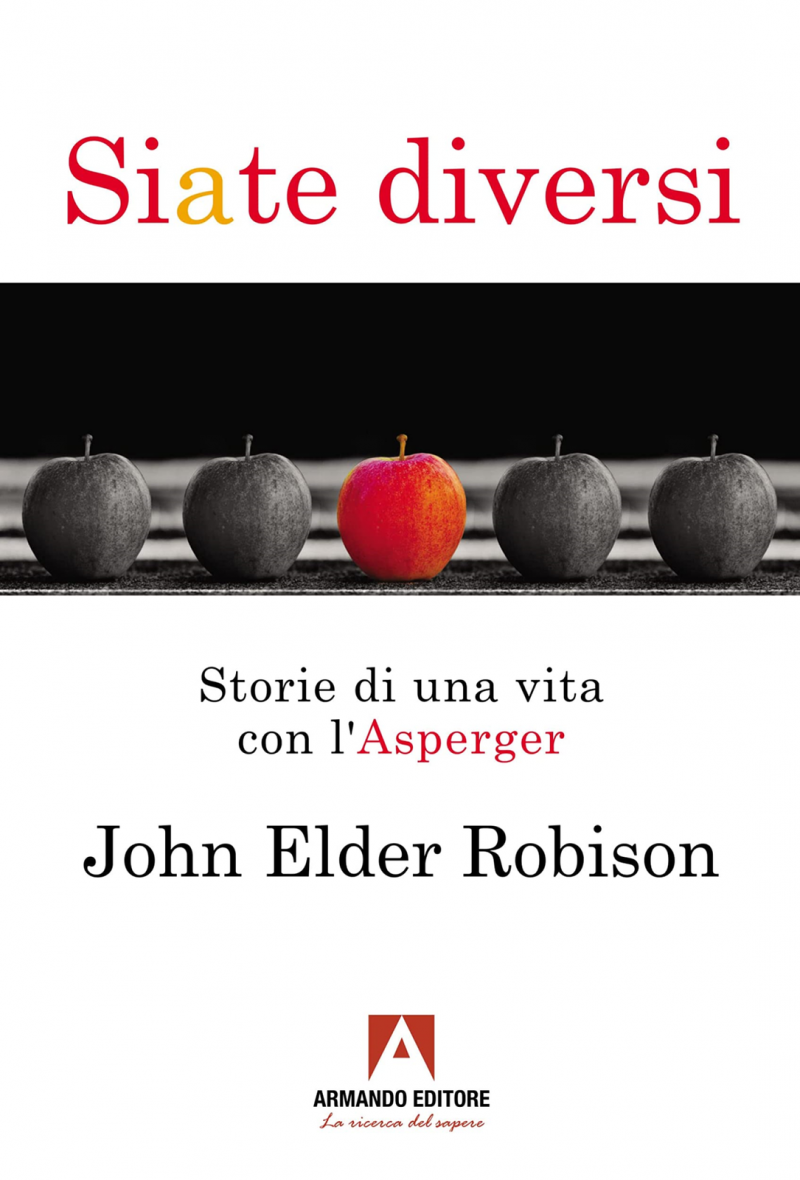
Il suo caso è particolarmente interessante perché Robison ha vissuto quarant’anni senza sapere di essere un Asperger e quando ha scoperto di esserlo si è servito di questa diagnosi per spiegarsi retrospettivamente la prima parte della sua vita, il perché di alcuni suoi comportamenti e delle reazioni degli altri, e poi a comprendere l’analoga condizione del figlio per potergli essere d’aiuto. Leggiamolo:
“Quando ero un bebè e stavo dalla famiglia di mia madre (…) mia nonna aveva l’abitudine di prendermi in braccio e farmi delle smorfie. Non sapevo che molti adulti lo facessero con i bambini piccoli. (…) Perciò non sapevo bene cosa fare quando la nonna mi tirava su e appiccicava la sua faccia alla mia. Fondamentalmente sembrava enorme e mostruosa. Le smorfie che faceva ricordavano quelle di un pagliaccio, tanto erano esagerate e assurde. Io la guardavo a mia volta, confuso da ogni strana espressione che assumeva. Era divertente? Era spaventosa? Non ero mai del tutto certo. Dopo un po’ si stufava. «Perché non mi sorridi? Sei proprio un bambino cattivo!». Ciò detto, la nonna Richter mi rimetteva a terra dritto sui i miei piedi tozzi, e se ne andava poi sulle sue tozze gambe.” (p. 61).
Il linguaggio non verbale è il vero tallone d’Achille dei soggetti autistici e si estende a contesti apparentemente meno equivoci che mettono piuttosto in evidenza lo scollamento, che talvolta trascuriamo, tra le nostre affermazioni e i nostri comportamenti, che non di rado sono in contraddizione tra loro. L’autore racconta che la madre, quando era bambino, gli chiedeva: perché non mi rispondi mai che mi vuoi bene vuoi bene dopo che te lo dico io? Mia madre, spiega Robison, “mi diceva ti voglio bene e poi mi abbandonava al terrificante mondo invisibile in cui, di notte, si trasformava la mia stanza. Per il me bambino quella frase non aveva una connotazione del tutto positiva. I grandi si aspettavano che capissi il significato delle loro parole indipendentemente dalle azioni da cui venivano seguite. Beh non ci sono mai riuscito”.
A volte l’incoerenza e la contraddittorietà nei comportamenti di chi diceva di amarlo, ma magari poi lo picchiava, appariva ancora più stridente e rendeva evidentemente difficile comprendere quanto sentito ma non abbastanza sperimentato. In particolare l’autore racconta di come per tutta la vita gli sia risultato difficile cogliere gli aspetti della comunicazione non verbale e quanto questa difficoltà sia alla base di moltissimi equivoci nelle relazioni con soggetti autistici che non sembrano avere gli strumenti per capire se una persona sta scherzando o meno, se sta usando un’iperbole o parla sul serio, perché tendono a letteralizzare ciò che ascoltano, il che li fa apparire a volte insensibili mentre sono semplicemente adesivi al messaggio che ricevono, senza comprenderne le sfumature non verbali e gli impliciti ambientali. La situazione viene poi complicata dal fatto che, data la loro alta emotività, queste situazioni si rivelano spesso per questi soggetti fonti di agitazione e ansia considerevoli che possono farli agire in maniera sconsiderata agli occhi degli altri.
Tuttavia, spiega Robison, in alcuni casi i modi di ragionare degli individui autistici possono essere più funzionali e utili di quelli dei cosiddetti neuro-tipici. Alcune delle sue fissazioni – i soggetti autistici hanno spesso interessi selettivi, limitati e tendenzialmente maniacali – gli hanno permesso di affermarsi nel lavoro di tecnico del suono e delle luci nel mondo della musica rock e l’alta preoccupazione e la logica ferrea che ne consegue nel valutare i pericoli di alcune situazioni renderebbe i soggetti autistici ad alta funzionalità particolarmente adatti a ruoli di sicurezza. Ne costituisce un esempio virtuoso l’incapacità di Greta Thunberg di comprendere come fosse possibile che alla preoccupazione dichiarata di fronte ai dati allarmanti della crisi ecologica non seguissero azioni minimamente coerenti.
In effetti non è il comportamento di Greta a essere strano ma la nostra scissione. Simili esempi, non sempre così convincenti, si rincorrono nel libro Siate diversi offrendoci la possibilità di praticare il prospettivismo nietzschiano, perché se è vero, come recita un antico adagio taoista, che ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla, lo è altrettanto la massima di Basaglia per la quale da vicino nessuno è normale. Si tratta dunque di imparare non solo a comprendere e ad accettare le differenze ma a valorizzarle, concedendo chances a chi spesso non ne ha e che per questo resta indietro. I bambini autistici possono infatti avere un ritardo cognitivo anche significativo ma non sono destinati a restare “ritardati” per sempre, come si diceva una volta di alcuni di loro.
Avrete probabilmente letto del caso di Jason Arday che a trentasette anni è da poco divenuto il più giovane insegnante di colore della storia dell’Università di Cambridge, nonostante una forma particolare di autismo gli avesse impedito di parlare sino all’età di undici anni. I medici avevano spiegato ai genitori che avrebbe avuto bisogno di un’assistenza per tutta la vita e che non avrebbe mai potuto cavarsela da solo. Invece Arday ha potuto contare su un ambiente sufficientemente capace di accompagnarlo alla crescita e di credere in lui, facendogli seguire altri canali di espressione e comunicazione, come la musica, finché questo ritardo non si è colmato e il giovane londinese, nella tarda adolescenza, ha iniziato a leggere e scrivere.
Non sempre, tuttavia, le vite degli individui nello spettro autistico conoscono un simile lieto fine e spesso le esistenze di coloro che li accompagnano sono attraversate da considerevoli difficoltà. Impossibile generalizzare per un fenomeno così vasto e differenziato, ma certo, come diceva Danilo Dolci, “cresce solo chi è sognato”, chi ha la fortuna di avere quello che Winnicott definiva un ambiente “sufficientemente buono”, capace proprio di rapportarsi in maniera attenta, creativa e non sbrigativamente giudicante con quanto appare strano, disfunzionale, diverso. Su questo è la nostra cultura, temo, a essere in evidente ritardo.
In copertina, Jason Arday nominato Professore di Sociologia dell’Educazione presso l’Università di Cambridge (Foto: Università di Cambridge).