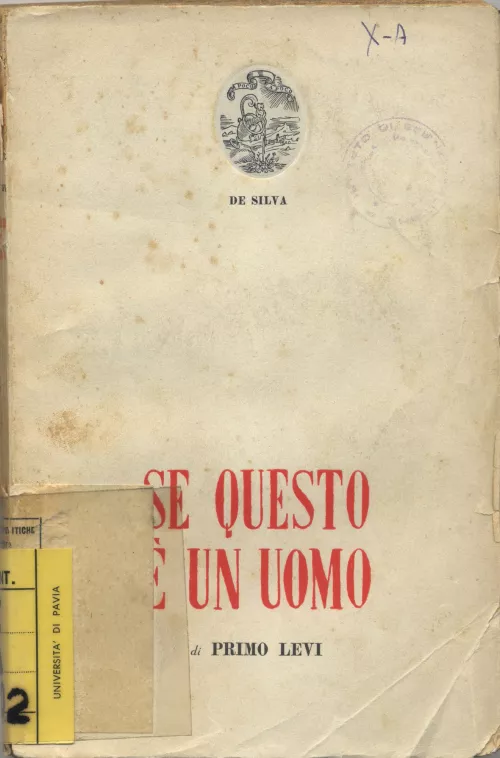Tra memoria e antropologia / Se questo è un uomo e le prime testimonianze
Il mio contributo a questo convegno prende le mosse da uno studio sui primi libri che hanno raccontato in Italia i Lager: tale contesto può contribuire ad evidenziare quanto la forza letteraria dell’opera di Levi si radichi nella sua attitudine all’esercizio antropologico e quanto in esso trovi la capacità di generare memoria. Si tratterà di considerare quanto la struttura narrativa, tanto nel suo rapporto con l’oggetto e il destinatario tanto con il contesto più in generale, evochi temi e questioni familiari all’antropologia.
A qualche mese dall’uscita di Se questo è un uomo, Cesare Cases, germanista e vivace intellettuale della comunità ebraica milanese, coglieva “il segreto” del libro nell’aver voluto “rendere l’inumano con parole umane, riportare il regno della morte nelle dimensioni consuete degli uomini che dimorano nelle case”: una sfida riuscita grazie all’arte che permette a Levi di dare a vedere il “mondo omogeno, compatto” del Lager, di scandagliarlo di fronte al lettore “al contrario di quel che accade in parecchi libri usciti dall’esperienza dei campi di concentramento, incapaci di superare l’immediatezza dell’orrore”.
Quando, nell’ottobre 1947, usciva in libreria Se questo è un uomo, il pubblico italiano non si trovava forse nella situazione degli Alleati che, entrando nei campi, rimasero disorientati “come se scoprissero una popolazione sconosciuta della nuova Guinea”; eppure, come loro, si trovava nella condizione di doversi costruire percorsi di conoscenza per rendere l’universo concentrazionario parte del sistema dell’immaginabile.

Durante tutto il periodo della guerra e benché le notizie dai Lager circolassero in Europa, la deportazione in Germania era rimasta una nebulosa vaga. Alla liberazione l’emorragia di fotografie diffuse dagli Alleati fanno dei campi e dei sopravvissuti icone dell’orrore della guerra. Fare spazio alla parola che intende dare a vedere l’esperienza implicita nell’icona, fare un posto all’universo concentrazionario nell’immaginario italiano è una sfida del dopoguerra in cui libri hanno inevitabilmente un ruolo.
Varrà allora la pena osservare che nel 1947 Se questo è un uomo è l’ultimo libro firmato da un deportato della stagione editoriale 1945-1948 e in cui il tema dei Lager si confronta con la costruzione della narrazione collettiva del conflitto appena concluso.
Fissiamo alcuni dati. Dal 1945 al 1948 vengono pubblicati 29 libri (11 nel 1945, 13 nel 1946, 4 nel 1947, 1 nel 1948), poi un lungo silenzio che si romperà solo nel 1952. Gli autori sono per la maggior parte deportati, ma non solo: su un totale di 29 autori, sette non sono deportati e due tra questi raccontano due storie singolari (una di un deportato immaginario e l’altra di una donna). In maggioranza (79,3%) gli autori sono uomini e tra i deportati quelli per motivi politici sono il 55, 2% contro il 20,7% di quelli per motivi razziali (percentuale inferiore anche a quella degli autori non-deportati, il 24,1%). Per maggiori dettagli cfr. la mostra “E tutto questo diventa una storia”. I primi libri che in Italia hanno raccontato i Lager, a cura di Isrec Bergamo, gennaio 2016.
Se attraversiamo questi dati con Primo Levi e il suo Se questo è un uomo, il segreto del libro evidenziato da Cases non solo trova le sue radici nel contesto storico, ma di esso mette in luce il movimento e l’insita esigenza di un esercizio antropologico in grado di ridefinire i contorni dell’immaginario collettivo.
È un dato che in un’Italia uscita dalla guerra con un cambio di regime, in cui l’idea di cittadinanza si va fondando su una lettura antifascista del conflitto appena concluso, l’orizzonte di attesa del pubblico fa emergere le voci che raccontano la deportazione come conseguenza dell’impegno nella Resistenza e fa del deportato politico maschio il simbolo dell’esperienza concentrazionaria. Tuttavia, le storie dei deportati si intrecciano nei libri e i sopravvissuti che raccontano assumono una postura di delega, tanto che dalla lettura dei testi risulta chiaro come in quegli anni non si impone all’attenzione collettiva un campo simbolo e come, accanto al tanto citato Mauthausen, Auschwitz e la storia degli ebrei trovano posto non solo nelle narrazioni degli autori che raccontano poiché deportati razziali. In questo modo le voci che testimonia l’esperienza di Auschwitz si connettono alla trama dell’immaginario che si va tessendo, fili imprescindibili che ne impediscono la sclerotizzazione. Interessante allora notare che se il libro di Primo Levi è l’ultimo dei sette libri specificamente dedicati ad Auschwitz, i sei che lo precedono sono firmati da sette donne, cosi da poter dire che le donne per prime hanno raccontato Auschwitz in Italia e viceversa constatare che attraverso il racconto di Auschwitz emerge, nell’immaginario collettivo, la voce delle donne deportate. Il simbolo del deportato politico azzera la voce delle donne italiane deportate per motivi politici, ma organizza un orizzonte d’attesa ampio, all’interno del quale Se questo è un uomo si leva come l’unica voce maschile nel gruppo degli autori deportati-razziali, ma si colloca come paradigma di un’urgenza di racconto e di un bisogno d’ascolto che è comune a tutti e che sottende e impone uno sforzo per rendere intelligibile il mondo dei Lager.
Da una parte, non è questione di soffermarsi sull’ormai troppo conosciuta storia editoriale di Se questo è un uomo. Ricordiamo solo che essere pubblicati da piccole case editrici è destino comune a tutti gli autori che in quegli anni vogliono parlare di Lager (unica eccezione Aldo Bizzari, scrittore già prima della deportazione, che pubblica per Mondadori). E aggiungiamo che non è da sottovalutare la convinzione dimostrata da queste case editrice perché indice di un’azione critica nei confronti del contesto del dopoguerra.
Dall’altra parte, la poesia di apertura di Se questo è un uomo nella forza dei suoi versi (“[…] Considerate se questo è un uomo […] Meditate che questo è stato […] O vi si sfaccia la casa/ la malattia vi impedisca/ i vostri nati torcano il viso da voi”) sintetizza quanto la sfida di trovare ascolto sia imperiosa e contenga in sé una dose di violenza indotta non tanto dall’indicibile, ma dall’incredibile della storia da raccontare. La scrittura di Se questo è un uomo è emblematica di quanto la difficoltà non sia mai nel dire, ma nel far immaginare il destinatario. Non è questione di ritirarsi impauriti davanti al linguaggio povero rispetto all’esperienza vissuta, ma di risignificare le parole nel confronto con l’esperienza del campo, sotto la lente del narratore che la indaga, di fronte a un destinatario disposto, ma in un certo senso anche obbligato, a mettere in discussione il proprio sistema di riferimento. Tanti gli esempi a questo proposito. Si ripensi anche solo a come il narratore, sulla soglia del testo, porta il lettore a passare in rassegna un lungo elenco di gesti che gli permettano di comprendere “il duplice significato del termine ‘Campo di concentramento’”. Se da letterati cogliamo qui “l’arte della glossa” di Levi (A. Cavaglion), possiamo anche rilevare quella vocazione dialogica propria all’antropologia che fa della traduzione uno spazio di incontro con l’altro e per gli altri e spinge a ripensare all’esercizio letterario come esercizio di osservazione che scioglie le impasse del linguaggio nella fluidità di una narrazione che mira a dire il mondo e le sue diverse esperienze trovando le parole per fare gli altri partecipi.
Non sarà allora secondario osservare che la parola “indicibile”, oggi troppo spesso connessa all’esperienza dei Lager, non aiuta certo a cogliere le sfide di quei primi narratori, ben consapevoli che la difficoltà stava nella “necessaria incredulità” dell’ascoltatore di fronte alle loro storie. Nella scia di Primo Levi, vale la pena non dimenticare che, nei primi libri pubblicati per testimoniare, le parole “indicibile”, “indescrivibile” sono molto meno usate di “incredibile”, “inimmaginabile”, “incomprensibile”. La questione non è un’impossibilità o un’interruzione di comunicazione, ma la necessità di mettere in discussione, insieme al destinatario, l’immagine del mondo accreditata, per rendere l’esperienza vissuta in Lager diventi patrimonio di conoscenza di tutti. Non è un caso che “l’inferno” sia una metafora che, pur se storicamente fuorviante, ricorre in molti testi e che, come per Levi, per molti (7 su 29) sia esplicito il riferimento a Dante.
Ed è qui che si impone la specificità di Levi in quanto scrittore, come fin dal 1948 Cases lo riconosceva, capace di mettere in campo delle strategie narrative in grado di dare a vedere grazie alla capacità di rendere l’osservazione strumento di narrazione, la descrizione perno e non pausa dello svolgimento narrativo.
L’io-narratore, che nell’edizione del 1947 emerge in medias res (le citazioni che seguono sono tratte da questa edizione), si assume la responsabilità di tracciare un percorso di adattamento alla vita dell’universo concentrazionario che diventa un percorso di conoscenza anche per il lettore che sta alle spalle del narratore-personaggio: tale percorso, in consonanza con gli altri testi coevi, parte dall’Italia, dall’universo concentrazionario italiano (Fossoli in particolare) e si fonda sull’identità tra narratore e personaggio che implica il suo possibile sdoppiamento, o per dirla in antropologia su un’osservazione partecipante che porta il narratore-personaggio da una condizione di novizio del campo (p. 32) a quella di “vecchio prigioniero” (p. 169), incrociando due isotopie che corrono nel testo e che rendono esplicito quanto l’attitudine all’osservazione corrisponda alla volontà di fare attraversare il mondo del Lager come sistema da indagare e denunciare. Da una parte, un’isotopia teatrale, disegnando una linea guida del testo, porta il narratore-personaggio a fissare come su una scena, e sotto i riflettori dell’osservazione, l’esperienza diventata racconto: l’io narratore, facendo leva sullo sdoppiamento tra il suo ruolo di narratore e quello di personaggio, pare invitare a vedere la vita del Lager come un “dramma pazzo” (p. 23), ora suggerendo una possibile scansione in atti (pp. 22, 150), ora cogliendone la “coreografia” (p. 45), ora mostrando i nazisti quali spettatori più o meno divertiti (pp. 23, 25), ora sottolineando e annunciando la sua stessa presenza nella storia con l’avverbio “eccomi/ecco” (pp. 33, 37, 113) che sembra fare eco al “rientra in scena” del kapo Alex (p. 118). L’universo concentrazionario diventa un’esperienza di campo, grazie all’osservazione partecipante implicita nell’arte di narrare di un narratore che partecipa e osserva, continua a muoversi da livello diegetico a quello extradiegetico. Dall’altra parte, un’isotopia epistemologica dissemina il tema della conoscenza che il narratore in quanto personaggio deve fare propria per sopravvivere: è il “Ne pas chercher à comprendre” inciso sul fondo della gamella di un compagno (p. 113); è il ritornello ripetuto ai nuovi arrivati (p. 23); è ciò che resta da fare all’uomo incredulo (p. 41); è il commento all’incontro con il capo del Laboratorio di chimica, dottore in glottologia (p. 54); è “la saggezza” del vecchio Häftling (p. 127). L’universo concentrazionario diventa mondo strutturato da un sapere che si può e si deve conoscere, anche se non comprendere.

In questo modo la forma del testo fa propria, capovolgendola, la struttura tipica del percorso di iniziazione, connettendo la tradizione, i suoi modi e le sue forme di conoscenza, al tempo in cui “l’uomo è stato cosa agli occhi dell’uomo”, rendendo leggibile l’universo concentrazionario nell’immaginario del destinatario. In questo modo l’orrore diventa spazio di narrazione, in una rivincita di narrazione che permette di vedere là dove la logica SS cancella. Negli uomini ridotti a numeri per essere sterminati, nei “vermi senz’anima”, nei “fagotti vuoti”, il narratore rintraccia destini singolari, ciascuno sacro come “le storie della Bibbia”: è così che la parola “Häftling” si riempie di significato di fronte al lettore e dentro una narrazione che non resta schiacciata dall’orrore del campo.
Messa sotto le lenti create dall’impianto narrativo, la storia dell’iniziazione alla vita del campo si mostra una storia di anti-formazione alla vita di uomo. La saggezza del campo è l’opposto di ciò che la parola “saggezza” evoca nel mondo degli uomini liberi e attorno ad essa ruota un universo in cui l’esperienza è vissuta nel rovesciamento o, se si vuole, nella sospensione o nell’abolizione delle abitudini mentali dell’uomo libero. La rivincita del narratore è la “vendetta del racconto” che per Levi significa fare emergere nello spazio grigio del campo, il brulichio della vita delle esperienze singolari, colte nella specificità del loro muoversi all’interno del sistema Lager; del loro abitarlo. È così che attraverso i gesti dei tanti personaggi che popolano il testo, Se questo è un uomo racconta il Lager facendo considerare che fu “anche e notevolmente, una gigantesca esperienza biologica sociale” (p. 91) e mirando all’obiettivo dichiarato dal suo autore, quello di “fornire documenti per uno studio pacato dell’animo umano” (p. 7).
Per concludere, vorrei rilevare che là dove nel 1958 troviamo la parola “memoria” (p. 86), nel 1947 c’era la parola “fantasia”, monito a non dimenticare che la fantasia è la radice della memoria perché consapevolezza della necessità di tessere le forme per dare a vedere l’esperienza, costruendo la conoscenza dell’altro e del passato da condividere.
Si apre oggi a Bergamo il convegno dedicato a Primo Levi organizzato dall'Università degli studi di Bergamo e dall'Università degli studi Milano Bicocca.