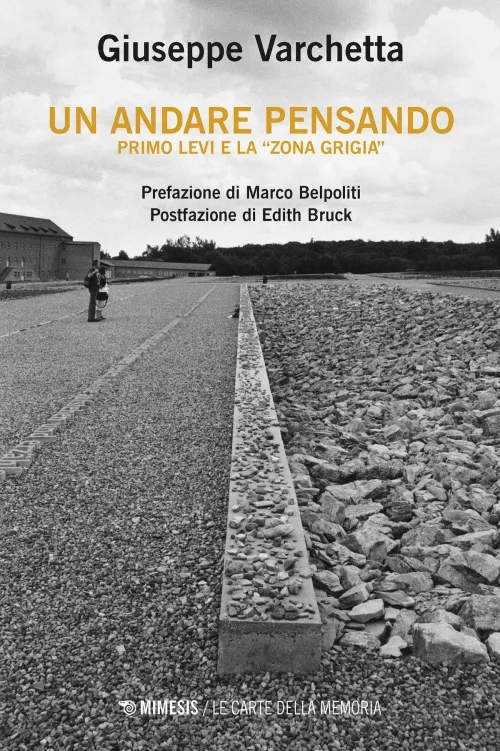Dentro e fuori di noi / La “zona grigia” come paesaggio dell’ambiguità
Ognuno ha esperienza della “zona grigia”, che ne sia consapevole o no. La portiamo in noi e nell’ambiguità delle nostre esistenze. Non siamo fatti di confini, ma di margini sfrangiati. Lacerate e laceranti sono le nostre relazioni. Approssimandoci ci facciamo almeno un po’ di male, anche quando siamo quasi vicini, quasi somiglianti e quasi d’accordo. Di più, di coincidere perfettamente non ci è dato. Allo stesso tempo quando scegliamo, quando cerchiamo di tirarci fuori dall’incertezza di una decisione qualsiasi, mettiamo a tacere una parte di noi che andrebbe in direzione contraria. Viviamo l’incertezza come una nemica da rimuovere, eppure è nostra sodale compagna di strada. Negli spasimi dell’anima in cui ci trascina l’amore, persino lì, il dionisiaco turba la pretesa apollinea della certezza, e ci impegniamo a ricomporre la dimensione che vogliamo prevalente. Se non fossimo continuamente divenienti, forse allora saremmo coincidenti con noi stessi e, chissà, non lo sapremo mai, avremmo conquistato una condizione di beatitudine, che non solo non è di questo mondo e di queste nostre vite, ma forse conterrebbe quello che, in I fiori del male, Baudelaire chiama il vizio più immondo: la noia.
“Senza troppo agitarsi né gridare,
vorrebbe della terra non lasciar che rovine
e sbadigliando inghiottirebbe il mondo:
è la Noia! Occhio greve d’un pianto involontario,
fuma la pipa, sogna impiccagioni…”
Intersoggettivi e allo stesso tempo irriducibili l’uno all’altro, viviamo il dramma esistenziale che come pochi altri Anna Achmatova, in La Corsa del tempo, ha messo in impareggiabili versi:
“C’è nel contatto umano un limite fatale,
non lo varca né amore né passione,
pur se in muto spavento si fondono le labbra
e il cuore si dilacera d’amore.
Perfino l’amicizia vi è impotente,
e anni d’alta, fiammeggiante gioia,
quando libera è l’anima ed estranea
allo struggersi lento del piacere”.
Né l’amore, né l’amicizia neutralizzano l’irriducibilità e l’unicità di ognuno di noi, anche se oggi sappiamo che è un paradosso concepire un io senza un noi. Quel paradosso ne contiene un altro: l’unicità di ogni “io” che pur nel “noi si forma”. Giuseppe Varchetta all’unicità aveva dedicato un altro libro, oltre che un’intera vita di studi e lavoro. Lo aveva fatto con Telmo Pievani, quando nel 1999 avevano pubblicato, appunto, Il management dell’unicità, da Guerini e associati, Milano.
Ora Varchetta porta a compimento un percorso dialogico con Primo Levi, su un tema che dice bene la complessità della questione indecidibile tra l’essere noi animali relazionali e allo stesso tempo tutti unici. Lo fa con un libro introdotto da Marco Belpoliti che di Levi ha fatto una delle ragioni fondamentali del suo cercare, e con la postfazione di Edith Bruck: Un andare pensando. Primo Levi e la “zona grigia”, Mimesis Edizioni, Milano-Udine 2019. Un certo numero di fotografie, una delle passioni di Varchetta, corredano il libro. Chi aveva forse trovato una chiave per tentare di capirci qualcosa è un nostro comune maestro che non volle mai essere chiamato maestro: Luigi Pagliarani. Col suo linguaggio immediato e chiaro Pagliarani ricordava sempre che abbiamo tutti l’ombelico, ovvero che siamo tutti figli.
Quella evidenza fisiologica fa di noi esseri che sono stati dipendenti, avendo trascorso nove mesi nel corpo di un’altra mammifera. Il fatto più fondativo e fondamentale tra tutti i fatti. Eppure già in quella situazione, nel momento di venire al mondo, si consuma il primo dramma del divenire autonomi essendo e rimanendo a lungo dipendenti. Ovvero, rimanendo in una certa misura per sempre dipendenti. Nello spazio esistenziale tra autonomia e dipendenza, che è spazio interno ed esterno allo stesso tempo, noi ci individuiamo. In quella transeunte ricerca di noi, tra solitudine e invasività da parte degli altri, tra l’altro necessario per noi e il bisogno di una pelle che ci contenga, si crea un gioco senza fine e senza confine: si crea e ricrea una zona che non è bianca e non è nera, non coincide con l’io né con l’altro, ma è tale da mettere in dubbio l’esistenza del primo e del secondo senza quella zona. È la zona grigia.
Non è solo grigia del grigiore dei giorni tetri; non è neppure la zona grigia del grigio perla dei tempi luminosi; è grigia perché di incertezza vive l’uomo e imperfetta è la sua condizione. Come scrive Primo Levi, ripreso con cura e attenzione duratura nel tempo da Varchetta: “È difficile giudicare i limiti della compromissione”. Siamo tutti compromessi, abitanti, in tempi e misura diversi, di quella zona. L’ambiguità, che è la nostra condizione, non nel senso che siamo equivoci e poco affidabili, forse anche quello, ma nel senso che siamo angeli e demoni allo stesso tempo e transitiamo lungo la scala in cui ci capita di vivere la nostra esistenza. In quel transitare ci individuiamo e facciamo i nostri tentativi di fissarci in qualche definizione identitaria che sfuma e scolora nel momento stesso della sua formulazione.
Prendiamo il caso della bontà e della cattiveria, dell’essere buoni e cattivi.
Pare che siamo tra le specie meno aggressive, ma basta metterci in gruppo e sviluppiamo capacità distruttive e atrocità impressionanti. Riconoscere questo ci inquieta e a sentir parlare di piacere della guerra ci viene da girarci dall’altra parte. Come specie umana ci siamo auto-addomesticati, ci siamo ammansiti da soli e siamo divenuti capaci di cooperazione. Eppure siamo capaci di atrocità evidenti e continue. Socialità e aggressività distruttiva nella specie umana sono due facce della stessa medaglia.
La rilevanza dello studio appassionato e attento contenuto nel libro di Varchetta emerge proprio a questo livello: possiamo cooperare per il bene o per il male e le predisposizioni duali non sono incise in alcuna determinazione genetica ineluttabile. Sono potenzialità attivate in un senso o in un altro a seconda degli stimoli culturali e delle forme di vita che ci diamo, in base ai contesti sociali e organizzativi in cui si esprime la nostra esperienza. Abitiamo la zona grigia del divenire, in base alle contingenze del nostro cammino esistenziale e a seconda di quel che ci si para innanzi.
Allora cercare di comprendere la complessità della nostra esperienza nelle relazioni con gli altri impone di non semplificare. Soprattutto quando le relazioni sono relazioni asimmetriche e di potere. Ora, è difficile che le relazioni, qualsiasi relazione, non siano asimmetriche e non implichino una qualche forma di esercizio del potere. Quell’esercizio, nonostante la nostra propensione a ridurre a schemi e a semplificare, non può essere ridotto alla logica amico-nemico. Dopo Foucault, verrebbe da dire, quella riduzione non è più consentita: il potere ha una sua microfisica e si esprime e manifesta in forme molto articolate e differenziate. Non è descrivibile con la semplificazione dominanti-dominati, soprattutto dopo la testimonianza letteraria, storica e poetica di Primo Levi, che scrive, in I sommersi e i salvati:
“È una zona grigia, dai confini mal definiti, che insieme separa e congiunge i due campi dei padroni e dei servi. Possiede una struttura interna incredibilmente complicata, ed alberga in sé quanto basta per confondere il nostro bisogno di giudicare” [p. 29].
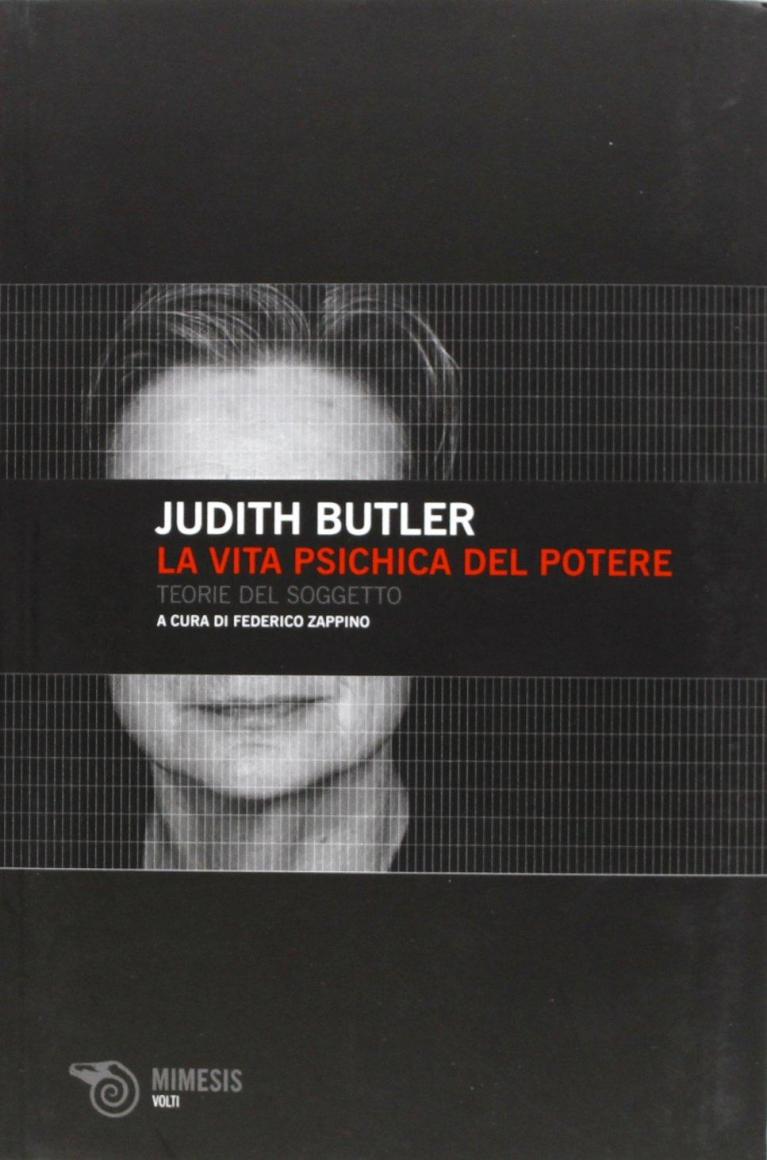
La disposizione a collaborare col potere da parte degli oppressi, che è tanto più elevata quanto più il potere è oppressivo, non è solo una delle altre facce dell’ambiguità, ma l’evidenza che “il potere esiste in tutte le varietà dell’organizzazione sociale umana, più o meno controllato, usurpato, investito dall’alto o riconosciuto dal basso, assegnato per merito o per solidarietà cooperativa o per sangue o per censo: è verosimile che una certa misura di dominio dell’uomo sull’uomo sia inscritta nel nostro patrimonio genetico di animali gregari. Non è dimostrato che il potere sia intrinsecamente nocivo alla collettività” [p. 32]. Quest’ultima frase di Levi assume un’importanza difficilmente sopravvalutabile. Il potere e la sua connessione strettissima con il senso del possibile sono l’alveo in cui la zona grigia emerge e prende forma. Se vuoi fare qualcosa hai bisogno dell’altro, anche se sei una delle forme di potere tra le più strutturate e totali che si conoscano, il potere nazista e quello dei campi di sterminio, hai bisogno dei prigionieri e delle popolazioni sottomesse. Se sei sottomesso e vuoi sopravvivere hai bisogno di chi ti sottomette e manifesti la tua disposizione a collaborare.
Come ha mirabilmente sostenuto, in proposito, Judith Butler in La vita psichica del potere, in un capitolo che si intitola Dentro l’ambiguità. Un contributo di psicologia politica: “Nessun soggetto emerge senza un attaccamento appassionato nei confronti di coloro dai quali dipende in maniera fondamentale”.
Per Varchetta l’organizzazione, quella particolare forma di vita nelle cui diverse manifestazioni noi trascorriamo le nostre esistenze, è sempre stata espressione dei mondi interni e delle relazioni di coloro che la abitano e la creano, spesso nonostante se stessi e inconsapevolmente. “Nessuno vuole la torre, eppure la torre viene costruita”, ha scritto Friedrich Dürrenmatt in Un angelo scende a Babilonia.
Non solo, ma l’organizzazione come esito mobile e dinamico delle azioni e delle relazioni delle donne e degli uomini è sempre stata, nelle sue ricerche e nella sua pratica professionale, per Varchetta, solo in parte manifesta. Nella sua parte latente, per così dire nascosta, nella sua parte profonda, dove alberga l’imperscrutabile, per quanto sia clinico, disposto a chinarsi, l’atteggiamento di chi la osserva, l’organizzazione almeno in parte si cela, perché è fatta dell’incerto procedere delle attese e delle delusioni, dei desideri e delle frustrazioni, degli attacchi e delle difese, delle collusioni e delle complicità, delle paure e degli atti eroici, dell’aggressività e della solidarietà di chi ci vive.
E chi ci vive non vorrebbe essere lì ogni giorno, ma allo stesso tempo se non potesse essere lì non saprebbe dove andare, cosa fare e, soprattutto chi è, almeno in buona misura. In una tale fittissima rete di relazioni le zone di incertezza, le zone grigie, lungi dall’essere lo sfondo della scena si propongono, alfine, come la figura. Se si aggiunge che sempre più veniamo riconoscendo di essere intersoggettivi e di divenire quello che siamo a partire da quel che ci precede e dalle relazioni in cui ci costituiamo, potremmo arrivare a sostenere l’ipotesi che a seconda delle caratteristiche e della natura delle zone grigie, emerge il tasso di vivibilità delle organizzazioni.
Seguendo la pista unica e straordinaria di Primo Levi, a cui aveva già dedicato un suo precedente libro, Ascoltando Primo Levi, Guerini e associati, Milano 1991, Varchetta instaura un’attività di scavo per approfondire la comprensione della conoscenza e della testimonianza esistenziale nella complessità della vita. L’interrogazione incessante di Levi è assunta da Varchetta come uno stile d’esistenza che, così come ha caratterizzato la vita del grande scrittore, testimone della Shoah, rappresenta una guida per comprendere chi siamo come esseri umani. Conoscere, comprendere, del resto non è un processo neutro che lasci al sicuro il mondo interno dell’osservatore. Scrive Varchetta:
“Come pensa e come lavora la mente umana? Per processi lineari? È probabile che questo sia il processo di ricerca quando l’oggetto è “là fuori”, nel mondo fisico, e pur richiedendo tale processo di ricerca una propensione a reggere l’ansia scaturente dalla creatività ad esso connessa, non scavi troppo profondamente nella struttura psichica dell’attore.
È meno probabile che questo processo si ripeta quando i temi siano esperienze di vita sofferta e, come nel caso di Levi, memorie dal regno dell’orrore, abitato dai “sommersi”. In questi casi con alta probabilità la mente lavora per intermittenze, un vedere a occhi aperti e alternativamente a occhi chiusi” [pp. 28-29].
Come appare evidente l’ambiguità non riguarda solo, per così dire, l’oggetto da conoscere ma anche il soggetto conoscente, il suo stile conoscitivo e la sua memoria, come del resto Varchetta aveva mostrato in un suo importante precedente libro, L’ambiguità organizzativa, Guerini e associati, Milano 2007.
L’ambiguità della zona grigia, o meglio la zona grigia come paesaggio dell’ambiguità è, secondo Varchetta un approdo della continuità dell’elaborazione narrativa e della poetica di Primo Levi. Varchetta riconosce “un approdare progressivo della riflessione di Primo Levi alla “zona grigia”, alla testimonianza del fondo ambiguo del sentire umano e della irriducibile molteplicità dei punti di vista di fronte alla fenomenologia di un esistere singolo e collettivo” [p. 34].
Varchetta mobilita la prospettiva psicoanalitica e la sfida della complessità, non solo per comprendere il percorso di Levi, ma per comprendere come la zona grigia sia un costrutto per comprendere alcuni dei più importanti aspetti della vicenda umana, come il lavoro e l’azione cooperante, con tutte le loro implicazioni in termini di vincoli e possibilità per l’espressione umana.
Alla trattazione della zona grigia è dedicata la parte principale del libro. Due sono, tra i tanti, i punti che è importante sottolineare. Il primo riguarda l’attenzione analitica a evitare il rischio di “una posizione assolutoria della colpa individuale e collettiva circa il male impensabile perpetrato nel lager e in quello di un possibile, abietto agire futuro sempre in agguato” [p. 79]. Il secondo mostra, in accordo con Giorgio Agamben, come l’opera di Levi sottolinea come nel lager ogni possibilità di creare un diaframma netto tra l’umano e l’inumano sia perduta. L’umano, conseguentemente può essere “infinitamente disumanizzato”.
Difficile non pensare al nostro presente, che in molteplici manifestazioni smentisce l’unicità dei lager nazisti e ci pone dinanzi a fenomeni di disumanizzazione e di distruttività, la cui lettura necessita di categorie interpretative in parte indicate da Levi e in parte da mettere a punto.
Nel capitolo riguardante la zona grigia e l’esperienza organizzativa Varchetta dà fondo alla sua lunga tradizione di ricerca e si concentra su una efficace lettura delle relazioni organizzative come emergenti dalla elaborazione delle ansie e dell’incertezza, dalla capacità negativa e dall’apprendimento situato. Esperienze strettamente collegate alla zona grigia che ne caratterizza le manifestazioni. È l’incertezza la fonte originaria della ricerca dell’altro e della disposizione alla cooperazione organizzata; così come “nell’apprendere ad apprendere, la possibilità di agire il linguaggio dell’effettività, ossia il linguaggio che prelude al cambiamento, passerebbe attraverso la capacità di persistere nel sopportare l’incertezza, il mistero, il dubbio, without any irritable reaching after fact and reason” [p. 99].
Qui, molto opportunamente Varchetta ricorre a un’intuizione di Wilfred R. Bion, che aveva colto la rilevanza per l’esperienza umana di una riflessione epistolare del poeta John Keats, a proposito della capacità negativa, di quella capacità di sostare nell’attesa della generatività delle relazioni e degli eventi. È stato Luigi Pagliarani ad amplificare ed estendere quella intuizione connettendola al costrutto della mancanza come possibile condizione generativa, in base a una sua efficace elaborazione. Zone grigie interne alla nostra condizione umana e ai contesti relazionali in cui trascorrono le nostre vite, di esseri attraversati dal non coincidere mai con noi stessi e dal tendere sempre all’oltre rispetto all’esistente.
Le domande che si aprono leggendo l’incessante preoccupazione di Varchetta nell’evidenziare la zona grigia e le sue implicazioni, sono davvero tante e riportano continuamente al significato stesso di essere umani. Una questione tra le tante conviene qui evidenziare: sull’essere la zona grigia uno spazio intermedio, sembra opportuno approfondire la ricerca e esercitare qualche dubbio. Abbiamo sempre maggiori evidenze della nostra costitutiva intersoggettività: è dal noi che sembra evidente nasca l’io, la cui consistenza come costrutto è sempre più corrosa dalle risultanze di ricerca. La relazione è incarnata e pre-intenzionale e pre-linguistica.
L’ambiguità della zona grigia probabilmente precede l’espressione individuale e concerne l’individuazione, riguarda l’indivisibile che ci accomuna e a sua volta ci precede. C’è un indivisibile costitutivo che genera noi “dividui” intersoggettivi ancor prima di nascere.
Possiamo allora sostenere che l’ambiguità non interviene, perché prima ancora noi siamo l’ambiguità. L’ambiguità, forse, non è orizzontale, spaziale.
L’ambiguità si propone come quantistico-temporale, fonda le relazioni tra gli enti, nella sua verticalità. Il paesaggio del vivente è ambiguità e precede e costituisce le zone grigie in cui emergiamo e diveniamo.
È questo appena accennato un approfondimento necessario, alla cui messa a punto il libro di Giuseppe Varchetta contribuisce e sollecita.
Oggi alle ore 18 alla Libreria Linea d'Ombra Marco Belpoliti, Raoul Nacamulli e Giuseppe Varchetta presentano il libro di Giuseppe Varchetta Un andare pensando. La zona grigia di Primo Levi, Mimesis 2019.