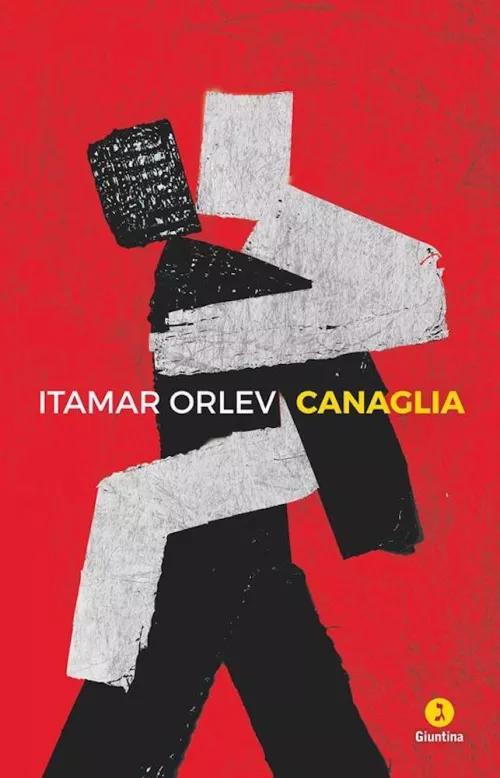Un libro di Itamar Orlev / Padre canaglia
Molti anni fa Abraham Yehoshua mi disse: “Non si dovrebbe scrivere romanzi prima dei quarant’anni, al massimo racconti”.
Il grande autore israeliano con quella frase non pretendeva di imporre un limite anagrafico ai romanzieri. Del resto sapeva bene che la storia della letteratura è piena di ventenni e trentenni che hanno prodotto dei capolavori (Thomas Mann, quando pubblicò I Buddenbrook, aveva ventisei anni). Piuttosto intendeva che a quell’età ormai si è conosciuto la vita abbastanza da potersi cimentare nella difficile arte del romanzo, la quale, fra tutte le arti, è quella che più pretende un’acuta comprensione della natura umana.
Mi sono ricordato di quelle parole leggendo le note biografiche di Itamar Orlev, nato nel 1975 a Gerusalemme, autore di racconti apparsi sulle pagine delle più importanti riviste letterarie israeliane, di un’opera teatrale e di un romanzo pubblicato, appunto, nel 2015, quando Orlev, compiendo quarant’anni esatti, è diventato – secondo lo speciale canone di Yehoshua – “maggiorenne”.
Il romanzo in questione era Bandit (Premio Sapir 2015 in Israele e Prix du Meilleur Roman des lecteurs Points 2020 in Francia) che arriva ora in Italia col titolo Canaglia (Giuntina, traduzione di Silvia Pin). Un’opera grandiosa che ha per protagonista un uomo ripugnante e magnifico, un personaggio letterario che sembra un puro distillato della storia del Novecento.
Il personaggio in questione è Stefan Zagurski, un vecchio dal carattere impossibile, distrutto nel corpo e nei sentimenti, che giace in un ospizio per eroi di guerra a Varsavia, consumato dalla vodka e assediato dai mostri del passato. Siamo nel 1988 e la storia è narrata dal figlio Tadek che all’inizio conosciamo in preda all’avvilimento per un sogno infranto, quello di poter vivere da scrittore, e all’angoscia derivata da un matrimonio appena deragliato per colpa delle sue insolvenze di marito e di padre. Tadek vive a Gerusalemme e non vede Stefan da vent’anni, le due sorelle e il fratello sono dispersi nel mondo e la madre, a sessantasei anni, veste elegantemente quando è in preda al cattivo umore e fa ancora gli occhi dolci ai ragazzi, come a pretendere un risarcimento tardivo per tutto ciò che negli anni la vita le ha sottratto.
Cresciuto in Polonia con la famiglia in una fattoria agricola statale, come i kolchoz sovietici (in Polonia si chiamavano PGR), Tadek ha ricordi del padre attaccabrighe, lussurioso, un uomo temuto da tutti che non risparmiava violenze a nessuno, in casa e fuori, e che quando la moglie decide di emigrare con i quattro figli in Israele per sfuggire alla miseria della Polonia socialista, lui a malapena va a salutarli alla stazione.
Approfittando della progressiva riapertura dei confini dei paesi del blocco orientale, Tadek decide di andare a trovare il padre, temendo che al vecchio ormai non manchi molto a morire. Raggiunto l’ospizio a Varsavia, Tadek porta in regalo a Stefan alcune foto che lo ritraggono con la propria famiglia, senza dirgli che quella famiglia in realtà non esiste più. Nonostante il fisico distrutto dall’alcolismo in fase terminale, Stefan non tiene a freno la sua esuberanza, pur lasciandosi andare a furiosi attacchi di malinconia e accenni alle cose orribili successe in tempo di guerra.
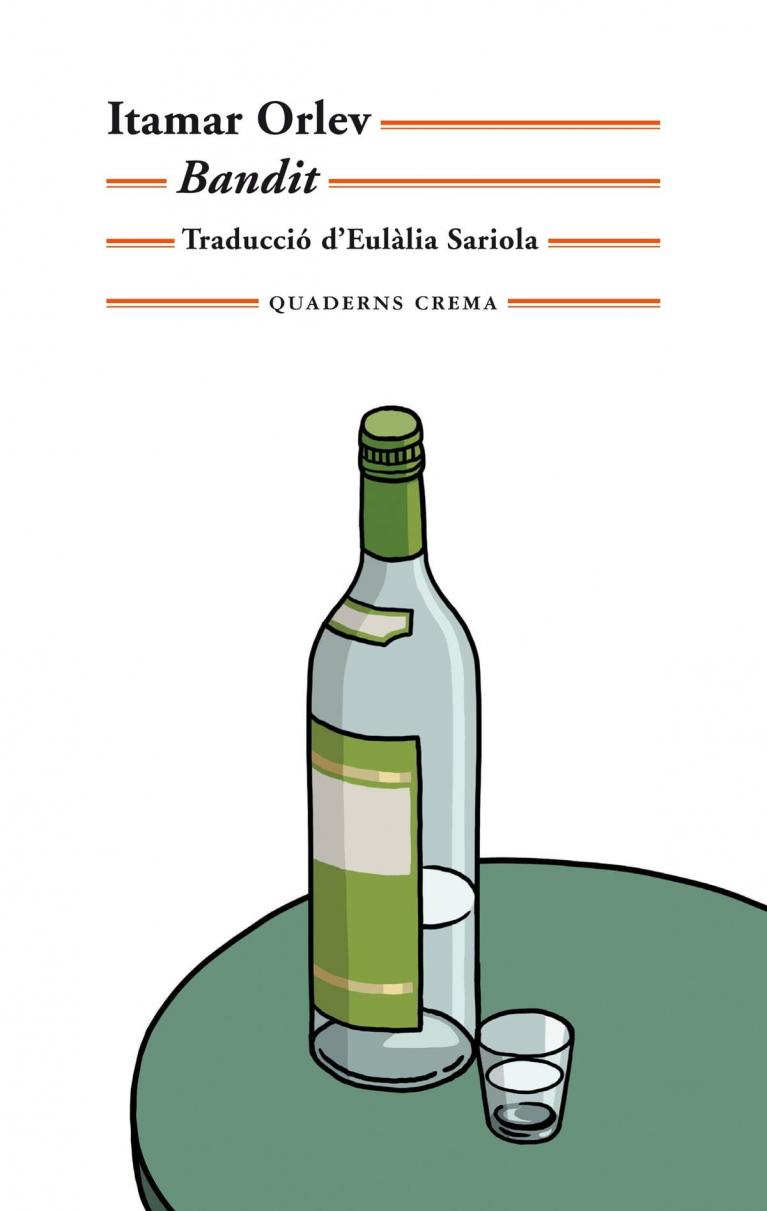
La guerra combattuta nei Battaglioni Contadini aggregati all’Armia Krajowa, quello che fu il principale movimento di resistenza nella Polonia occupata dalla Germania nazista. Stefan porta addosso le cicatrici lasciate dalle torture della Gestapo e quelle invisibili delle atrocità che ha commesso a sua volta. E quando Tadek gli chiede conto di quante persone abbia ucciso, Stefan rimase assorto e risponde: “Ho ucciso abbastanza. A un certo punto ho smesso di contare”.
È l’incontro tra due fallimenti, l’uno discendente dell’altro: “Il figlio di merda del padre di merda siede tra le macerie della scenografia che hai costruito con troppo talento”, dice a un certo punto Tadek alla dolce Lidia, la cameriera della pensione in cui alloggia a Varsavia con la quale trova il tempo di improvvisare una fugace storia d’amore (mi piace immaginare che questa Lidia sia un omaggio a un’altra Lidia della letteratura, anch’essa cameriera d’albergo, nonché amante del medico protagonista del romanzo L’anno della morte di Ricardo Reis di José Saramago).
Ciò che il figlio e il padre devono intraprendere però è un viaggio attraverso il quale tentare una doppia riconciliazione: l’uno con l’altro, e – ciascuno – fra sé e il proprio passato. Un viaggio in una Polonia mesta e poverissima, colta al tramonto dell’era sovietica, in cui non si trovano più neppure i fiammiferi perché i russi si sono presi tutto il legno per far andare le loro industrie, fra mezzi di fortuna, visite improvvisate a parenti e a vecchi amici, racconti sempre più atroci degli orrori della Seconda guerra mondiale.
Una riconciliazione che si rivela impossibile, a meno che non si contempli la possibilità di tenere tutto dentro e di non scartare niente, il bene e il male, il miele e il vomito. “Volevo bene al padre che odiavo”, dice Tadek a un certo punto osservando in treno il viso assorto del vecchio Stefan.
Intorno alla storia di questo colossale farabutto, di questa canaglia, si dipana un romanzo spietato e al contempo pieno di pietà, tetro e luminoso. Orlev riesce a toccare con sorprendente maestria tutti i registri dell’animo umano, sia emotivi che razionali, alternando pagine comiche ad altre tragiche e immensamente malinconiche, con una scrittura paziente e lieve, ma sempre capace di scartare all’improvviso verso l’assoluto.