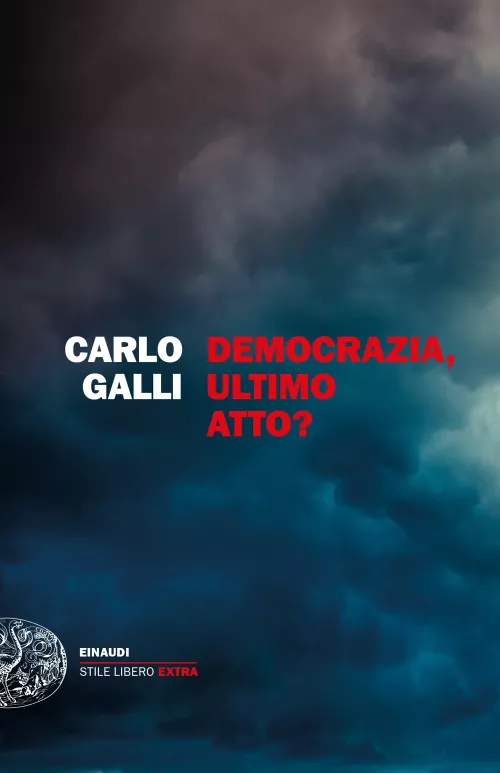Democrazia, ultimo atto
È possibile immaginare una politica che non sia quella definita da Voltaire come il mezzo attraverso il quale persone senza morale comandano su persone senza memoria; o da Carl Schmitt come essenzialmente il rapporto amico/nemico? Siamo capaci di definire una democrazia politica dopo che il mercato e poi la tecnica si sono sovrapposte alla democrazia e allo Stato e alla politica come governo della polis, escludendo quella politica che invece, ponendosi come tecnica regia (Platone) tutte le altre tecniche dovrebbe governare e orientare al bene collettivo?
Populismi, democrature, postdemocrazie, sovranismi, democrazie illiberali, trumpismi, orbanismi, melonismi-salvinismi e neo/post-fascismi, oligarchie vecchie e nuove, politiche emergenziali e stati d’eccezione, guerra, voglia di autorità/autoritarismo – e su tutto il totalitarismo del tecno-capitalismo e della moderna razionalità strumentale: tutti sintomi/patologie di una democrazia malata.
Siamo dunque all’ultimo atto della democrazia, come ci interroga la domanda posta da Carlo Galli – uno dei più lucidi tra i filosofi politici italiani, tra i pochissimi impegnati ancora a fare pensiero critico – come titolo del suo nuovo libro (Einaudi): Democrazia, ultimo atto?
La storia della democrazia e la diagnosi della sua malattia che narra Galli nei capitoli del suo libro, è perfetta – avendo per metodo “un incrocio di analisi dialettiche (per chiamare le contraddizioni con il loro nome…) e di spunti tratti dal pensiero negativo (per individuare le aporie, senza farne un’arma contro la democrazia”), recuperando il passato (“il grande rimosso della nostra cultura e il grande assente dal dibattito sulle sorti della democrazia”) – ma preferiamo andare subito alle ultime pagine, dove Galli cerca di rispondere alla domanda del titolo e dice che no, non siamo all’ultimo atto della democrazia, anche se è a rischio, e che può essere portata a nuova vita attraverso un forte investimento politico.
Scrive Galli – sempre ricordandoci che la democrazia, come la libertà, non è mai garantita, che è sempre imperfetta, che sempre si basa su un equilibrio instabile (“l’aporia fondamentale della modernità è la sua instabilità”), che sempre occorre farne manutenzione attraverso un pensiero che non sia semplificante (a questo pensano la tecnica e gli algoritmi/IA, il populismo/sovranismo), ma complesso e consapevole. E “la critica – l’autocritica – è la prima àncora di salvezza delle democrazie; che hanno il loro principale nemico non nelle autocrazie esterne, né nelle ideologie anti-democratiche, ma nella mancata riflessione su se stesse”. Un dovere, quello della critica, del realismo critico, “che ne porti in salvo l’orientamento emancipativo. Appunto democratico”.
Per fare questo “non serve ricucinare le ricette del passato – anche della liberaldemocrazia e della socialdemocrazia, che sono crollate sotto le proprie contraddizioni – se non per ricordare che l’obiettivo anche della democrazia politica sarà, in modalità nuove, far coesistere un transitorio equilibrio fra conflitto e forma, fra politico e istituzione, fra libertà e diritto”. Con un popolo – non quello del populismo o del sovranismo – “che rivendica la propria posizione di titolare della legittimità: che non vuole essere ‘neo-plebe’, ma iniziatore di una azione politica, innescata da minoranze, com’è ovvio […]”, unendo istanze politiche e sociali concrete, “determinate e capaci di uno sguardo che vada al di là della mera affermazione delle identità, perché solo “il potere dell’unità politica è in grado di indurre trasformazioni sistemiche emancipative”.
E dunque, quel che più importa – per evitare di aggravare ulteriormente i processi di spoliticizzazione e di tecnicizzazione (un’altra forma di spoliticizzazione) – è ricordare, è prendere consapevolezza “che la soluzione non sta in ‘più tecnica’, in ‘più emergenza’, in ‘più guerra’, ma in ‘più politica’: democratica, s’intende. Una politica che nasca da un sapere critico-pratico, non da una improvvisazione populista”. E quindi e ancora – e lo sottolineiamo di nuovo, concordando totalmente con Galli – “solo l’incessante opera della critica è la dimensione in cui la speranza della democrazia può oggi sopravvivere: e ciò significa l’esigenza, tra l’altro, di una nuova stagione di impegno politico degli intellettuali (quanto verosimile, e quanto probabile, non è facile sapere)”. Mentre “sotto il profilo pratico, in assenza di rivoluzioni per mancanza di grandi idee e di robuste energie […] si può solo ipotizzare che forse un giorno qualcuno commetterà un errore troppo grande e si aprirà quindi una lacuna nel sistema; che forse si produrrà un evento che offrirà un varco in cui potranno entrare forze di liberazione, nelle quali confluiscano i rivoli delle lotte e dei saperi che oggi, pur sparsi, pur incerti, si muovono nella società; forze capaci di guardare in faccia – senza pretendere di ‘superarle’ in un unico ‘atto salvifico’ – le opacità che salgono dal profondo e di non lasciarle al governo delle oligarchie postdemocratiche”. Forse, le potenze sociali “oggi sopite o arrancanti proveranno, attraverso il conflitto” – sì, il conflitto sociale e politico – “a riprendere in mano i destini comuni, a riaffermare la forza della politica democratica, l’idea che è diritto e dovere dell’uomo vivere in un ordine in cui egli stesso sia, per quanto possibile, autore”. Autore dunque, e non attore che deve solo recitare secondo la sceneggiatura e nella scenografia pre-disposta dal tecno-capitalismo. E solo in questa possibilità, conclude Galli – che presuppone una capacità politica di voler cambiare le cose – e solo nella convinzione che si possa fare nuovamente pensiero critico e non solo pensiero unico come invece oggi, “è iscritto anche il dovere, o la scommessa di pensare e di agire come se l’ultimo atto della democrazia, che stiamo vivendo [la ‘democrazia’ liberista] non ne segni necessariamente la fine” definitiva.
Dalla conclusione, riprendiamo dall’inizio il libro di Galli. Un libro breve quanto a numero di pagine (137), ma urgente e necessario, quindi benvenuto. Libro che attraversa la storia e le crisi della democrazia moderna, analizza le sue forme e le sue istituzioni, le sue illusioni e le sue contraddizioni, le sue aporie, il suo universalismo solo retorico. E il rapporto difficile con i suoi elementi pure fondamentali, cioè libertà, uguaglianza e trasparenza: la democrazia cercando infatti di “far coesistere il potere con l’energia dell’autoaffermazione individuale e collettiva (la libertà), con l’intento di limitarne l’eccesso (l’uguaglianza), e con la finalità di istituire le strutture e le pratiche di una convivenza che le soggettività [individuali e collettive] possano riconoscere come opera propria”. Democrazie che oggi sono deficitarie “per eccessi opposti: per conformismi e automatismi, da una parte e per esasperazioni polemiche dall’altra; per spoliticizzazioni spurie e per politicizzazioni incongrue”. Cercare l’origine di questo deficit diventa allora essenziale per capire cosa è andato storto e per cercare soluzioni possibili.
Democrazia, dunque e soprattutto il Novecento, dove quattro sono state le rivoluzioni politiche avvenute: “comunismo, fascismo e la liberaldemocrazia” del compromesso socialdemocratico tra capitale e lavoro, del benessere e dei diritti sociali, dalla cui crisi si arriva, con gli anni ’80, alla “democrazia liberista, una rivoluzione passiva efficacissima”. Dove tutto è mercato e concorrenza, mercificazione e spoliticizzazione radicale e insieme compulsiva ricerca del successo individuale – il capitalismo intanto “imponendo le proprie logiche produttive, il disciplinamento radicale dell’antropologia” e divenendo una forma di vita, con individui isolati e privi di legame sociale ma connessi/integrati nel sistema. Dove l’impresa (oggi soprattutto tecnologica) – riprendendo Marx con Galli – “è libera volpe in libero pollaio”. E dove trionfa la globalizzazione (“il dilagare del capitalismo nel mondo”), con le sinistre che la “abbracciano entusiaste”, incapaci “di decifrare le contraddizioni socio-economiche” del sistema, prigioniere anch’esse “di uno schema produttivistico condiviso con il capitalismo” e tanto ingenue e arroganti “da pensare di poter piegare e governare a finalità progressiste le potenze del capitalismo scatenato”. Mentre la tecnica – la razionalità strumentale e positivistica – “si pone ora come l’Assoluto, l’incontrovertibile; è il Dio […] ai cui capricci ci pieghiamo, i cui misteri ci affascinano, la cui onnipotenza e onniscienza accogliamo con timore e speranza”. Eppure, anche questa è una narrazione della tecnica “che va criticamente approfondita” e la tecnica “è oggi più correttamente nominabile come tecno-capitalismo”. Quindi, fondamentale diventa “contrapporre un diverso potere al potere che si serve della tecnica”. Perché il lato politico della tecnica non è tanto la tecnocrazia, ma il fatto che “non l’AI imita noi, ma che molti di noi sono già come lei”.
Ora anche la democrazia liberista è in crisi. Ma questo non genera ancora una riflessione politica e una ricerca di alternative, semmai “una passività sistemica”. Mentre sullo Stato prevale il deep state, “l’oscuro, opaco, segreto del potere politico mescolato a quello economico” (altro che trasparenza) e a quello mediatico (il “triedrio del potere”) e cresce la sfiducia nella democrazia davanti “all’enormità del disagio sociale”, con le sinistre che si pongono sì contro le destre, “ma non contro le cause strutturali” che producono il disagio e le destre. E invece, scrive Galli, “per cambiare rotta è necessario uscire dal paradigma economico dominante e dalle sue intrinseche contraddizioni”. Servirebbe “un salto – politico – di qualità e di consapevolezza” – e non possiamo che essere d’accordo.