Speciale
Non è solo poetica / Cercando un’economia per gli Appennini
L’Italia profonda è espressione con cui significhiamo i sentimenti, i comportamenti, gli umori, “la pancia” degli Italiani che la modernità non riesce a comprendere; persone e genti che pur vivendo il presente ne sono in fondo solo sfiorate rimanendo attaccate alle inerzie, ai valori, alle abitudini, ai pensieri, alle tradizioni di un passato indefinito che però tutto trattiene.
Poi, la stessa espressione è anche sinonimo di aree interne, identità geografica vaga quanto evidente, almeno quando comprende luoghi lontani dalle coste, dalle grandi città, facilmente coincidenti con le provincie più sperdute o con ogni vallata di montagna che sia rimasta lontana dal turismo di massa.
In pratica gli Appennini ci sono dentro tutti.
L’Italia profonda è appunto il titolo di un piccolo libro appena edito da Gog, giovane casa editrice romana. È un breve dialogo intervista con Franco Arminio e Giovanni Lindo Ferretti che rispondono su cosa negli Appennini sia la vita in montagna, su cosa resti, sui simboli, sui luoghi, sul lavoro dell’uomo, sul tempo visto da là e da lassù, sulla parola e la poesia intorno ai luoghi e alle persone...
Sguardi, quelli di Arminio e Ferretti, diversi nella sensibilità e nelle propensioni personali, ma accomunati dalla cura di ciò che è e che resta, dal privilegio di poter osservare il creato da luoghi in cui questo è ancora possibile.
L’uno forse più attento alle diverse sfumature della concretezza del vivere, l’altro più sensibile alla ricerca del sacro e della fede.
Gli Appennini come luogo in cui poter osservare il creato dicevamo... privilegio di colti e di eremiti si direbbe ma certamente non solo.
Del resto, gli eremi, le abbazie, i conventi che storicamente hanno punteggiato la montagna appenninica forse rivelavano anche questo; luoghi di una montagna accessibile dove la vita si percepiva (e si percepisce) dentro la sacralità diffusa data dall’incontro tra l’uomo e la natura. Questo il tratto saliente di una montagna sempre possibile.
“Gli alberi che mi emozionano non sono quelli dei boschi ma quelli coltivati nei campi arati. Se proprio devo scegliere un simbolo scelgo questo. È un’emozione che mi arriva sempre, con la pioggia, col sole e ancora di più quando c’è la neve ... gli alberi mi sembrano presenze a cui posso fare affidamento” scrive Arminio. Oppure: ama la tua città, ama il tuo paese, questo è il primo comandamento nella civiltà della geografia in cui ogni cosa va sistemata con cura nel suo spazio: pensa al muso delle vacche, al cuore di una donna, agli occhi di un gatto”.
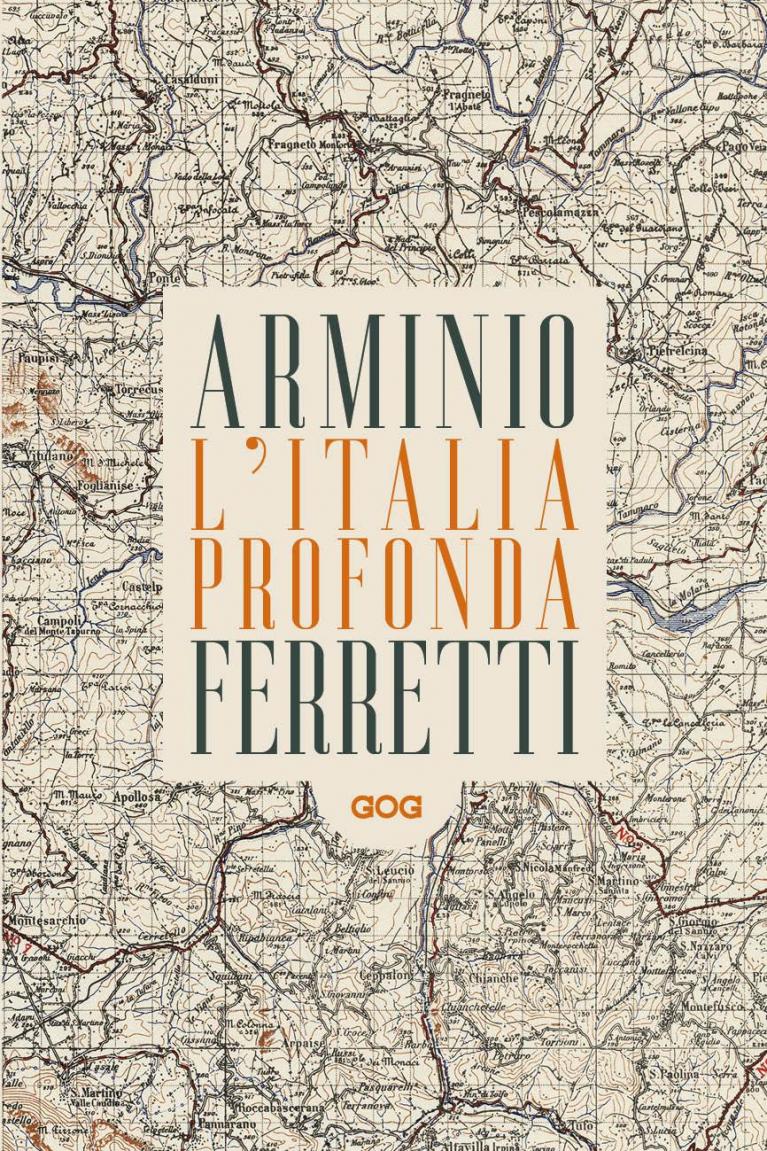
“Coltivando vane speranze ed espletando un dovere verso la creazione ho allevato ed addestrato sull’Appennino cavalli di nessuna utilità. Come farne a meno?”
“Se il cavallo è il mio simbolo del passato, e con diverse motivazioni, del presente, è il lupo a candidarsi a simbolo del futuro. Il lupo è tornato e ci guarda con occhi nuovi e stupiti”.
“... La città e i paesi, in questo perfettamente sovrapponibili, hanno dimenticato la vita vera: nascere diventa l’eccezione. Generazione senza generazione” scrive Ferretti.
L’incontro tra l’uomo e la natura si diceva... ma certamente oggi quell’incontro si è fatto più raro per il vuoto di umanità che quasi tutti gli Appennini vivono e che si percepisce quotidianamente lungo i milleduecento chilometri delle sue montagne. È infatti quel “vuoto”, soprattutto nell’Alpe, a renderci più prezioso l’uomo e il creato, condizione con cui tutti quelli che vivono quella montagna, fanno quotidianamente i conti. Ed è quel vuoto che sta rendendo gli Appennini un intero grande parco, una gigantesca riserva naturale, con o senza certificazione di parco, dalla quale l’uomo lentamente è bandito e dal quale si bandisce...
Del resto sono il paesaggio, i paesi, la natura ormai straripante e un’umanità sempre più scarna, sempre più stanca... questo l’orizzonte comune di tutto l’Appennino e di cui anche le pagine di Arminio e Ferretti ne sono un’altra lirica testimonianza.
Ma sembra che non una, due, mille poetiche possono bastare per l’Appennino – come per qualunque altro luogo – per la vita che è e che verrà...
Oltre ogni poetica infatti, il problema del vivere, del vivere cioè il presente, è sempre un problema economico, anzi è un problema demografico, è demografico ed economico, e ancora è economico e demografico, perché senza demografia non c’è nessuna economia e viceversa, non c’è, alla lunga, alcuna vita.
Difficile poi immaginare nel tempo un’economia sostenibile in quelle piccole comunità residuali e a loro modo quasi autosufficienti di cui si sta punteggiando l’Appennino, soprattutto l’Alpe o le vallate più profonde.
I monasteri medievali come modello concluso di piccole comunità colte e autosufficienti (se mai oggi fosse una suggestione e una tentazione dell’epoca web e dell’economia immateriale) sono irrimediabilmente lontani. Quelle comunità finché la storia gli è stata benevola, hanno goduto infatti di una demografia favorevole; a lungo, uno stuolo di adepti è stato pronto a rinfoltire e rinvigorire le fila di chi se ne andava.
Ancora la demografia dunque. Cosicché nel presente, assai poco vale trovare consolazione negli eventi – più o meno grandi più o meno piccoli – per far rivivere un giorno o una settimana un borgo o un paese degli Appennini; una illusione, forse anche una speranza certo, ma che alla fine resta come un misero argine alla mancanza di senso, all’aumento di disordine in cui quotidianamente sono immersi gli Appennini, proprio mentre gli altri giorni, tutti, raccontano l’estrema fragilità degli equilibri demografici; equilibri sempre precari e che in realtà sono già precipizi che sanno di desolazione. Come chiamarli diversamente quando i nuovi nati in un borgo, ogni anno sono uno, due... niente, o quando i paesi del sud inesorabilmente continuano a spopolarsi...?
Dunque che fare...?
Domanda impossibile quest’ultima e “madre di tutte le domande” per gli Appennini.
Forse, come premessa e prima di improbabili risposte occorrerebbe guardare come la parola paesaggio derivi da paese quasi a rimarcare come non possa esistere separazione tra natura e civiltà.
Paesaggio infatti ha la sua origine in paese, la cui etimologia muove dal latino volgare pagensem e dal più antico pagus vale a dire villaggio; così come ancora l’etimologia riporterebbe al latino paco, ovvero chiudo, serro, ma anche concludo un accordo tra parti.
Un paesaggio insomma sarebbe sempre in qualche modo paese e sempre in qualche modo “occhio civile”. È la conferma di come in ogni paesaggio vivo, la mano dell’uomo sia necessaria, è la conferma di come da quando esistono le città, e insieme ad esse “occhi urbani”, per tutti sia cambiato il modo di vivere e vedere la natura; la conferma cioè di come fin da Gerico, da
Ur, da Aleppo – piaccia o non piaccia – le città abbiano lentamente ridefinito il modo di vivere ma anche di guardare il mondo.
Ne sono consapevoli tutti quelli – come me – esuli di seconda generazione che periodicamente viaggiano dalla città in cui risiedono al borgo di provenienza. Transumanze minime in odor di modernità, pendolarismi esistenziali tra nostalgia, riconoscenza e inquietudine: condizione la cui non appartenenza a nessun luogo e nessuna patria è la cifra essenziale ma in cui è lo sguardo urbano ad arricchire di significati tutto quello che ancora è Appennino.
Del resto, oggi, nelle città, sulle coste o in pianura, dall'altro lato dove la storia ha tracciato le sue mutazioni, ognuno di noi conduce vite urbane, ormai le uniche possibili, aldilà di dove sia capitato di vivere. Ma in fondo, appartenenza o meno, non sono sempre occhi urbani quelli con cui ci guardiamo intorno anche quando abitiamo un paese, anche quando camminiamo il paese e il suo paesaggio...?
“Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via” scriveva Cesare Pavese. E ancora: “Un paese vuol dire ... sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”.
Eppure non è dalla poetica, non è certamente solo dalla poetica, che potranno trovare linfa nuova gli Appennini. Quella linfa potrà arrivare solo dal cercare e dal trovare la possibilità di un’economia che sia anche il tentativo di ricostruire una demografia, un’economia che possa ridare sangue alla vita che rimane e che verrà.
Anche quando poi saremo stanchi
Troveremo il modo per
Navigare nel buio... canta in Poetica Cesare Cremonini.
Sì, l’umanità scarna e stanca degli Appennini ha bisogno di un orientamento e di una qualche luce prima che sia troppo tardi, prima che tutto diventi un gigantesco inutile parco.
Chi avesse idee per rischiarare quel buio ne parli, le racconti, le gridi, ne scriva anche qui su queste pagine...







