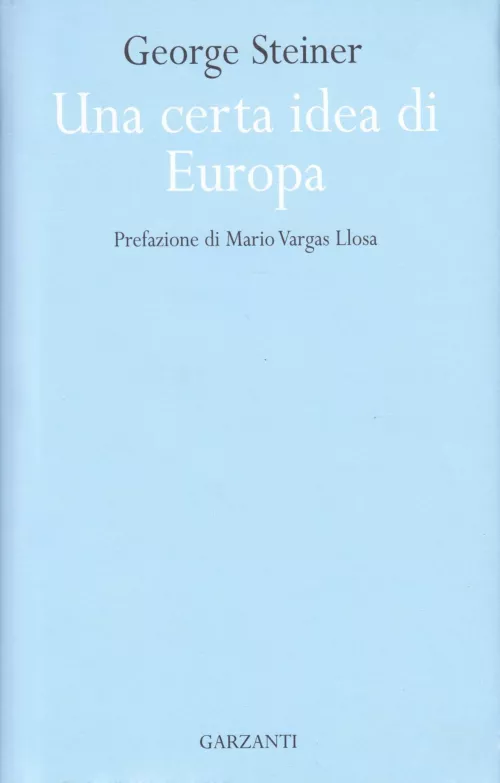Speciale
Appennini / Caffè. Conversazioni e solitudini
In quello straordinario piccolo libro che è Una certa idea di Europa di George Steiner, i caffè insieme alle vie con nomi propri, alle strade e ai territori percorribili a piedi (all’essere la sua civiltà “figlia” di Atene e Gerusalemme), sono un’idea di Europa aldilà di ogni confine, lingua, religione. Ne sono un tratto essenziale, elemento del panorama e del vivere comune in cui riconoscersi.
I caffè del resto sono differenti dai pub inglesi dove la birra, il cibo, gli orari, le luci e altro segnano una diversa convivialità e ancora i caffè appaiono profondamente estranei ai bar americani dove solitudini e super alcolici possono essere presenze abituali.
Non che nei bar-caffè italiani o europei non si bevano alcolici, ma almeno a partire dal Settecento, quando il caffè e il resto delle bevande nervine entrano nell’uso comune, almeno in molte città, una convivialità non alcolica diventa possibile, diventa disponibile un’alternativa al vino, alla birra, al sidro, all’idromele, ai liquori... insomma una alternativa all’alcol secondo lo stato sociale, il gusto, la geografia e le consuetudini.
È stata di fatto una rivoluzione silenziosa: la convivialita alcolica, disinibente ma anche sedativa secondo uso e dosi, è affiancata e sostituita da quella caffeinica, sostanzialmente stimolante ed eccitante. È cambiata la sostanza psicotropa e bere qualcosa in un caffè, progressivamente diventerà sinonimo di incontro, conversazione, discussione; una convivialità da cui è bandita l’ebbrezza e l’aggressività se non quella legata alle idee che la caffeina peraltro favorisce. Se i caffè sono nati nella Parigi della seconda metà del Seicento e poi in quella illuminista, l’attuale colazione e il caffè all’italiana la dicono lunga su un modo di intrattenerci e intrattenere il tempo che abbiamo regalato all’Europa.
Sì ha ragione Steiner, i caffè sono in Italia e in Europa un banale e straordinario luogo d’incontro, la continuazione della piazza del paese, un teatro quotidiano, un’abituale vetrina di umanità...

Una presenza e una funzione che, seppur per contrasto, ancor più si evidenzia in molte zone interne del nostro paese, sugli Appennini in particolare. Più che la presenza di una chiesa chiusa per sei giorni alla settimana, è l’assenza di un bar, di un caffè a negare l’esistenza di una comunità minima chiamata paese; senza un bar, un circolo, un caffè non può esserci paese. Quello il limite reale e sociale che definisce una comunità in grado di testimoniare una sua, per quanto fragile, vivacità quotidiana. Sono quei bar minimi che per grande parte del loro tempo “aspettano clienti”, sentinelle silenziose che si ravvivano a tratti quando poche persone si riuniscono intorno alle carte, alla stufa, al giornale, quasi sempre davanti a un caffè. Sono bar come quello descritti da Biamonti in un entroterra ligure aspro e abitato ormai soprattutto dalla memoria:
“ ...Il pomeriggio lo avrebbe passato al bar dell’olandese dove di solito lo aspettava Jean-Pierre. Era un bel posto su uno sperone quasi sempre dorato e ventoso...” (L’Angelo di Avrigue).
Sono caffè dove fuori restano terre che guardano il mare, rive in procinto di crollare e con sempre poca umanità intorno. Oppure, dappertutto in Italia dove la demografia e l’economia si sono ormai staccati dai luoghi, sono bar appesi a una strada o a una piazza, quasi sempre semi deserte e disadorne, caffè come altrettanti rifugi, tabernacoli laici che diventano sacri per la presenza, le risa, le parole, la compassione della rara umanità che ogni giorno vi transita.
Poi... scoprire come taverna e tabernacolo siano impastate dalla stessa etimologia può arrivare, magari seduti proprio in uno di quei caffè, come una stranita domanda su dove “il sacro” abbia intima origine e quanto l’umano possa coincidere con il divino.
Ma è nelle città o nei grandi paesi che, da soli o in compagnia, quella “vetrina di umanità” che sono i caffè “scintilla” oltre i vetri invernali così come attraverso i dehors d’estate.
Non deve essere un caso che i bar delle città abbiano spesso vista sulla folla.
 Roma, zona stazione Termini, © Gianfranco Gallucci
Roma, zona stazione Termini, © Gianfranco Gallucci
Più del panorama e dei monumenti, deve essere altro quello che da questi locali sembriamo cercare. Chi non ha provato la sensazione vaga quanto gratificante che dà il guardare la gente fuori da un caffè?
Ora credo di comprendere meglio l’attrazione per la città – probabilmente Roma – che Cesare Zavattini dichiara, in uno dei suoi primi libri, parlando dell’illusione che in una grande città ci si possa dimenticare di morire. “A destra intravidi una grande città che l'ombra stava abbandonando per dar posto al sole il quale avanzava come da un uscio che si apre adagio... io non voglio morire al mio paese, là tornerò terra mentre in mezzo alle grandi case della città potrei risvegliarmi un mattino". (“In aeroplano”, in Io sono il Diavolo, 1941)
Credo che sia soprattutto una questione di numero, nel senso che rispetto al piccolo paese, è il numero dei corpi a fare la vera differenza, la “biomassa umana” direbbero gli ecologi, vale a dire la concentrazione di umanità o infinite “copie di se stessi”, secondo altre percezioni e punti di vista. Nelle grandi città quel numero può essere infatti anche sedazione e stordimento, può essere una sorta di ipnosi se in quel numero che sembra non avere fine, in qualche modo ci sentiamo protetti.
Perché quel flusso di umanità che scorre davanti a un caffè ci dà sempre un qualche benessere, per quanto distratto: una folla che scorre con movimenti continui, per certi versi avvolgenti, alla lunga prevedibili quasi come le spira di un serpente.
Come se in quel flusso, in quelle “spira” ci fosse l’illusione che la vita possa non finire, perché finché dura quel movimento la menzogna resta nascosta: il numero ci ha sedato, ci ha convinto, il numero ha vinto.
Nei piccoli paesi non esistono caffè con vista sulla gente perché in paese non esiste folla che non siamo noi, quando la vita degli altri è anche la nostra.
Così il numero diventa sedazione impossibile dove non solo il re è nudo ma tutti sono nudi come lo è anche quella menzogna.
Così dai paesi si può fuggire anche senza la spinta di nessuna economia; in basso, le città regalano una consolazione e insieme una menzogna nelle quali ogni giorno ci avvolgiamo, delle quali ogni giorno ci nutriamo.