Abbandoni e diseguaglianze / Un'università classista
Mi capita da tempo di imbattermi, durante le sedute di laurea, in genitori o parenti che cercano un candidato che non c'è. Tante studentesse o studenti non hanno il coraggio di rivelare alle famiglie il reale stato del loro percorso accademico, costellato di esami non superati o mai sostenuti. Imprigionati dai recinti costruiti sulle bugie, questi giovani annunciano lauree che non avranno mai luogo e nel giorno della festa preferiscono scomparire, vivendo ansie indicibili e trasmettendole anche ai loro cari. Talvolta riappaiono a distanza di settimane e decidono di ricominciare a vivere rinunciando per sempre all’università. Solo in rari casi riprendono gli studi.
Nei giorni scorsi, uno di questi studenti ha deciso di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto a Napoli, nella sede del Dipartimento di Studi Umanistici della “Federico II”. Non lo conoscevo, forse lo avrò incontrato nei cortili o nei corridoi, avrà frequentato qualcuno dei miei corsi, ma per me era solo uno fra tanti. Alcuni di noi – amici, insegnanti – avranno cominciato a chiedersi cosa avrebbero potuto fare per lui. Forse molto, forse poco, forse niente. In realtà anche questa volta il tempo della tragedia lascerà spazio a quello della rimozione: torneremo alla vita di sempre, accompagnando con qualche singhiozzo gli inciampi quotidiani e le corse verso i traguardi che ci proponiamo di raggiungere.
Non sentiremo il bisogno di riflettere sul nodo, ormai costante, delle lauree fantasma e dei percorsi di studio che si perdono in vicoli ciechi (talvolta con conseguenze impensabili, come accade nel capolavoro di E. Carrère, L’Avversario). La nostra università è triste, ingiusta, vuota, inefficiente, nonostante gli sforzi individuali delle molte brave persone che ci vivono dentro. Pur essendo sempre più costosi, i corsi di laurea perdono da decenni quasi 8 studenti su 10. Gli atenei non hanno alloggi dignitosi, costringono gli iscritti a un logorante pendolarismo o a vivere in appartamenti fatiscenti con affitti insostenibili. Abbiamo parlato tanto – e a vuoto – della "didattica a distanza" durante l’epidemia di Covid-19, ma dimentichiamo che la stragrande maggioranza degli studenti è costretta a lavorare per sopravvivere, non ha mai frequentato un corso, non ha mai visto la faccia di un docente prima dell'esame, legge solo i libri di testo prima di sottoporsi ai giudizi dei titolari delle cattedre. Se chiedessimo a queste persone di scegliere fra la "dad" e il nulla, opterebbero per la prima soluzione, vorrebbero qualcuno con cui confrontarsi, vivere un'esperienza di condivisione o confronto, evitare di rimanere da soli.
Lottiamo tanto per il ritorno alla didattica accademica "in presenza", accogliamo con disappunto il successo delle cosiddette “università telematiche”, ma dovremmo almeno coltivare qualche dubbio. Ad esempio, abbiamo mai provato a chiedere a uno studente se preferisce partecipare a un corso on line o sedersi sul pavimento in un'aula da 500 posti, senza la possibilità di interloquire con l'insegnante o con chiunque altro? Le ricordo bene quelle lezioni, il loro effetto sul mio sguardo di studente, anche se sono trascorsi più di venti anni. Talvolta seguivo docenti di altissimo profilo che mi lasciavano tanto, ma quell'esperienza puramente trasmissiva (una persona che consuma il suo monologo di fronte a un pubblico) è oggi quasi completamente riproducibile su una qualsiasi piattaforma aperta come Youtube o Vimeo. Non posso apprezzare le energie che si captano solo dal vivo, ma posso comunque ascoltare attraverso uno schermo interi cicli di lezioni offerti dai più grandi studiosi del pianeta in diverse discipline, osservare le loro mappe concettuali, cogliere distintamente l'espressione dei loro volti, le sfumature delle loro voci, i loro movimenti, i gesti delle loro mani mentre cercano di sciogliere complessi nodi tematici. L'unico privilegio che mi è negato è il dialogo, l'interazione con gli altri studenti, la trasformazione del mio percorso di apprendimento in una forma di condivisione, capace di mettere in discussione le mie certezze, l'efficacia dei miei metodi, la solidità delle mie esposizioni, la fondatezza dei miei dubbi.
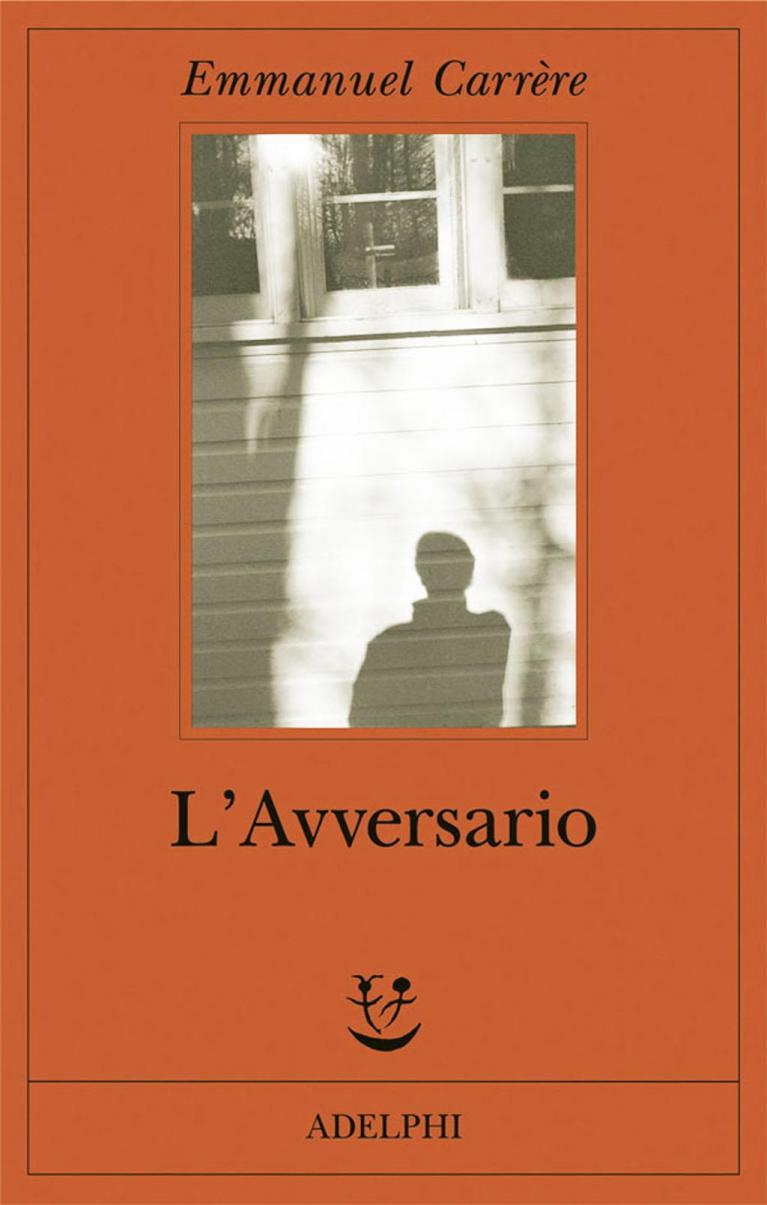
Ciò nonostante, non riesco a fare a meno di chiedermi se l'università italiana abbia mai soddisfatto questi desideri. La risposta è semplice: molto raramente. Ho conosciuto in profondità la relatrice e il correlatore della mia tesi di laurea, ma non gli altri docenti che lavoravano nel mio ateneo. Per me quegli studiosi – talvolta plurititolati e di fama internazionale – sono stati solo voci e volti, mentre io sono stato poco più di un numero, una sagoma parlante, una delle tantissime che affollavano aule sprovviste di attrezzature e poco spaziose. Ho conosciuto centinaia di colleghi, li ho visti correre da un corridoio all'altro, cercare con pazienza il modulo giusto da compilare (in un'epoca che non conosceva digitalizzazioni), ho scambiato con loro poche parole durante le interminabili attese per gli esami. Ma ne ho conosciuto anche tanti altri, la stragrande maggioranza in verità, che hanno abbandonato gli studi dopo il primo o il secondo anno.
La rinuncia agli studi è la triste costante della mia vita di studente e di quella di docente. Mi chiedo spesso, nei miei periodici grovigli di rimorsi, cosa riesco a dare alla vita di queste persone. Un contributo minimo, con ogni probabilità. Come tanti miei colleghi, mi sforzo di conferire un senso alle attività didattiche, di organizzare attività “extracurricolari”, di mettere in discussione le mie certezze e quelle di chi partecipa alle lezioni, spesso frequentate da centinaia di persone. Arrivato al momento degli esami, fatta eccezione per rarissimi casi, mi ritrovo spesso a parlare con sconosciuti, persone con le quali non ho mai scambiato una parola, né in presenza né in incontri virtuali.
Bisogna avere finalmente il coraggio di ammetterlo, e di denunciarlo: la didattica universitaria italiana è ratificatoria, si limita a svolgere un compitino semplice, vale a dire quello di distinguere i "bravi" dagli "incapaci", i preparati dagli impreparati. Non nego che alcune persone traggano benefici dai loro studi, ma il loro numero è irrilevante rispetto a un'utenza ampia e variegata. I pochi che riescono a emergere, in larga parte, hanno già frequentato durante l’adolescenza i migliori licei dei grandi centri urbani. Hanno già avuto modo di trascorrere periodi di studio all’estero, seguendo corsi di lingua, leggendo libri costosi, ascoltando musica, visitando musei e sale cinematografiche, godendo di molteplici stimoli culturali. Dal nostro limitato punto di osservazione, noi docenti siamo solo chiamati a trasformare le “prestazioni” in numeri, voti, quantificando i processi di apprendimento degli studenti senza conoscere i loro punti di partenza, il loro retroterra culturale, i loro obiettivi, i bisogni, le paure, le aspettative, le aspirazioni. Ci limitiamo talvolta a notare che alcuni sono felici del loro percorso. Altri invece si annoiano nell'ascoltare (solo "ascoltare") cose che già sanno o ritengono di poter imparare altrove, mentre altri ancora rimangono delle incognite, chiusi come sono in imperscrutabili silenzi.
La nostra università non è selettiva né di massa. Non promuove l'inclusione, solo in casi sporadici (e fortunosi?) valorizza l'eccellenza. Non favorisce la mobilità sociale o la circolazione del sapere, ma si limita solo a confermare e autenticare le gerarchie esistenti. È lo specchio di una società ingiusta, lacerata da grottesche disuguaglianze. È semplicemente e atrocemente classista. Si pone in coda a una scuola classista, capace di assorbire tutte le inaccettabili distanze fra centri e periferie, fra ricchi e poveri, che si traducono con puntualità nella persistente e ghettizzante ripartizione degli alunni fra istituti tecnici e licei. Le numerose riforme degli ultimi decenni hanno inasprito le disuguaglianze anziché attenuarle. Il sistema universitario – insieme all’intero sistema scolastico – va ripensato dalle fondamenta, a partire proprio dalla centralità della didattica, che ha bisogno di essere sviluppata in classi ristrette, con una costante attenzione alla condivisione e al confronto, i veri privilegi della “presenza”, sui quali si costruisce il rapporto fra insegnamento e ricerca. Deve offrire spazi, alloggi, borse di studio, occasioni di incontro e approfondimento. Non possiamo sentirci assolti dalla presenza di studenti che riescono a utilizzare il nostro sistema accademico per raggiungere obiettivi impensabili per i loro genitori. Al contrario, ci dovrebbe allarmare il fatto che questi studenti sono eccezioni. Sempre più rare.







