Il gioco a confondere di Dag Solstad
Previsto per il 2020, l’anno successivo a T. Singer, Armand V. di Dag Solstad è apparso solo adesso in Italia e anch’esso con grande ritardo, tradotto da Iperborea al pari degli altri cinque titoli dello scrittore norvegese. Rispetto alla prima pubblicazione ad Oslo, sono così diventati per Armand V. ben diciotto gli anni di attesa, mentre per T. Singer ne sono passati venti, venticinque per Romanzo 11, libro 18, diciannove per La notte del professor Andersen, sedici per Timidezza e dignità e ventitré per Tentativo di descrivere l’impenetrabile, il romanzo che nel 2007 ha rivelato in Italia un autore unico anche nel suo Paese, dove ha imposto un cosiddetto “metodo solstadiano” nel quale riconoscere un modello compositivo personalissimo, fatto di astrazioni e salti temporali, fraseggi articolati in una sporade vertiginosa di digressioni, sottigliezza acribitica di pensiero e ritmo che richiama da vicino il passo e lo scavo interiore di Thomas Mann, distorsioni vorticose di prospettiva, compenetrazione e commistione tra autore, narratore e personaggi, assenza pressoché assoluta di dialoghi, narrazione ridotta all’essenziale e descrizione spinta alla massima espressione. Un autore che, essendosi fortemente implicato nei rivolgimenti politici norvegesi, tanto da essere ritenuto in patria il cronografo nazionale, oggi ci appare – leggendolo a distanza di molto tempo – legato alla sua circostanza, come storicizzato: alla maniera in casa nostra di Sciascia e per certi versi di Vittorini, che è stato utopico allo stesso grado, preda delle “due tensioni”, politica e social-culturale, che hanno agitato anche Solstad, di decennio in decennio andato riproponendosi in nuove cotte e in una produzione letteraria sempre diversa, preda di una inesausta smania di cogliere il “respiro” (come lo ha chiamato parlando della sua scrittura) del proprio tempo.
Con una avvertenza necessaria: leggere in Italia Solstad è come sperimentare la visione delle stelle che vediamo non come sono oggi ma com’erano in passato. Legato a un’epoca colma di ideali rivoluzionari, poi di progetti riformisti ispirati a precetti da welfare state, quindi alla disillusione delle mire comuniste divenuta ambulacro di recidivanti interessi esistenzialisti e per questa via viatico di un reflusso personale che dal quadrante della politica ha distolto il suo sguardo verso la ricerca di una “chiave che apra la cassa piombata della coscienza”, come ammetteva già in Tentativo di descrivere l’impenetrabile, o della “formula della natura umana”, secondo quanto scrive in T. Singer, Dag Solstad è anche visto radicato in una Norvegia che nel tempo ha perso, dalla sua prospettiva, la vocazione laburista divenendo uno Stato capitalista provincia dell’impero statunitense. Una Norvegia in realtà cambiata veramente, al punto da indurre Massimo Ciaravolo, senz’altro il maggiore studioso italiano della sua opera, ad andare nel 2006 ad Oslo per verificare, oltre all’ipotesi che i personaggi di Solstad agiscano in funzione dell’ambiente, come in ventidue anni fosse cambiato il quartiere satellite di Romsås, concepito per dare una casa ai lavoratori e teatro del disincanto di Arne Gunnar Larsen, il progettista che in Tentativo di descrivere l’impenetrabile sceglie di andarci a vivere, così da condividere la condizione proletaria. E quel che Ciaravolo constata è un mutamento epocale, perché le case dei lavoratori sono diventate quelle degli immigrati, pur nello stesso spirito originario chiamato della “Grande Assenza”: ovvero la mancanza di socialità, compartecipazione e convivenza, risultato del benessere materiale conquistato dalla società norvegese nella sua trasformazione in senso capitalista e nella concomitante perdita della sua identità solidaristica.

Armand V. è il manifesto di questa disillusione convertita in delusione, ultimo atto del lungo, lento e travagliato processo di distacco di Solstad dalle sue primigenie istanze marxiste-leniniste. Ma più che una dichiarazione di resa alla subordinazione della Norvegia agli Stati Uniti, il romanzo integra un colpo di coda dell’orgoglio nazionale che tante illecebre aveva creato negli spiriti rivoluzionari dei giovani come Solstad negli anni Sessanta e Settanta. A quarantadue anni (l’età che anche in altri romanzi segna la linea d’ombra tra un prima e un dopo la svolta esistenziale) Armand V. è nominato ambasciatore, senonché maschera una coscienza nicodemica mai dismessa di estremista anti-Usa e anti-Nato qual è stato da giovane e tale da renderlo un “paradosso ai suoi stessi occhi”. Deride il figlio che si arruola per andare in missione di guerra all’estero, sapendolo al servizio degli Usa, e si fa beffa dell’ambasciatore statunitense che ad un convegno incontra negli orinatori trovando che abbia una testa da maiale e dicendogli, nel dargli la precedenza all’uscita, “Prima i giovani e poi i belli”, rendendosi conto solo dopo di averlo offeso e macerandosi quindi in un senso di colpa (entro un formidabile monologo interiore di tipo psicomachico) nel timore di contraccolpi alla propria immagine pubblica di diplomatico invero perfettamente osservante delle sue funzioni ufficiali. “Non si rivoltò contro coloro – scrive l’autore – che avevano scatenato la guerra da cui il figlio era tornato invalido. Se provava una rabbia profonda contro gli Stati Uniti non la espresse mai”.
Armand V. è compagno di inchiostro di T. Singer (anche nel gioco molto solstadiano di inversione di nomi e cognomi), che parimenti decide di rendersi anonimo al mondo, lascia Oslo e la promettente carriera intrapresa al ministero per trasferirsi a una settantina di chilometri, nell’entroterra del Telemark (evocazione del romanticismo agreste di cui Solstad è debitore a Knut Hamsun e ai suoi Germogli della terra), vivendo invisibile nella amorfa cittadina di Notodden come semplice bibliotecario. A mezz’ora di strada, a Kongsberg, scegliendo dunque anch’egli la provincia, si è trasferito anche Bjørn Hansen, protagonista oblomoviano di Romanzo 11, libro 18 e personaggio che ricompare con le stesse qualità dimidiate in Romanzo 17 del 2009 e in Terzo e ultimo romanzo di Bjørn Hansen del 2019, l’ultimo testo pubblicato da Solstad. Che oggi ottantatreenne tace ormai da cinque anni, dopo aver scritto nel 2013 L'indissolubile elemento epico nel Telemark nel periodo 1591-1896 e dichiarato in Armand V.: “Sto scrivendo nei tempi supplementari. La mia opera letteraria si è conclusa con T. Singer, scritto e pubblicato nel 1999. Tutto ciò che è venuto dopo è un’eccezione, che non si ripeterà mai. Anche questo.” Questo è il romanzo-non romanzo Armand V., davvero un’eccezione, che vedremo perché tale subito dopo una considerazione da farsi circa l’uomo solstadiano.
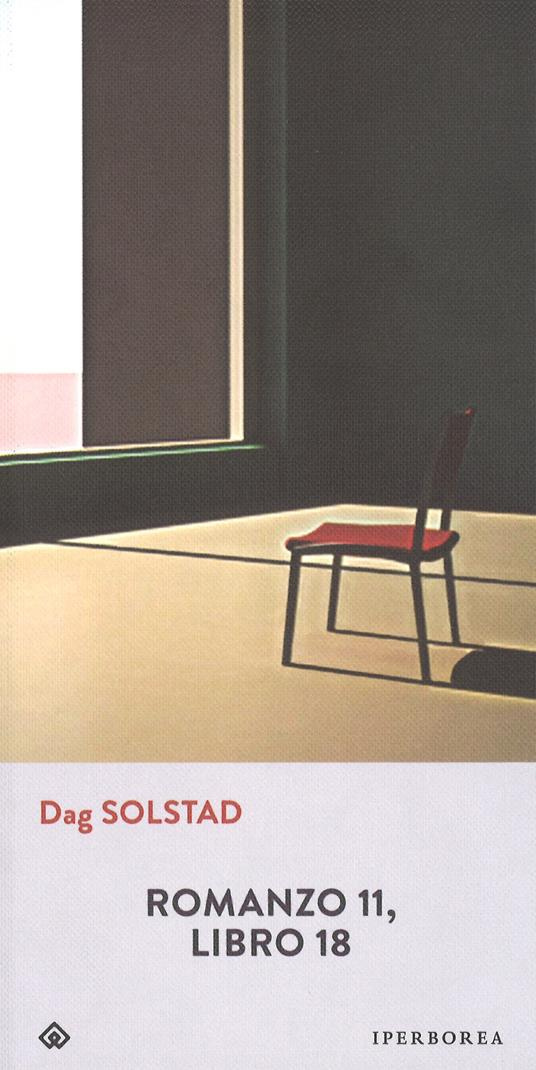
Riprendendo lasciti decadentisti, da Des Esseintes di Huysmans a Zeno di Svevo, sulla poetica dell’inetto, Solstad rifonda il modello nel calco dell’inattivo, nel quale è facile riconoscere lui stesso una volta spogliato dei sorgivi princìpi rivoluzionari che lo hanno nutrito e accettata la teoria di un fondo sempre autobiografico nella sua opera. L’uomo inattivo è quello che per indolenza, insipienza, escapismo e accidia, come anche per viltà, rinuncia a ogni ambizione e si chiude in sé stesso, rivivendo i sogni vagheggiati da giovane. Coerentemente, nei romanzi di Solstad i rimandi dall’età giovanile a quella adulta sono ricorsivi e insistiti nel segno di un diaframma tra ideali mancati e attuali disinganni nel cui solco lo stesso autore si attesta in prima persona.
Una sindrome questa che solo in parte è restituita dai sei romanzi usciti finora in Italia, ma che nel complesso dell’opera originale deve essere sicuramente significativa. Nell’intera attività letteraria dovrebbe infatti apparire chiaro qual è stato il percorso, in Italia appena intravisto e intuito, che porta allo sperimentale metaromanzo Armand V., cerebrale esercizio di scomposizione del genere narrativo destituito in note a piè di pagina, a formare un composito apparato che la critica italiana ha invero faticato a spiegare. Ma che pure non arriva improvviso perché in 16.07.1941, libro del 2002 che nel titolo ricorda la data di nascita di Solstad, figurano già undici note a piè di pagina, prodromo quindi di un programma che si concretizza quattro anni dopo in una forma che a noi può sembrare sconcertante ma che involge un preciso intento evoluzionistico di cui Solstad non fa mistero in Armand V.: “Devo ammettere che di anno in anno divento sempre più consapevole di quanto io sia avviluppato in questa idea”.

L’idea è quella di scrivere non più romanzi, bensì note a piè di pagina di romanzi “uutgravde”, letteralmente non scavati, non estratti. Di qui un funambolico e originalissimo teorema che investe la natura del romanzo e la capacità di destrutturazione e di sperimentazione di nuove formule narratologiche. Sottotitolo di Armand V., fatto proprio di novantanove note a piè di pagina, non poche articolate in più parti alfanumeriche, in italiano è “Note a un romanzo non scritto”, un po’ fuorviante rispetto all’originale norvegese, più pregnante: “Note a piè di pagina a un romanzo non scavato”: a intendere un romanzo “originario” (più avanti, per qualche motivo, chiamato nella traduzione italiana “originale”), dunque esistente e perciò come scritto, ma solo virtualmente perché è invisibile, sta “là fuori” o “là sopra”, un romanzo che si può solo portare alla luce estraendolo dalla sua sfera di impalpabilità. Una sorta di Ur-text mentale.
La formula “note a piè di pagina” evoca Borges e quanto disse sulla letteratura occidentale, da intendere come una nota a piè di pagina di Cervantes. A proposito ha scritto lo scrittore argentino Alan Pauls: “L’opera di Borges abbonda di questi personaggi subalterni, un po’ oscuri, che seguono come ombre le tracce di un’opera o di un personaggio più luminoso. Traduttori, esegeti, annotatori di testi sacri, interpreti, bibliotecari, perfino gregari di guappi armati di coltello: Borges definisce una vera etica della subordinazione”. Pauls parla di “nota a piè di pagina di quel testo che è la vita di qualche altro”, definendo una condizione umana ma anche letteraria che in Solstad si costituisce piuttosto come etica dell’alterità sia in riferimento a un testo che a un personaggio. Le note che compongono il libro rimandano infatti al romanzo da estrarre come anche alla vita di Armand V. che Solstad, in uno straniante gioco di specchi, dice di aver conosciuto insieme con il suo amico di giovinezza Paul Buer. In sostanza l’autore, ormai ultrasessantenne nel 2006, confessando di non avere più futuro (“comincio a guardare avanti, non verso il futuro, ma verso la fine; non posso più cambiare il mondo, ma posso completarlo”) né quindi un “progetto” che riguardi un romanzo, si addice a scrivere note a piè di pagina da un lato del romanzo stesso che si rifiuta di scrivere, ma che potrebbe portare alla luce perché esiste nella personale sfera di intuizione, ciò che però non fa, e da un altro della vita del protagonista che tuttavia “là sopra” potrebbe essere molto diversa.

Si potrebbe pensare che, a corto di energie, Solstad non si senta più in grado di affrontare sforzi pari a quelli che richiedono la stesura di un romanzo della complessità a lui propria e si limiti così al più agevole commento, disomogeneo ed estemporaneo, di svolgimenti diegetici che però sono solo immaginari. Invece il romanzo, chiamato “esistente”, è alla fine costituito proprio dalle note a piè di pagina, tanto che Solstad può alla fine stabilire che “la somma di queste note è il romanzo su Armand V.”. Ma, in questo quadro di finzioni decisamente borgesiane, Solstad non riesce a risolvere una contraddizione che egli stesso solleva: se è vero, come dice, che tutti i suoi romanzi finiscono in maniera diversa rispetto alle intenzioni iniziali e se questo dunque significa che scrive a vista e non sviluppando un vero progetto già predisposto, come può poi parlare di “romanzo originario” da portare alla luce, dal momento che in realtà non esiste se non in forma minimale? La risposta che l’autore offre è elusiva: “Per quanto io neghi che il romanzo fosse presente fin dall’inizio, non posso ignorare che potrebbe comunque essere così. Anzi più mi contraddico, più sono sicuro che non mi sto contraddicendo, ma che scrivere un romanzo è trovarlo e rivelarlo”. Se non lo cerca, come ha sempre fatto, entrando cioè nel romanzo non scritto per tirarlo fuori, è perché ha paura, come ammette, che non risulti alla stregua degli altri e non soddisfi il suo “standard abituale”.
Non leggeremo mai il romanzo che sta là fuori, ma ci basta quello “esistente”, fatto delle sue note a piè di pagina, per dire che lo sforzo compiuto da Solstad ha del prodigioso, giacché il romanzo c’è tutto e nessun deficit sconta al di sotto dei precedenti. Soprattutto c’è Solstad come lo abbiamo conosciuto: più beffardo che ironico, ridondante, corrosivo e irridente, magistrale conoscitore dell’animo umano nei recessi più profondi, tale da richiamare da vicino i tragici greci, prosatore con una cifra unica talmente raffinata da apparire stucchevole. Così è nella descrizione delle azioni sulle quali si sofferma in aperta violazione dei principi aristotelici dell’essenzialità e della consequenzialità. In base a questi principi, fatti propri da ogni scuola di scrittura, un’azione che non serva alla trama va taciuta, perché regola è che se l’autore, durante una cena, manda un commensale in cantina deve succedere qualcosa che ne sia conseguenza.
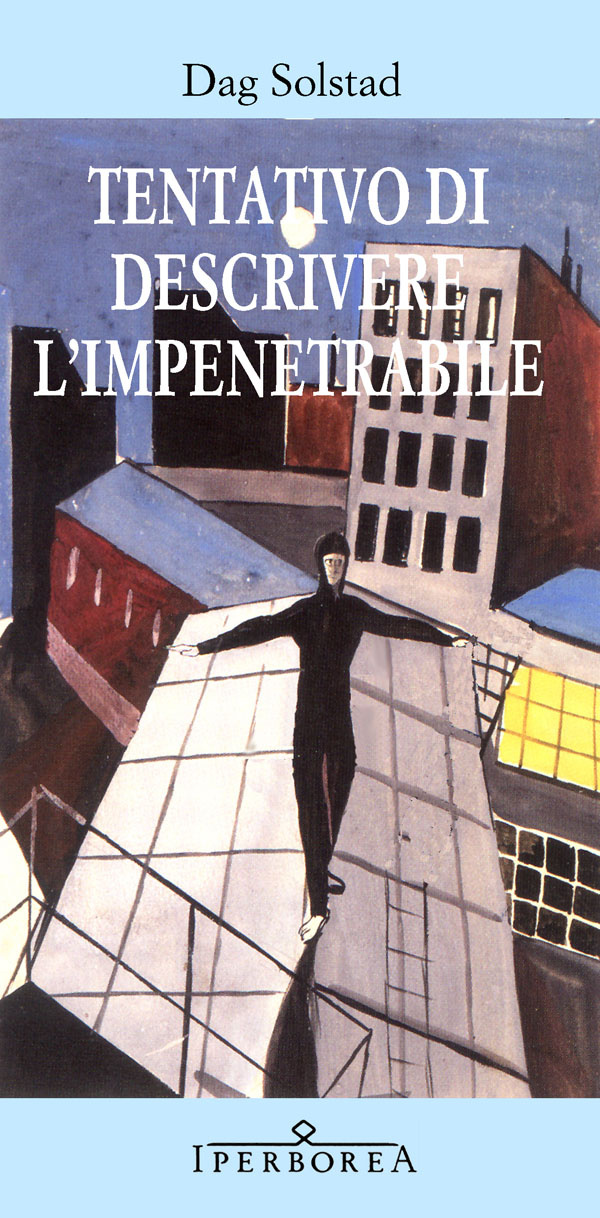
Solstad se ne infischia e non solo indugia fino al logoramento nel tracciare i percorsi stradali che i personaggi coprono sia a Oslo che altrove in un’odeporica che suona tanto travel, ma è capace, come in T. Singer, di descrivere il protagonista mentre, accompagnato in hotel dall’autista dell’amico, prova ad aprire la portiera senza riuscirci perché sia l’autista a farlo: senza alcun motivo ai fini di una scena che appare del tutto pleonastica. Basti il brano di T. Singer che esce di casa: “Afferra la chiave sul tavolo dell’ingresso, esce dalla porta e raggiunge l’auto. Apre e si mette al volante, infila le chiavi e suona impaziente il clacson per chiamare le altre due”.
Perché fa questo, spazientendo il lettore? Perché il Sostald del nuovo secolo ha maturato uno spirito esistenzialista che lo porta a notomizzare le azioni e le reazioni umane più impercettibili, nella ricerca in esse dei punti rivelatori della coscienza collettiva, consapevole che questa è la strada che porta nel territorio del nonsenso e dell’assurdo. Per Solstad una serie di gesti insignificanti vale più di quanto dica un personaggio, elemento canonicamente necessario a conoscerlo: per modo che nell’opera solstadiana, specie in quella della seconda metà degli anni Novanta, sono del tutto assenti i dialoghi. L’unico, interminabile, figura in T. Singer tra il protagonista e il marito della collega che Singer invita a casa per parlargli della moglie defunta e del grado di dolore e di colpa da riconoscersi avendo deciso entrambi di separarsi. Un dialogo sofisticatissimo quanto surreale, perché il marito della collega è solo immaginario.
Leggi anche:
Gianni Montieri | Dag Solstad, Ma Singer chi è?
Giorgio Matrorocco | Il diabete del Ministro







