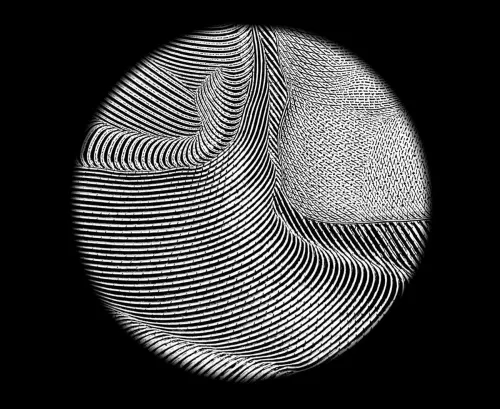Speciale
Accademia Unidee / Il lavoro dell'immaginario
Darwin in The Descent of Man, 1871, afferma: «La differenza mentale fra l’uomo e gli animali superiori, per quanto sia grande, è certamente di grado e non di genere». Una progressione nei risultati di ricerca che ci aiutano a comprendere un poco meglio cosa significa essere umani, conferma sistematicamente l’ipotesi del grande naturalista inglese. Antecedenti evolutivi delle nostre attuali distinzioni di specie che presidiano all’antropogenesi si ravvisano in altre specie. Dal canto dei fringuelli alla parola; dall’affettività primaria di una mamma scimpanzé al caregiving di una mamma della specie homo sapiens; dall’eusocialità tra i primati di ordine superiore alla cooperazione tra noi umani. E l’immaginazione? E l’immaginario? Abbiamo prove evidenti dell’attività onirica degli altri animali e anche della loro capacità immaginativa. È opportuno allora chiedersi se producono, come noi, mondi immaginari. Sappiamo che gli altri animali sanno ma non sappiamo se sanno di sapere. Ipotizziamo di no, anche se è verosimile supporre che dispongano anche nel campo dell’immaginario di antecedenti evolutivi, magari rudimentali. Pare che le loro conoscenze siano operative, immediate e pratiche, magari spesso irraggiungibili in molteplici aspetti e prassi per noi umani. Basterebbe considerare per un momento la tela di un ragno.

La sua dimensione estetica, in grado di sollecitare la nostra sensibilità e di farne scaturire infinite interpretazioni, richiede la presenza di un appartenente alla specie homo sapiens. È quest’ultimo che fotografa le tele di ragno, allestisce magari delle mostre di quelle fotografie, riproduce le tele dipingendole, le commenta, le analizza, le studia, ne ricava teorie, le usa come metafore, crea poesie, inventa miti e linguaggi fino a irretirsi (sic!) nelle proprie stesse creazioni. Tirare un filo tra noi e un ragno è un’impresa impegnativa e difficile, eppure quel filo c’è. Tra noi e uno scimpanzé o un gorilla è meno impegnativo, ma la vita è differenza che genera differenze. E forse la nostra differenza consiste nel saper dire di no alla coincidenza con noi stressi e con la nostra natura, alle routine e alle consuetudini, e nel saper creare immaginari componendo e ricomponendo in modi almeno in parte originali i repertori esistenti nel mondo. Fino a inventarsi altri se stessi e a vivere di loro.
“Vado mutando di personalità”, scrive Fernando Pessoa, “vado arricchendomi della capacità di creare nuove personalità, nuovi modi di fingere che io comprenda il mondo, o meglio, di fingere che lo si possa comprendere”. E ancora, sempre lui: “Ci sono cose in me che avrei voluto poter trasformare in uomini, solo per poterle affrontare faccia a faccia. Avrei detto loro: ‘Non sono vostro schiavo!’. Ma quando queste cose sono dentro di noi non esiste negazione né coraggio. Obbedendo a esse, obbediamo a noi stessi; obbedendo a noi stessi, obbediamo a esse”. [Fernando Pessoa, Teoria dell’eteronimia, Quodlibet, Macerata 2020; p. 20]. Sul tema della creatività Donald Winnicott avrebbe scritto, in una lettera a Melanie Klein del 17 novembre 1952: “La psicologia della creazione artistica è quindi un genere della creatività che infonde vita…”, confermando l’affermazione di Mary Wollstoncraft: “È l’immaginazione il vero fuoco che abbiamo rubato al cielo”.
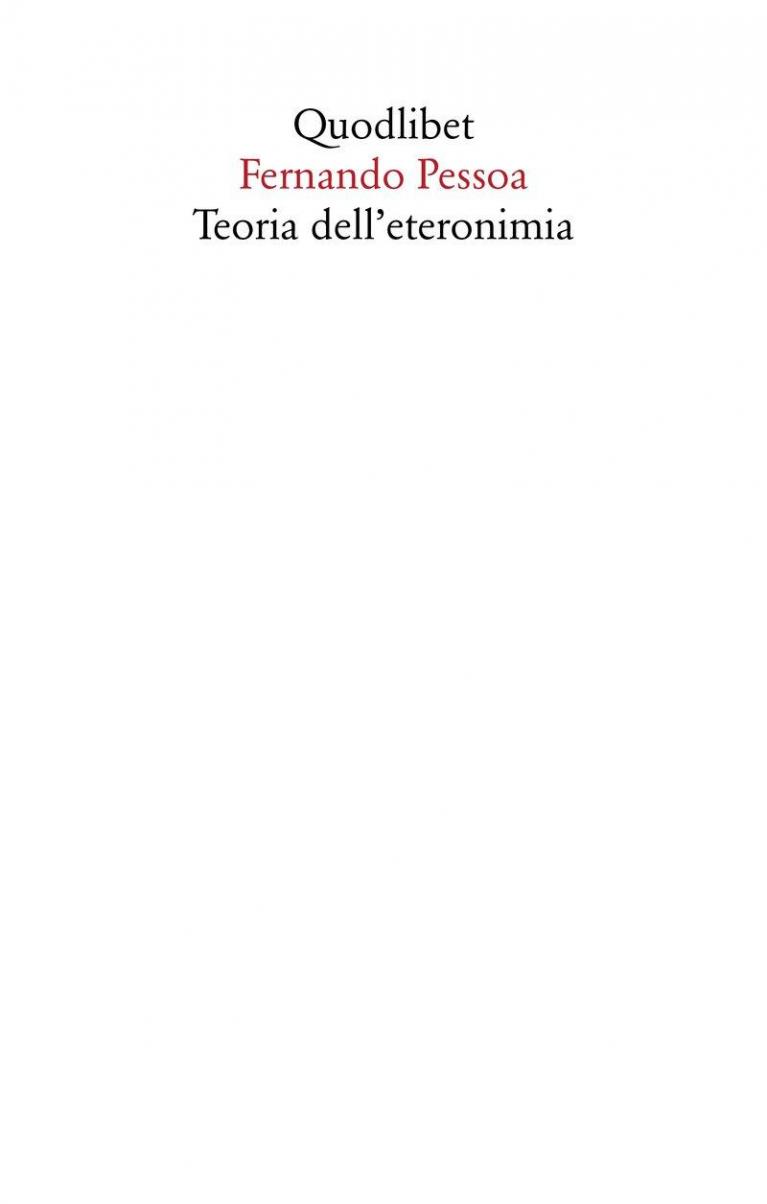
La sostanza dei sogni prende fuoco
In una lettera a Donald Winnicott, Claire Britton scrive: “Buona notte – ti scrivo due righe di una poesia di Seigfried Sassoon (non riesco a ricordarmene di più):
‘Grazie a voi, Beethoven, Bach, Mozart,
la sostanza dei miei sogni ha preso fuoco’.
Non è bella? Sai che Wordsworth per la maggior parte della vita ha parlato dell’enorme fortuna che aveva per il fatto che il suo mondo immaginario interno fosse così strettamente connesso alle sue preferenze reali? Era una fonte costante di meraviglia, gli sembrava un miracolo e cercava sempre di cogliere i segni di questo rapporto” [in F. R. Rodman, Winnicott, Vita e opere, Raffaello Cortina Editore, Milano 2004; p. 100]. Immaginazione, immaginario, comportamento simbolico, finzione, finzione di finzione, simulazione, ironia, umorismo, negazione, creazione, esperienza estetica, bellezza, sono esperienze peculiarmente riconducibili a homo sapiens, che è in grado, anche se non sempre, di mettersi al margine di un contesto o di una situazione a cui appartiene e da cui trae senso e significato, magari mettendola in discussione fino a rivoltarla e ribaltarne il senso. Il ready made di Marchel Duchamp ne è una conferma evidente, ma ancor più lo è il gesto con cui, in occasione dell’inaugurazione di una mostra al Museo Métropole di Lille, in cui Fountaine, l’opera di Duchamp del 1917 era in mostra, alla presenza del Presidente francese, un esibizionista riportò al suo uso originario l’opera, urinandovi dentro e venendo immediatamente arrestato. La rottura di un ordine di senso basato su una precedente rottura di un ordine di senso evidenzia sia le proprietà emergenti che i vincoli di persistenza dell’immaginazione e della creatività umane. Non solo, ma ci aiuta a comprendere anche che il senso emerge dal margine e che i margini che abbiamo non sono illimitati, come non sono illimitate le grammatiche, secondo la fondamentale analisi di Andrea Moro, in I confini di Babele, Il Mulino, Bologna 2018. Il margine, che non è lo spazio residuale, la componente che non conta, quel che rimane rispetto al centro, bensì, in buona misura, il luogo delle effettive possibilità, l’area delle azioni possibili, si propone come l’ambiente là dove emerge il senso, e soprattutto il senso del possibile. Già Martin Heidegger aveva sostenuto che “Il limite non è il punto dove una cosa finisce, ma, come sapevano i Greci, ciò a partire da cui inizia la sua essenza”. È richiesta oggi un’epistemologia del confine e del margine, per riconoscere che è solo il secondo che ci può aiutare a rendere flessibili, seppur a non negare, le componenti di chiusura del primo. Il rapporto tra mondo immaginativo interno e esperienze reali si esprime anche nell’atto di leggere. Il lettore vede oltre le parole sulla pagina: la lettura è dunque, a sua volta, un atto dell’immaginazione. Ludwig Wittgenstein nel Tractatus Logico-Philosophicus scrive che “La proposizione è un’immagine della realtà, è un modello della realtà quale noi la pensiamo”. E Oliver Sacks, in Allucinazioni, sottolinea che “noi non vediamo con gli occhi: vediamo con il cervello”.
Peter Mendelsund – che della grafica e dell’art direction editoriale è anche teorico – ha scritto un libro originale e affascinante, Che cosa vediamo quando leggiamo (Corraini, Mantova 2020), in cui afferma che quando ricordiamo l’esperienza di aver letto un libro, immaginiamo un dispiegarsi continuo di immagini. Secondo i principi della fenomenologia della percezione visiva e dei processi mentali, il linguaggio scritto si configura come un potente produttore di immagini, un fertile motore dell’immaginazione. Nell’esperienza della lettura ogni lettore colma le lacune dell’indistinto mettendoci sempre qualcosa (anche molto) di suo, soggettivamente. Nota Mendelsund: “È proprio quello che il testo non dice apertamente a sollecitare la nostra immaginazione. E dunque mi chiedo: forse immaginiamo di più, o più nitidamente, quanto più un autore è criptico e sfuggente?”. Rilevante è l’intuizione che l’esperienza della lettura di un libro possa essere come l’esecuzione di un brano musicale, dove il lettore è autore della performance e insieme suo spettatore. O quella che la memoria è fatta di immaginario e l’immaginario è fatto di memoria. O anche l’interrogativo se sia possibile esercitarsi a immaginare, come ci si esercita nel disegno, per riuscire a immaginare meglio.
Epistemologia del margine
È dall’ibridazione di codici, dall’incontro tra differenze, che a ben guardare ricaviamo di fatto i processi di innovazione e trasformazione e, quindi, le dinamiche della vista stessa. I frutti puri impazziscono, aveva scritto non molti anni fa l’antropologo James Clifford, tracciando uno dei più bei ritratti della letteratura e dell’arte del ventesimo secolo [J. Clifford, I frutti puri impazziscono, Bollati Boringhieri, Torino 2010]. Un’epistemologia del margine esige un approccio marginale, in grado cioè di muoversi negli spazi transdisciplinari, dove i saperi e le culture si intrecciano tra loro più volte dando vita a sguardi neodisciplinari e fluidi, in grado di riconoscere che le narrazioni della conoscenza sono a loro volta parte integrante, e in una certa misura costitutive, delle realtà narrate. Tutto questo non è il contrario della relativa e necessaria chiusura di tutto quel che vive per poter esistere.
Una realtà vivente, infatti, per esistere tende a darsi una relativa chiusura, condizione della propria autonomia (Maturana, Varela, Autopoiesi e cognizione, Marsilio, Venezia 1980). Vive, tuttavia, in quanto al margine si generano le possibilità di adattamento e apprendimento che ne mettono in crisi l’autonomia e ne sollecitano l’evoluzione. Sia l’adattamento che l’apprendimento non sono processi lineari ma circolari e conflittuali. Il margine, come l’ambiguità e la mancanza, tende a segnalare l’importanza di una visione dinamica e non lineare, complessa e non deterministica, dell’esperienza. Appare evidente l’importanza di domandarsi allora come si può riconoscere e comprendere il margine; quale rapporto tende a esserci tra il margine e la chiusura; perché essere al margine, nel linguaggio di ogni giorno assume un valore negativo, ma allo stesso tempo chiedere la concessione di un margine vuol dire auspicare una possibilità. Per quanto fragile, nel margine sembrano vivere l’adattamento e l’apprendimento e sappiamo che la stessa autonomia di un sistema dipende dalla capacità del suo adattamento continuo, della sua gestione evolutiva dei conflitti con gli altri e con l’ambiente.
Qual è insomma il senso del margine e che rapporto c’è fra difficoltà e possibilità di essere al margine e gestione evolutiva dei conflitti? Apparirà probabilmente evidente come la posizione marginale sia propria e proficua per la comprensione e la gestione dei conflitti. Provando a ragionare intorno al margine e sulle esperienze che esso richiama è opportuno privilegiare una visione ampia e pluridisciplinare; rispetto al tema del margine abbiamo perciò inteso tenere conto di quello che accomuna gli organismi viventi, gli individui, i gruppi, le società. A volte il margine si è presentato come residuo, a volte come terra di nessuno; in certi casi come zona d’ombra. Tutti significati che inevitabilmente rimandavano a un centro, a un nucleo, a un dentro contrapposto a un fuori. Il confronto ha messo in evidenza come il margine non sia un confine ma uno spazio, una infinita varietà di toni; non una separazione tra bianco e nero ma una molteplice scala di colori. Si trova tra e si evolve in relazione a ciò che è fuori e ciò che è dentro, si modifica continuamente, cambia in base ai rapporti che si sviluppano nelle aree di contatto e contagio: è lo spazio dell’altro da sé e la sua esistenza e il suo valore dipendono dalla disposizione alla discontinuità e al cambiamento. Nella zona intermedia del margine si creano i vincoli e le possibilità di apprendere ad apprendere dall’evoluzione dei conflitti che i diversi movimenti comportano. Il margine non si contrappone a ciò che è solido, continuo, ma gli è complementare e per molti aspetti lo alimenta. E’ in questo ambiguo equilibrio tra ciò che muta e ciò che permane che si gioca il destino delle specie, dei gruppi, delle organizzazioni, delle società, ma anche degli individui.
Le società ad esempio vivono in quella continua tensione fra ciò che è e ciò che può essere; fra l’istituito e l’istituente; senza questa tensione non vi é democrazia. Il margine ha cominciato perciò a configurarsi, nel confronto e nello scambio, come il luogo dell’ambiguità, dove non valgono le leggi del vero e del falso, del sano e del malato; come il luogo del non definito, dell’incertezza e dei dubbi; come lo spazio delle possibilità. Il linguaggio, che esprime la potenza creatrice del possibile e dell’inedito, è in un certo senso la pratica del margine per eccellenza; il luogo dell’elaborazione e della possibile approssimazione: la stessa parola può esprimere le più tenaci forme di integrazione ma anche le più drammatiche forme di esclusione. Il margine è perciò luogo di disagio e di inquietudine, luogo di ricerca potenzialmente generativo di possibilità e di futuro. L’elaborazione che il conflitto comporta può fare del margine il luogo privilegiato dell’evoluzione di una relazione, di un rapporto tra gruppi, di un incontro di culture.
Dimensione germinale del margine
L’elaborazione del margine è un esercizio atto a mettere in forma la vita intera. Il termine giapponese Yohaku significa letteralmente margine, spazio vuoto (yo: resto; haku: bianco), qualcosa che ha raggiunto la riduzione all’essenziale. La stessa dimensione i greci la definivano àskesis, indicando un esercizio e un’esperienza attraverso cui la vita intera prende forma. Il margine, lo spazio agibile, luogo del vuoto e del possibile è perciò la struttura che collega, il luogo del gioco, del rischio del baratro e di ogni possibilità. Gestire l’evoluzione del conflitto vuol dire “darsi margine”. Il margine è il luogo del divenire, dell’inizio dell’altrove e in questo senso vale il gotico marka quando indica la frontiera. L’origine della parola ne segnala sia il genere maschile che femminile, la sua capacità di costituire un contenuto e di essere luogo germinale di contenimento, mentre può essere luogo di emarginazione. In queste sue potenzialità sta il più alto rischio ma risiedono anche le opportunità più elevate. Quando si cerca di realizzare un processo di cambiamento in una situazione che riguardi l’esperienza individuale, quella di un gruppo o di un’istituzione, ci si rende presto conto che proprio le cose lievi bisognerebbe perseguire: quelle in grado di facilitare l’evoluzione. Ci si rende anche conto che perseguirle non è però facile poiché per il fatto stesso di perseguirle esse tendono a strutturarsi e a divenire impegnative, costose e vincolanti. La nostra stessa ricerca di consistenza nell’azione, il nostro stesso desiderio di lasciare una traccia, concorrono a questo rischio e non sempre ci riesce di disporci ad attendere attivamente e in forme leggere la loro manifestazione imprevista, o raramente prevedibile.
È al margine della caoticità che si genera l’incertezza (Holland, 1998) e la possibilità della vita nell’infinitamente piccolo, mentre le dinamiche dell’ “infinitamente grande”, come i sistemi sociali e i processi sociali in genere, tendono ad avere almeno in parte gli stessi andamenti. Il senso del margine sta, quindi, nel suo valore generativo; se il margine non è una linea né un confine, contiene, per la stessa ragione della generatività, il rischio della perdita. Tra conformità e difformità emerge lo spazio del “quasi-conforme”: quello spazio può portare all’esclusione o può generare una trasformazione emancipativa. Può generare aggressione ed emarginazione o capacità di riflessione e “corteggiamento”. Se il margine riesce a essere valorizzato come spazio e tempo di gioco può divenire il passo da fare per spostarsi dalle posizioni centrali di certezza e accedere alla plasticità delle zone temporanee ed evolutive, agli spazi del possibile dove dalla buona elaborazione dei conflitti può emergere il senso del futuro.
Ambiguità del margine
Una delle ipotesi più accreditabili sulla complessa origine della cultura e del legame sociale è che abbiano a che fare, tra l’altro, con l’elaborazione dell’ambiguità e con il conflitto generativo. Dove convivono in maniera contingente domanda di autonomia presente in ogni vita e della dipendenza che ogni vita ha dalle altre vite per riuscire a riconoscersi mentre viene riconosciuta, lì si originano la socialità umana e la cultura. Ci leghiamo agli altri nei processi primari e successivi che presidiano all’elaborazione di questa ambiguità e così, verosimilmente, istituiamo forme riconoscibili e almeno relativamente rassicuranti che si esprimono in valori e culture. Il conflitto generativo è costitutivo di quell’incontro reiterato che istituisce la società. Dall’incontro di differenze possono emergere provincie di significato, se la cultura fa da lievito, o regressioni e chiusure senza l’alimentazione culturale.
Lo stesso processo porta al consolidamento delle forme sociali e alla loro relativa stabilità e durata. Forze centripete e difensive spesso alimentano le culture fino alla chiusura, vissuta come condizione di preservazione con l’esito di giungere alla negazione di ogni margine di flessibilità per preservare l’integrità, con rischi di integralismo. Quando questo processo si avvita in modo esponenziale su se stesso e rompe gli indugi e l’incertezza di ogni differenza, negandola, ecco che si configura l’integralismo o il totalitarismo come negazione di ogni margine.
La ricerca della dimensione pura del “noi” diviene una forma di socialità ossessiva, che esige nette e marcate separazioni tra il dentro e il fuori, tra noi e loro. Il gioco del possibile e il riconoscimento di ogni margine suonano come minacce e la cultura, figlia dell’ambiguità, diviene madre di mostri, anch’essi forme di culture che si alimentano voracemente della negazione e dell’esclusione di ogni spazio di incertezza, di ogni margine e di ogni differenza, di ogni possibilità di accesso al conflitto e al dialogo. Lo spazio del gioco finisce e con esso il sorriso, la dissacrazione, il contagio e l’ironia. Il margine può essere perciò inteso come il luogo dell’ambiguità, dove convivono ineliminabilmente le dimensioni di vero e di falso con cui i fenomeni non banali si manifestano, dove le cose divengono possibili senza che necessariamente avvengano. Il margine è il luogo dove, stando nel micro, due cellule possono incontrarsi e generare una vita o possono non incontrarsi. E’ anche, nel macro, il luogo dove possiamo incontrarci o, avendo potuto incontrarci, non ci incontriamo.
La base sicura e il margine possibile
Per tutte queste ragioni il margine permane un luogo ambiguo, di disagio relativo, con un’infinita possibilità. Il bisogno di centro non è in alternativa con l’esistenza del margine. Appare infatti di particolare importanza riconoscere il bisogno di sicurezza e di protezione che l’appartenenza ad un centro suscita e allo stesso tempo comprendere il senso di paura e di incertezza che il margine attiva. Se è vero che l’elaborazione del conflitto è decisiva per accogliere la complessità del margine, essa ha bisogno di una base sicura per divenire possibile. La bellezza delle dimensioni destrutturate è possibile per l’esistenza di strutture che connettono e rassicurano. I fallimenti nell’elaborazione emancipativa del margine non vanno cercati solo nelle condizioni esterne avverse o sfavorevoli, ma anche negli eccessi di relativismo e nell’incapacità di riconoscere il valore del centro e la sua funzione di espressione di autonomia e di possibilità di relazione, negoziazione e conflitto. La negazione della dipendenza non aiuta a riconoscere il valore e la possibilità intrinseci nel margine. Si rischia altrimenti di predicare il margine e di praticare la ricerca rassicurante del centro. Noi tutti dobbiamo la nostra crescita e la nostra evoluzione all’esistenza di un livello di autonomia della nostra origine e della nostra storia; tutti noi allo stesso tempo sappiamo che quella autonomia si genera e si afferma in quanto dipendiamo da qualcuno e qualcosa che ci rassicurano, almeno relativamente. Il margine tra noi e l’altro è così un “terzo spazio” tra l’accettare l’altro passivamente senza farsi influenzare dalla sua presenza e il negare l’altro per la differenza grande o piccola che porta con sé. La negazione della dipendenza dall’altro in fondo è il significato più intenso e più inquietante della negazione dell’altro.
La ricerca della propria autonomia è una condizione perseguita a partire da fondamenti anche naturali da parte di ogni sistema vivente. Si giunge però in molte situazioni a cercare la via della propria emancipazione trasformando l’autonomia in chiusura. Si rimuove così il fatto che l’altro è la fonte di ogni possibile emancipazione, così come è la fonte della propria e dell’altrui mente e di ogni possibile pensiero, coscienza di ordine superiore e conoscenza. Senza attribuzione di autorità all’altro egli non può essere fonte del nostro riconoscimento. Ciò è possibile senza negazione e senza adesione cieca. Lo spazio tra le due dimensioni è proprio il margine. È uno spazio ambiguo nel senso più profondo del termine. Mentre richiede lo spazio dell’altro, esige allo stesso tempo il riconoscimento del limite del proprio. Non è concesso al conflitto per l’elaborazione del margine la riduzione al gioco del vero e del falso, pena lo scadere del conflitto stesso in antagonismo.
Elaborazione della negazione
La tendenza a regredire alla negazione e alla scomparsa del margine è sempre presente in quanto l’aspettativa di certezza è pervasiva e pretende spazio di affermazione. L’ammissione dell’incertezza come condizione costitutiva di ciò che vive pone oggi una sfida epocale all’esperienza personale e sociale così come alla ricerca scientifica. Dalla quantità di incertezza riusciremo ad ammettere nella nostra esperienza relazionale, sociale e politica, dipende il nostro stesso futuro. Se la ripetizione rassicura e la differenza inquieta, la loro ambigua coesistenza è la vita stessa; la prevalenza di una delle due dimensioni può generare negazione e morte. Il margine è perciò conflittuale. Di quello stesso conflitto che genera la cultura come luogo dell’incontro e della coevoluzione delle differenze. Così come il margine è il luogo dove convivono ineliminabilmente le dimensioni di vero e di falso con cui i fenomeni non banali si manifestano, alla stessa maniera il conflitto è l’incontro delle differenze e dalla sua elaborazione possono emergere emancipazioni o regressioni. Per questo il margine è anche il luogo del disagio, dove non ci sentiamo “a posto”, dove si esprimono, costantemente, inquietudine, possibilità e paura di essere esclusi. Dove non è facile sostare senza prendere posizione e, soprattutto, senza tendere a semplificare e ridurre la complessità. È solo perché si cerca una via d’uscita e, pertanto, una certa convergenza verso un “centro” che si riesce a valorizzare il margine. È perciò importante riconoscere che il margine non è il luogo del vago, del vuoto di senso, dove non vige un principio di autorità, un orientamento o un criterio di scelta. È proprio l’esistenza di un orientamento e di un principio selettivi che consente di interagire, negoziare o confliggere dando valore ai margini di evoluzione esistenti e possibili. Abbiamo bisogno di riconoscere il valore della domanda di sicurezza e di strutturazione, non negandoli. La possibilità evolutiva sta nel modo di elaborare la domanda di sicurezza e non nel negarla, accogliendo il valore che ha per chi la esprime. È la prima condizione per una reciprocità ed una comune emancipazione possibile. Se è vero che c’è qualcosa di bello e generativo nel destrutturato, del resto, è perché appoggia su qualcosa di strutturato. Esistono le emozioni e c’è una coscienza primaria e fondativa. A partire da una base generativa originaria, emerge la comunicabilità in una relazione. Non sono gli esiti relativistici che consentiranno di valorizzare il margine e le sue potenzialità, ma è la difficile accoglienza della sua ambiguità, che può essere generativa.
Cultura e innovazione al margine
L’ambiguità del margine ha una sua origine interna, prima ancora che relativa ai fenomeni sociali. Siamo prevalentemente orientati alla persistenza e alla continuità dei nostri orientamenti e delle nostre posizioni, rispetto alla disposizione a cambiare punto di vista. Vi è un margine interno che fa i conti con un ostacolo epistemologico, per cui cambiare idea richiede spesso un investimento in discontinuità non facile da realizzare. I vincoli della storia e dell’esperienza sono, oggi in particolare, spesso rinviati o risolti e sostituiti nella negazione, piuttosto che dare vita all’immaginazione del possibile. Il margine diviene così un luogo di implosione piuttosto che un luogo di ricerca e di progettualità. Accade però che alcune tra le categorie più importanti di una socialità possibile oggi si definiscano al margine delle forme consolidate. La definizione dei diritti futuri e possibili e, in particolare il diritto di cittadinanza, seguono oggi almeno due direttrici: quella dell’autonomia e quella dell’alterità, e in questo modo vengono messe in discussione le categorie moderne della cittadinanza. L’unificazione dei mercati entra in conflitto con la domanda di partecipazione che si estende di pari passo e con una domanda crescente di autonomia dalla sfera economica e dallo stato, che si approfondisce progressivamente.
Questi casi sono accomunati dal fatto inedito che la produzione della norma prende le mosse da un’antropologia dell’alterità e pone il rapporto tra il soggetto giuridico e le organizzazioni politico-sociali a partire dalla molteplicità delle forme di individuazione del proprio sé. Il margine diviene origine di trasformazione e pone un conflitto rilevante tra il diritto come codificazione di un comportamento unico per tutti i cittadini e i confini troppo limitati delle norme sociali per contenere la varietà delle identità individuali. L’alterità sfuma, insieme alla ridefinizione dell’identità, dal centro al margine. Le “volontà di controcondotta” espresse dai soggetti e in grado di sostenere norme individuali di comportamento, esaltano il ruolo del conflitto come via per problematizzare l’esistenza della propria identità, nel momento in cui, anche a livello culturale e sociale, prende piede l’idea che il riconoscimento sia possibile a livello transindividuale. Una soggettività relazionale e riflessiva è per molti aspetti resa necessaria dalla densità delle relazioni e degli scambi e da una concezione della soggettività non come presupposto, ma come esito delle relazioni e delle azioni attraverso le quali gli individui danno voce ai propri desideri, alle proprie aspettative e, a livello sociale, prendono voce le istanze marginali e cercano inedite forme di esercizio del potere. La contraddizione tra diritto e giustizia emerge qui in tutta la sua portata.
La forma giuridica tradizionale e dominante, esito dei rapporti di forza storici e consolidati, viene sollecitata da nuove attese di giustizia che, dal margine, ne interrogano e mettono in discussione la struttura consolidata. Molte sono le differenze sociali che confliggono con l’autorità e il potere legittimo e la natura “conservatrice” di ogni istituzione viene messa in discussione dalla natura “fondatrice” delle istanze marginali. Le crisi contemporanee presentano spesso, oltre a tutti gli altri aspetti, una domanda che proviene da componenti della popolazione, locali o globali, ai margini dell’ordine legittimamente riconosciuto. L’intreccio tra le crisi ambientali e i conflitti sociali presenta molti di questi casi in cui ogni situazione rimanda ad una questione più generale di giustizia. Un intero universo di esperienze di base legate alla difesa del territorio, dell’aria e dell’acqua, emerge ponendo questioni ineludibili e tali da collegarsi a questioni epocali ed esistenziali, perciò radicalmente conflittuali. Si tratta di “lotte per il riconoscimento” che propongono non solo contenuti inediti ma anche un’etica del conflitto.
Esse riguardano le politiche per il riconoscimento all’interno di una prospettiva multiculturale. Quelle politiche sono generate da conflitti sociali più o meno espliciti e diffusi, ma in grado di caratterizzare la contemporaneità, dagli aspetti bioetici a quelli riguardanti il rapporto tra libertà individuale e appartenenza comunitaria. Gli stessi principi universali liberali vengono sollecitati dall’incidenza delle differenze tra culture che irrompono sulla scena e chiedono voce, aprendo spazi di conflittualità inediti e dagli esiti incerti e per molti aspetti imprevedibili. A confronto ci sono l’appartenenza, il diritto e la solidarietà da un lato, e la violenza, la privazione dei diritti e l’umiliazione, dall’altro. Le possibilità dell’integrità e dello sviluppo personale sono sempre più correlate ad una dimensione intersoggettiva. Le condizioni dell’interdipendenza io – altro si profilano come il luogo marginale dove il conflitto può generare il presente e il futuro, con il sostegno generativo della cultura.
Accademia Unidee è il prototipo di un nuovo tipo di accademia d’arte della Fondazione Pistoletto. La proposta nasce dal percorso e l’esperienza del grande artista e dalle numerose azioni e iniziative ospitate nella sede di Cittadellarte. Accademia Unidee si caratterizza per una conoscenza multidisciplinare, orientata alla sostenibilità, all’innovazione consapevole, con attenzione all’impatto delle tecnologie sull’uomo, sull’ambiente e sulla società, e con una forte vocazione alla ricerca. Leggi anche: Una nuova Accademia.