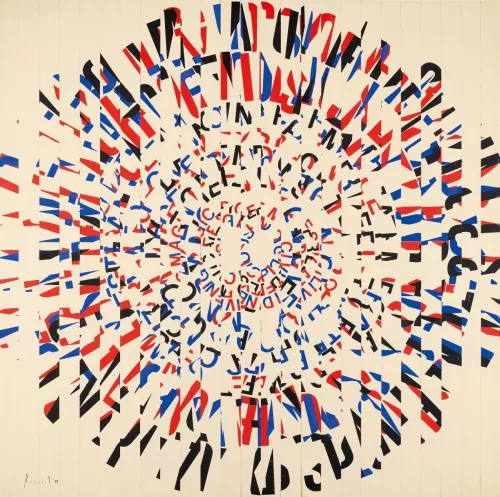Dal numero speciale di Philosphy's Kitchen / Mito e (neuro)scienze
Pubblichiamo un estratto da un saggio del numero speciale della rivista Philosphy's Kitchen, MITO. Mitologie e mitopoiesi nel contemporaneo (a cura di Giovanni Leghissa ed Enrico Manera). Pensato come espansione del volume Filosofie del mito nel Novecento, Carocci 2015, il numero della rivista ospita interventi dedicati alle forme contemporanee della mitologia nel Novecento in diversi ambiti (arte, letteratura e cinema, storiografia, mito, esoterismo, scienze cognitive).
L'intelligenza del dio
Molti sono gli antropologi e gli psicologi di orientamento cognitivo che sostengono che le credenze religiose e mitiche siano una conseguenza naturale dell'evoluzione della mente umana, o mente/cervello, come si dovrebbe dire per sottolineare l'impostazione materialista di questi autori.
Considerando il suo ruolo fondamentale nella storia delle scienze cognitive, un punto di vista interessante è quello di Howard Gardner, il padre della teoria delle «intelligenze multiple» (Gardner, 1987). Gardner (2000) analizza la possibilità di una forma autonoma di intelligenza, spirituale o religiosa, che comprenderebbe due abilità principali: realizzare particolari stati fisici coinvolti nella meditazione e in altre tecniche di manipolazione della coscienza, e raggiungere certi stati fenomenologici consistenti in una qualche esperienza di unione con il tutto. Secondo Gardner, però, nessuna di queste due capacità cognitive è specifica di un'intelligenza spirituale o religiosa, perché le abilità meditative possono essere ricondotte all'intelligenza corporeo-cinestetica e l'esperienza “estatica” di unione spirituale può scaturire da altre forme di intelligenza, come quella matematica o quella musicale, soprattutto nei momenti creativi. Per individuare una forma autonoma di intelligenza si devono poter individuare computazioni specifiche del dominio e secondo Gardner non è questo il caso per la presunta intelligenza spirituale. Gardner si domanda se sarebbe possibile attribuire a una «intelligenza esistenziale», legata all'esistenza di sé come individuo nel cosmo e alla capacità di interrogarne il senso, la capacità di «effettuare computazioni (in senso lato) su elementi che trascendono la normale percezione sensoriale, forse perché sono troppo grandi o troppo piccoli per essere appresi direttamente» (ivi, p. 29). Ma in mancanza di evidenze neuroscientifiche non c'è ragione per ipostatizzare un'intelligenza apposita.
Mito e cognizione
Gli antropologi cognitivi che si sono occupati di miti e religione hanno formulato spiegazioni specificamente cognitive, guidate dalle ipotesi sull'architettura della mente umana: il presupposto forte è che abbia senso parlare di “natura umana”, come i cognitivisti ammettono (Chomsky - Foucault, 2005).
I primi lavori di Dan Sperber, antropologo cognitivista e allievo di Lévi-Strauss, forniscono un buon esempio per una breve panoramica sul modo in cui le scienze cognitive hanno trattato il mito e le credenze religiose, “irrazionali” (Sperber, 1985). Nel contesto di uno studio sul simbolismo in generale, Sperber nel 1974 (ed. it. 1981) si è sforzato di sottrarre idealmente il suo maestro allo strutturalismo francese. Sperber attribuisce in generale scarsa produttività scientifica alla semiologia saussuriana (Sperber - Wilson, 1995) e contesta alla radice l'ideologia scientista secondo la quale
ogni oggetto della conoscenza ha per forza un senso, una significazione: dal senso della vita al senso del colore delle foglie in autunno. Dire di un fenomeno che non ha senso, equivale ad ammettere di non poter dire nulla sul suo conto […] L'attribuzione di senso è un aspetto essenziale dello sviluppo della nostra cultura; il semiologismo è uno dei fondamenti della nostra ideologia (Sperber, 1981, pp. 82-83).
Con questa critica del senso semiologico e del simbolismo, trattato già in una prospettiva cognitivista, Sperber contesta alla teoria lévi-straussiana la concettualizzazione del mito come articolazione delle somiglianze e differenze tra versioni diverse di uno stesso racconto. La natura dei miti è eminentemente cognitiva:
i miti secondo Lévi-Strauss [...] sono generati da un dispositivo che ammette un insieme infinito e non enumerabile di input possibili. [...] Il dispositivo che dovrebbe generare i miti dipende da uno stimolo esterno ed è affine ai dispositivi cognitivi, mentre si oppone ai dispositivi semiologici: è un sistema interpretativo e non generativo. [...] Lévi-Strauss ha dimostrato il contrario di ciò che afferma e i miti non costituiscono un linguaggio. [...] Se Lévi-Strauss ha concepito i miti come un sistema semiologico, i miti sono stati concepiti da lui, e a sua insaputa, come un sistema conoscitivo (Sperber, 1981, p. 82-83).
Secondo Sperber, Lévi-Strauss ha inconsapevolmente concepito le rappresentazioni della cultura primitiva come il risultato dell'interazione tra menti che elaborano input e producono output, in una non intenzionale coerenza con il paradigma computo-rappresentazionalista. La lettura sperberiana di Lévi-Strauss è certamente controcorrente; Sperber ha successivamente ribadito e precisato l'ideale vicinanza del suo maestro allo spirito delle scienze cognitive (Sperber, 2008). Ma che cosa sono i miti, nella prospettiva del primo Sperber?
Si immagini, per esempio, un racconto storico trasmesso oralmente in una società priva di scrittura. A meno che non si faccia uno sforzo particolare per conservarlo nella sua forma iniziale, certi episodi cadranno dopo poco tempo nell'oblio e altri invece verranno esaltati; l'insieme, in certi punti impoverito e in altri arricchito, acquista una struttura più regolare, una portata simbolica maggiore e una facilità a essere ricordato che il racconto originale non possedeva; in breve, esso si trasforma in un oggetto culturalmente esemplare e psicologicamente emozionante, che, dal momento in cui è adottato da una società, diventa per l'appunto un mito (Sperber, 1981, p. 78).
I miti dunque sono oggetti culturali rilevanti ed esemplari, adottati presumibilmente per la loro stessa rilevanza ed esemplarità. È questa un'interpretazione cognitivista del modo in cui la mente/cervello gestisce le informazioni che assumono forma di rappresentazioni mentali, alle quali gli interpreti, assumendo una prospettiva metarappresentazionale, attribuiscono un significato mitico-religioso. Vale la pena notare che agisce già qui uno schema teorico che verrà esplicitato in Sperber e Wilson (1995): le rappresentazioni mentali si formano e selezionano in accordo col principio economico del massimo effetto e del minimo sforzo. È anche interessante rilevare come, secondo la lettura sperberiana, l'idea di una trasmissione culturale che gestisce i propri contenuti economizzando rispetto alle capacità cognitive umane (semplicità, regolarità o simmetria, memoria) sia sostanzialmente già contenuta in Lévi-Strauss (Sperber, 1981, pp. 79-80).
Sviluppando la prospettiva epidemiologica, alternativa e avversaria alla memetica di Dawkins (1976), Sperber (1996) propone un'analisi materialista del dispositivo mitologico: ciò che chiamiamo mito è composto da tre categorie di oggetti o eventi materiali: narrazioni, storie, catene causali. Le narrazioni sono rappresentazioni pubbliche, ossia manifestazioni materiali (acustiche o scritte) delle storie; queste sono rappresentazioni mentali (conoscibili solo attraverso la loro rappresentazione pubblica) di eventi; le catene causali, infine, costituiscono il legame tra storie-narrazioni-storie-narrazioni, ecc. (Sperber, 1996, p. 32).
Il percorso del pensiero sperberiano sul mito si configura così dall'inizio alla fine come un netto oltrepassamento dello strutturalismo in direzione di una prospettiva cognitiva e materialista.
Religione? Naturale!
La ricerca dell'antropologo Pascal Boyer si inserisce pienamente nel solco della psicologia evoluzionistica, che è un innesto della psicologia cognitiva sul neodarwinismo (Barkow - Cosmides - Tooby, 1992). Anche per Boyer (2013) Lévi-Strauss è un predecessore «brillante e problematico» dell'antropologia cognitivista. E coerente con l'impostazione dei lavori di Sperber è anche la prospettiva di Boyer (1992) sulla trasmissione culturale delle credenze mitiche e religiose, intese come particolari forme di rappresentazione mentale e di narrazione. Boyer spiega le credenze mitiche e religiose partendo dall'ipotesi che esse siano sempre coerenti con i meccanismi della cognizione umana, che nella prospettiva della scienza cognitiva è l'insieme dei processi mentali pensabili come elaborazione di informazioni: dalla comprensione di una frase a un ragionamento logico, alla visione di una scena o all'ascolto di una musica. Anche la trasmissione culturale sottostà alla “benformatezza” delle storie: come hanno mostrato gli studi pionieristici di Bartlett (1932; 1923; 1958) le “buone” storie, cioè quelle ben costruite rispetto ai vincoli cognitivi, si ricordano meglio, e le narrazioni mitiche raccolte dagli antropologi sembrano conformarsi alle caratteristiche determinate negli esperimenti di laboratorio. Questo significa che nel processo di trasmissione della memoria mitica le narrazioni sono “formattate”, oppure vengono dimenticate: i miti e i riti tradizionali sono composti rispettivamente di storie e sequenze di gesti e azioni particolarmente memorabili (Boyer, 1992, p. 19).
Il contenuto delle credenze mitiche non avrà una variabilità indefinita perché le caratteristiche cognitive della mente umana costituiscono i vincoli di formazione, conservazione e trasmissione delle credenze stesse. Così, le idee religiose sono “naturali” (Boyer, 1994), ossia comprensibili e spiegabili all'interno di un'epistemologia naturalizzata (Quine, 1969).
Gli esseri umani si trasmettono nozioni religiose all'interno del proprio gruppo sociale. Secondo Boyer, però, la trasmissione reale delle credenze non corrisponde a un'immagine naive e semplicistica: acquisire rappresentazioni mentali non è un processo passivo e i bambini che imparano i contenuti religiosi della propria cultura filtrano attivamente tutte le informazioni dell'ambiente. Il paragone con l'apprendimento linguistico può essere illuminante: non si apprende la sintassi della lingua materna sulla base di stimoli espliciti, come voleva il comportamentismo, esizialmente criticato da Chomsky (1959), bensì in maniera complessa, naturale e inconscia (Bloom, 2000). Le regole di comportamento, invece, si apprendono per insegnamento esplicito, e non con la semplice osservazione degli esempi di interazione sociale. La matematica costituisce un caso diverso, che richiede un certo sforzo di apprendimento e dunque la relativa coscienza di apprendere qualcosa.
Non c'è dunque un unico modo di apprendere i contenuti che ci rendono culturalmente competenti, perché la disposizione del cervello umano ad apprendere può essere differente a seconda del dominio considerato: è naturale apprendere entro i sei anni la corretta sintassi e la fonetica della propria lingua, mentre le norme sociali vengono interiorizzate secondo un diverso ritmo. In tutti questi casi si ha disposizione ad apprendere perché si ha disposizione ad andare oltre la mera informazione presente nell'ambiente, come Chomsky (1959) ha messo per primo in evidenza relativamente al linguaggio (non si raggiungerebbe mai la competenza linguistica degli adulti se ciò dipendesse esclusivamente dalle informazioni ambientali: è l'argomento della “povertà dello stimolo”). La mente che acquisisce informazioni non è una tabula rasa (Pinker, 2006) bensì ha istruzioni innate per organizzare l'informazione e conferire senso a ciò che si osserva e impara, oltrepassando il mero dato informazionale. La mente effettua inferenze a partire dalle informazioni ambientali e le inferenze costruiscono concetti generali a partire dall'informazione frammentaria. Le inferenze sono naturalmente governate da principi (probabilmente innati) che fanno combinare il materiale concettuale in determinati modi, non in altri. […]
Che la religione sia un fenomeno culturale, come i gusti in fatto di cibo, musica, buone maniere e abbigliamento, non significa dunque che essa sia infinitamente variabile, come un malinteso culturalismo lascerebbe pensare; per gli antropologi cognitivi, anzi, che qualcosa sia culturale è proprio la ragione per la quale non varia oltre una certa misura. Che cos'è in definitiva la religione, nella prospettiva cognitiva di Boyer? È uno «spandrel», un fenomeno evoluzionistico parassitario dei moduli cognitivi della mente umana (Fodor, 1988; Sperber, 2001), com'è parassitario lo spazio risultante fra due archi in una basilica come quella di San Marco a Venezia: non ha una funzione precisa, ma la sua mancanza di funzione non è immediatamente visibile (Gould – Lewontin, 2001). Si noti che le spiegazioni evoluzionistiche che non assegnano una funzione evolutiva ad attività umane che oggi ci appaiono fondamentali sono abbastanza diffuse: Pinker (1997), per esempio, considera la musica alla stregua di una «torta alla panna uditiva», e anche per Sperber la musica è soltanto un «parassita evoluzionistico» (Levitin, 2008). La costruzione di concetti religiosi richiede dunque dispositivi cognitivi e capacità disparate insite nella natura della mente umana, che vengono reclutate dall'immaginazione religiosa. Ma, come per Gardner e Sperber, non c'è ragione di ipotizzare un modo speciale di funzionare della mente, dedicato particolarmente ai pensieri religiosi.