Ritorna in libreria il volume / Il pane selvaggio di Piero Camporesi
Il pane selvaggio di Piero Camporesi (1926-1997) riappare in libreria pubblicato dal Saggiatore, già editore di alcuni fondamentali classici della produzione dello stesso autore: La carne impassibile. Salvezza e salute tra Medioevo e Controriforma (1983); La terra e la luna. Alimentazione, folclore, società (1989); La miniera del mondo. Artieri inventori impostori (1990). Il volume di Camporesi fu pubblicato nel 1980 dalla casa editrice il Mulino a Bologna, città dove Camporesi era docente di Letteratura italiana da oltre un decennio presso l’Alma Mater Studiorum. Tre anni dopo, nel 1983, il libro conobbe una seconda edizione (che fu poi ristampata da Garzanti nel 2004), «riveduta e ampliata» e arricchita dell’Introduzione apparsa con il titolo Avant-propos à l’édition française del 1982 de Le Pain sauvage.
Dietro al titolo Il pane selvaggio, tanto fascinoso quanto inquietante, si apre l’inedito scenario di un «vissuto» che vede come protagoniste le «folle stracciate e affamate dei secoli moderni», in balia di Fame, Carestia, Malattia. Nel suo lungo raccontare «il dramma quotidiano» dei poveri, Piero Camporesi giunge al «paese dello stento e dell’indigenza» più estremi, posto alla stessa latitudine di quello appena attraversato ne Il paese della fame (1978). Lo studioso dell’alimentazione, del “popolare”, del “marginale”, declina il tema della “fame” a quello del “pane”, che viene a configurarsi come un «oggetto polivalente da cui dipendono la vita, la morte, il sogno».
Composto di diciannove capitoli, a partire da «La “miserabile malattia”» fino a «Il trionfo della povertà», il libro racconta gli effetti della Carestia sui poveri di villa e di città che si riassumono nella Fame, «miserabile malattia», «anticamera della morte», genitrice di fenomeni di antropofagia, coprofagia e autofagia dell’«uomo-bestia».
In Camporesi il pane diventa «soggetto culturale», che rappresenta «punto» e «strumento culminante, reale e simbolico, della stessa esistenza». Nella rappresentazione del pane prende forma in modo più evidente il «conflictus fra cultura alta e cultura bassa» che si profila «sub specie coquinaria» già nell’opera di Baldassarre Pisanelli (Trattato della natura de’ cibi e del bere, Bergamo, per Comino Ventura, 1587), a cui lo studioso dedica una delle sue pagine più sentite e strategiche per la ricomposizione dei rapporti tra “alto” e “basso”, tra elitario e “popolare”, tra ufficiale e subalterno. Il medico e astrologo bolognese diventa per Camporesi voce autorevole di quella parte della medicina che aveva teorizzato il «duplice regime nutritivo e dietetico […] a seconda delle differenze sociali: cibi adatti alle persone rustiche e cibi per gentiluomini, vietati ai primi»; che aveva, in tal modo, costruito e diffuso «tabù alimentari […] al servizio d’una ideologia di potere e di sopraffazione sociale» .
La diversificazione del regimen alimentare e sanitario trova nel libro di Camporesi la sua più esplicita «metafora» come «"pane da prìncipi e da gran maestri" e "pan da cani"», il «pane di formento» e il «pane di fava» (G.C. Croce), il pane nero, «maligno» e «ignobile», e il pane bianco. La dicotomia si rifletteva anche sulla farmacologia, quella per i ricchi e quella per i poveri (cap. 10: «Medicina pauperum»). Per tutti, poi, quando non risultavano efficaci i segreti medicinali, entrava in azione lo «stregone di Dio», l’esorcista.
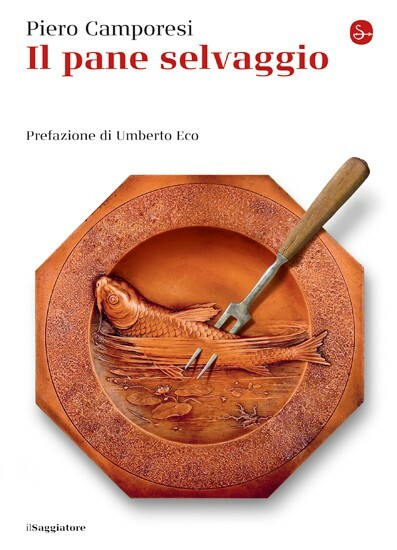
Il «pane selvaggio» è un «impasto polisemico denso di molteplici valenze», in cui la «funzione nutritiva» si amalgama con quella «terapeutica»; mentre la «suggestione magico-rituale» s’intreccia con quella «ludico-fantastica» per culminare in una rappresentazione «stupefattiva e ipnagogica» del reale, quando «il pane fuggente» (cap. 2), il pane negato dalle carestie e dalla miseria ritorna, “sardonico”, nelle vesti del «pane papaverino» (cap. 15), il pane «truccato» e «drogato», alloiato e alloppiato (tagliato con i semi del loglio o con i semi di papavero). È il pane «selvaggio di brughiera e di landa», il pane «sovventivo spontenascente succedaneo intero del pane ordinario», su cui nel XVII secolo «avevano lungamente elocubrato e meditato» intellettuali ed eruditi, religiosi e filosofi della natura come Ovidio Montalbani, fino a proporre miscele con un’ampia varietà di surrogati del frumento: dalla ghianda alla rapa, dalla gramigna alla coccola d’alloro, dal radicchio selvatico alle foglie dell’olmo, dai legumi ai cereali minori, come il miglio, il panico o il sorgo. Un pane dagli effetti leggermente «allucinogeni», studiato in età preindustriale secondo un preciso programma politico come rimedio eccezionale per intiepidire, se non spegnere del tutto, la fame dei poveri, «per contenere i furori della piazza», ma soprattutto per risospingere fuori dalle mura della città verso la terra e le erbe spontanee la «turba magna» «di miserabili, di irregolari, di paltonieri, di ammalati», di «mummie» (cap. 16-18).
Fame e carestia ingrossavano, infatti, le file di poveri, straccioni e vagabondi che si riversavano nello spazio protetto della civitas, quando la madre terra stremata dalla malignità delle stelle, dalle guerre e dalle calamità naturali, agonizzante non li nutriva più con i propri frutti. Nel XVII secolo, e non solo in Italia, fame e carestia rappresentavano malattie endemiche che divaricavano ancora di più le distanze tra città e campagna, tra i ceti sociali, tra la percezione del tempo di chi aveva il ventre pieno e quella di coloro che lo avevano vuoto (il giorno più lungo è quello in cui si sta senza mangiare, sentenziava Bertoldo). Disorientata e disordinata, mendica e accattona, “lesinante” e furfantesca, la folla suscitava disordini, alimentava sospetti che serpeggiavano nei palazzi del potere (cap. 7). Paure che s’ingigantivano nel «tempo di notte» signoreggiato dagli spiriti del male: tempo demonizzato dei «malandrini, malagenti e malandanti» (cap. 8). Fin dalla fine del XVI secolo, l’intolleranza degli addetti alla res publica, al governo della vita sociale e sanitaria, per i poveri, «putridi vermi» e «sordide lumache» (cap. 17), s’incanala verso i provvedimenti drastici della segregazione, del ricovero, dell’ospizio, «silos di temporanea misericordia per i pezzenti», secondo un processo che durante il XVII secolo si radica fino a portare, all’inizio del XVIII, al «trionfo della povertà», o – come osserva Camporesi –
«più correttamente» al «trionfo sulla povertà» (cap. 19).
Ne Il pane selvaggio si assiste alla rappresentazione di un paesaggio umano in bilico tra l’inferno del corpo e il paradiso della mente. Quando l’«invivibilità del reale» –
che non solo trovava compensazione ma alimentava anche utopie di riscatto sociale nelle mitologie popolari dei mondi artificiali, il mondo alla rovescia e il paese di cuccagna (cap.6) – diventava insostenibile e giungeva ai limiti della sopravvivenza; quando la fame instupidita e incantata dal pane alloppiato aggrediva «l’igiene mentale», allora si scatenavano «deliri tossici», «vertigini collettive». Allora le menti si annullavano in «sogni iperbolici», decollavano verso «paradisi artificiali», naufragavano in tregende demoniache (cap. 12-13).
Alla sua pubblicazione, Il pane selvaggio bucò lo schermo della produzione saggistica italiana: ebbe risonanza non solo in ambito accademico nazionale e internazionale, ma attirò anche l’attenzione dei media, della stampa e degli intellettuali. Contribuì alla nascita del “fenomeno” Camporesi” per il quale gli studi camporesiani furono proiettati in uno scenario culturale internazionale: nell’arco del decennio successivo alla sua uscita, il volume fu, infatti, tradotto in francese (1981), spagnolo (1986), inglese (1989), portoghese (1989) e tedesco (1990). La stessa fortuna editoriale accolse altri libri scritti in seguito dallo studioso romagnolo.
Come tutti gli autori di successo, Camporesi ebbe ammiratori e detrattori: questi ultimi si schierarono soprattutto sul fronte dell’Accademia. Mentre gli italianisti in genere preferirono velare il dissenso e celare l’imbarazzo per quel professore che deragliava dai binari della letteratura canonica sotto la retorica del silenzio; furono soprattutto gli storici tout court a far sentire le loro voci, verba e scripta, contrarie al metodo di quell’italianista che oltrepassava i confini “disciplinari” per fare storia a modo suo. Del resto Camporesi, proprio nel Pane selvaggio, era stato palesemente provocatorio quando, a proposito delle fonti da lui citate – testi che egli definiva “non propriamente letterari” – constatava come esse fossero «troppo ingiustamente non sfruttate dai pur benemeriti ricercatori d’archivio che talvolta cadono nell’illusione pseudoscientifica che una serie di dati più o meno giusti, più o meno comprensibili, siano più veri (e perciò più affascinanti) d’una pagina a stampa».
Piero Camporesi che «appartiene alla generazione degli scrittori anticlassici, nata negli anni XX» del Novecento, fu allievo di Carlo Calcaterra e compagno di studi di Ezio Raimondi. La sua formazione intellettuale va oltre il crocianesimo: ha alle spalle la Scuola storico filologica, la tradizione di studi ottocentesca non solo del «Giornale storico della letteratura italiana», ma anche dell’«Archivio per lo studio delle tradizioni popolari» di Giuseppe Pitrè, il dibattito sul “folclore” e l’antropologia, tutto rivisitato e studiato alla luce delle idee sospinte verso la penisola dal vento parigino degli storici delle «Annales».
Rileggere oggi Il pane selvaggio alla luce della complessiva produzione saggistica dell’autore, consente di comprendere meglio l’iter di quell’italianista che, nato filologo e critico letterario (negli anni Cinquanta e Sessanta aveva studiato autori del canone come Francesco Petrarca, Ludovico di Breme, Vittorio Alfieri), a partire dal 1970 con l’edizione einaudiana dell’Artusi diviene nel corso degli anni e a seconda delle definizioni «uno storico sociale», «uno storico-antropologo» («dicono a nord delle Alpi»), un «antropologo della cultura popolare» (P. Camporesi), un «antropologo culturale» (U. Eco), uno «storico-scrittore oltre che scrittore-lettore» (M. Belpoliti). Già nel 1980, con Il pane selvaggio, si era compiuta la straordinaria metamorfosi di Camporesi in «academico di nulla academia», il tratto distintivo e inconfondibile del proprio autoritratto culturale ripreso da Giordano Bruno e tracciato, specchiandosi alla saggistica del tempo, nella dedicatoria «al lettore» che apre Il governo del corpo (1995, due anni prima della sua scomparsa).
Rileggere un “classico” come Il pane selvaggio a distanza di trentasei anni dalla sua uscita e dopo diciannove dalla scomparsa dell’autore, significa riscoprire le potenzialità del testo, la complessità delle tematiche, l’unicità del metodo compositivo, la magia della scrittura; riflettere sulla ricerca scientifica camporesiana così intimamente intrecciata alla didattica: il libro è dedicato «Ai miei studenti». E, come accade per i classici, la cui rilettura ne scopre ogni volta aspetti di grande attualità, così il “pane selvaggio” dell’età moderna rinvia al “pane selvaggio” dell’inizio del secondo millennio, che non sarebbe certo sfuggito all’occhio critico costantemente fisso sul presente di Camporesi. Lo sguardo verso il passato dell’Europa d’ancien régime getta luce sull’oggi di un continente alle prese con fenomeni epocali di migrazioni di massa di disperati, dove l’antico confine tra città e campagna sembra separare oggi continenti e stati, terre e mari; dove le mura cittadine risorte in muraglie di lamiera e ritorte in gineprai e spirali di filo spinato tra stato e stato, sono corone di spine che fendono la terra e feriscono le carni vaganti alle frontiere; e i ricoveri di straccioni e di vagabondi che sancivano il trionfo del potere sulla povertà fanno pensare ai centri di umana accoglienza e di protezione che arrestano il cammino di fuggitivi, hotspots che soffocano speranze e sogni di una vita lontana dalla guerra e dalla fame.







