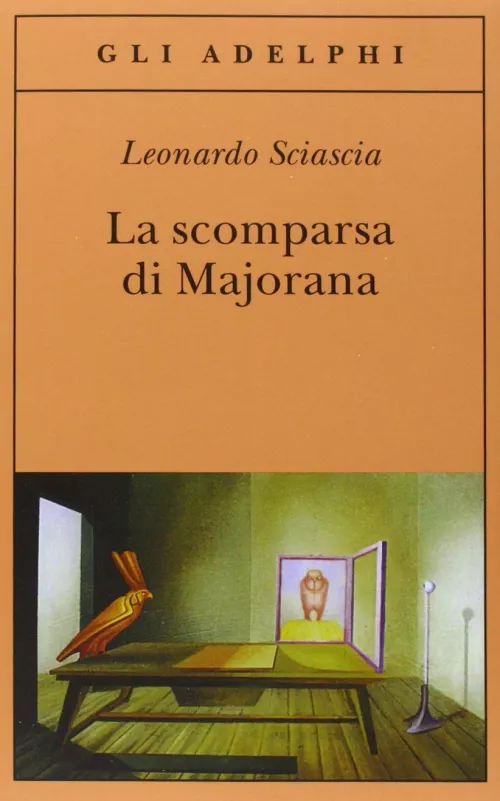Speciale
20 novembre 1989 / Leonardo Sciascia, La scomparsa di Majorana
Sono trascorsi 30 anni dal 20 novembre 1989, giorno in cui Leonardo Sciascia ci ha lasciati, trent'anni in cui il paese, che lui ha così bene descritto, è profondamente cambiato, eppure nel profondo è sempre lo stesso: conformismo, mafie, divisione tra Nord e Sud, arroganza del potere, l'eterno fascismo italiano. Per ricordare Sciascia abbiamo letto in questo anno i suoi libri: una scoperta per chi non li ha ancora letti e una riscoperta e un suggerimento a rileggerli per chi lo ha già fatto. Lo ricordiamo oggi con il suo La scomparsa di Majorana, ma cliccando qui è possibile leggere la raccolta completa.
Venerdì 25 marzo 1938, il trentaduenne Ettore Majorana, da pochi mesi professore di Fisica teorica per meriti eccezionali presso l’Università di Napoli, invia una lettera al direttore dell’Istituto, prof. Carelli: “… ho preso una decisione che era ormai inevitabile. Non vi è in essa un solo granello di egoismo, ma mi rendo conto delle noie che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti”. Il mistero della scomparsa sollecita lo spirito da “investigatore di Dio” (così lo definirà l’amico Gesualdo Bufalino) di Leonardo Sciascia, anche in seguito alla pubblicazione, il 1° giugno del ‘75 su La Stampa, di alcune lettere inedite. L’epistolario, insieme ad altri documenti e testimonianze, sarà poi posto in appendice a Il caso Majorana che Ernesto Recami pubblica nel 1987 per Arnoldo Mondadori (una versione ampliata compare nel 2008 per l’editore Di Renzo). Sciascia compone per il quotidiano torinese una serie di articoli che escono tra il 31 agosto ed il 7 settembre, con il titolo “giallo filosofico”, per poi confluire in La scomparsa di Majorana, contro-indagine stretta fra Gli atti relativi alla morte di Raymond Roussel del ’71 e L’Affaire Moro del ’78.
La lettera prega poi Carelli di perdonarlo e di ricordarlo a quanti ha conosciuto all’Istituto di cui “conserverò un caro ricordo almeno fino alle undici di questa sera, e possibilmente anche dopo” (Sciascia aveva inizialmente pensato di dare al libro il titolo “E possibilmente anche dopo”). Sul tavolo della camera d’albergo Majorana lascia anche una busta ‘Alla mia famiglia’: “Ho un solo desiderio: che non vi vestiate di nero […] Dopo ricordatemi, se potete, nei vostri cuori e perdonatemi – aff.mo Ettore”. Ritira gli stipendi dei cinque mesi d’insegnamento e porta con sé il passaporto, due elementi che appaiono stridenti con la volontà suicida. Sale sul piroscafo che fa servizio da Napoli a Palermo, ma da qui spedisce a Carrelli un’altra lettera in cui scrive: “Il mare mi ha rifiutato”. Aggiunge che tornerà il giorno dopo a Napoli, ma che ha intenzione di rinunciare all’insegnamento. Durante il tragitto per mare o poco dopo, scompare, anche se incerte testimonianze lo vorrebbero presente a Napoli nei giorni successivi.
Al brutale buonsenso degli inquirenti il caso sembra rientrare in una tipica scomparsa con proposito di suicidio. “Negli occhiali di un funzionario di polizia”, la volontà di scomparire di Majorana non può avere altra ragione che la pazzia: “la scienza, come la poesia, si sa che sta ad un passo dalla follia: e il giovane professore quel passo lo aveva fatto, buttandosi in mare o nel Vesuvio o scegliendo un più elucubrato genere di morte”. Anche Fermi, il “papa” dei ragazzi di via Panisperna, il gruppo di giovani fisici formato a Roma nel ’27-28, interviene presso il senatore Giovanni Gentile e lo stesso Mussolini per chiedere di intensificare le ricerche. Ritiene che Majorana, per la profondità e il rigore dell’ingegno, sia “il più grande fisico teorico dei nostri tempi” e che vada annoverato fra la ristrettissima cerchia dei geni, accanto a Galilei e Newton. Ma nel luglio del ’38 viene pubblicato Il Manifesto della razza ed il regime ha qualche imbarazzo con lo scienziato che, sposato con una donna ebrea, già si prepara ad emigrare negli Stati Uniti dopo aver ricevuto nel dicembre del ’38 il Nobel, senza fare il saluto romano.
L’ipotesi del suicidio è rimasta a lungo quella più probabile, trovando conferma nella testimonianza, riportata da Bruno Russo (Ettore Majorana. Un giorno di marzo, Flaccovio, 1997), del fisico sperimentale Giuseppe Occhialini, in cui rievoca l’unico incontro che ebbe con Majorana poco prima della scomparsa. Quest’ultimo gli avrebbe detto: “Hai fatto appena in tempo ad arrivare, perché se avessi tardato di qualche settimana non mi avresti più incontrato”, per poi aggiungere: “… ci sono persone che ne parlano, e ci sono delle persone che lo fanno”. La tesi del suicidio trova sostegno nei tratti del carattere di Ettore: riservato fino ad apparire ruvido, spirito introverso ed ombroso, con tratti nevrotici (c’è chi ha proposto una diagnosi di autismo). A questo si aggiunge la volontaria clausura degli anni fra il ’34 e il ’37, anni in cui si accentua l’interesse per temi filosofici, in particolare per l’opera di Schopenhauer. Il filosofo del pessimismo “rinunciatario”, per dirla con Nietzsche, condanna il comune suicidio per disperazione, quello che, invece di opporsi alla Volontà cieca che governa il mondo, esprime solo malcontento per le condizioni che la sorte ha deciso di darci, ma riconosce legittimità al suicidio di chi sceglie di non vivere perché ha smesso anche di volere.
Il numero di ipotesi sull’enigma della scomparsa negli ultimi decenni non ha fatto che crescere. Negli anni Settanta, ci fu chi riconobbe Majorana in un clochard girovago nel territorio trapanese, che si diceva abile matematico. Spettò a Paolo Borsellino (allora procuratore di Marsala) appurare attraverso una perizia calligrafica che il vagabondo era in realtà un ex galeotto. Guadagnò poi consensi l’ipotesi che Majorana, lasciando credere di essersi tolto la vita, fosse andato in Germania (consenziente o obbligato) per collaborare con gli scienziati impegnati nel progetto della “bomba atomica” del Terzo Reich. Il giovane fisico nel ’33 aveva trascorso alcuni mesi all’istituto di Fisica di Lipsia, posto, dirà con l’abituale ironia, “in una posizione ridente […], fra il cimitero e il manicomio”. Qui aveva collaborato proficuamente con Werner Heisenberg, a cui sarà poi affidato il ruolo direttivo nel progetto nazista. Le piacevoli chiacchierate, le discussioni scientifiche e le partire a scacchi, in cui eccelleva fin da bambino, segnalano un cambio di carattere rispetto al giovane ombroso che avevano conosciuto i colleghi di via Panisperna. Il che si spiega, suggerisce Sciascia, con il comune sentire, in quanto “Heisenberg viveva il problema della fisica, la sua ricerca di fisico, dentro un vasto e drammatico contesto di pensiero. Era, per dirla banalmente, un filosofo”. Nelle conversazioni segretamente registrate dagli Alleati, a guerra finita, a Farm Hall in Inghilterra, dove gli scienziati tedeschi impegnati nel progetto dell’atomica (rimasto alla fase embrionale) vengono “ospitati”, nessuno accenna a Majorana. Altri hanno suggerito che, alla conclusione delle ostilità, il fisico catanese abbia trovato rifugio in Sud America, magari assieme a gerarchi nazisti: c’è chi lo riconosce nell’uomo che, in una foto sul ponte di una nave in partenza per l’Argentina, sta accanto ad Eichmann. Sette anni di indagini, riaperte nel 2008 dalla Procura di Roma, in base alle rivelazioni di un immigrato italiano in Venezuela alla trasmissione di RaiTre “Chi l’ha visto?”, hanno ritenuto compatibili i tratti del giovane fisico con quelli di un cinquantenne ritratto in una foto degli anni Cinquanta, anche sulla base di una perizia del RIS. Disponiamo dunque anche di una “verità giudiziaria” contestata con buone motivazioni dagli eredi. Il pronipote di Majorana, Stefano Roncoroni, ha di recente proposto la scomoda “verità familiare”, a lungo taciuta (Ettore Majorana lo scomparso e la decisione irrevocabile, Editori Riuniti, 2013). All’origine del proposito suicida, realizzato nel ’39, starebbe soprattutto l’omosessualità repressa che ne segnava profondamente l’infelicità irrimediabile.
La “verità letteraria” di Sciascia scarta le tesi ufficiali del suicidio e della follia, propende per l’ipotesi che il giovane scienziato abbia organizzato la sua scomparsa “come una minuziosamente calcolata e arrischiata architettura”, per non collaborare all’avvenire distruttivo intravisto nelle ricerche atomiche. Nato nella Sicilia in cui “l’assenza se non il rifiuto della scienza era diventata forma di vita”, già l’essere scienziato doveva costituire una dissonanza di cui Majorana avvertiva l’angoscioso “peso di morte”: la “manciata di polvere” del verso della Terra desolata di Thomas S. Eliot citato da Sciascia si è fatta “manciata di atomi”, fino a provocare lo “sgomento religioso” che lo induce a far perdere le sue tracce. L’idea non era del tutto nuova. Nel 1972, la RAI aveva mandato in onda il film Ipotesi sulla scomparsa di un fisico atomico, regista e sceneggiatore Leandro Castellani, in cui l’origine dello sconforto di Majorana veniva indicata nella visione premonitrice delle ricerche atomiche.
Nessuna polizia avrebbe potuto vincere “contro un uomo intelligentissimo che aveva deciso di scomparire”, suggerisce Sciascia, col conforto di un’analoga osservazione di Fermi. Bergotte, nella Recherche di Proust, giudica il professore Cottard un imbecille, il che non gli impedisce di essere un buon medico, ma non per curare le malattie che colpiscono gli artisti e le persone intelligenti; il medico ha previsto la difficoltà di digerire le salse, ma non ha previsto la lettura di Shakespeare. E come aveva scritto Edoardo Amaldi, uno dei “ragazzi” di via Panisperna, che aveva pubblicato nel ‘66 La vita e l’opera di Ettore Majorana (Accademia dei Lincei), “Prediligeva Shakespeare e Pirandello”; la frase, posta in esergo al libro, sarà ricordata nell’Alfabeto pirandelliano del 1989. Come Mattia Pascal e Vitangelo Moscarda di Uno, nessuno e centomila, Majorana si affida non alla morte ma ad una condizione postuma realizzata in vita, mette in scena la sua assenza dal mondo. Riesce così a farsi invisibile agli altri, attinge una “condizione in cui dimenticare, dimenticarsi ed essere dimenticato”, per non assumere il carico degli interrogativi angoscianti della scienza emergente. Solo così, imitando la sorte dei personaggi di Pirandello, Majorana poteva finalmente riuscire ad essere un “uomo solo”: scomparendo fa valere le ragioni del singolo rifiutando il ruolo che la società gli impone. La stessa formula, “uomo solo”, Sciascia la riprenderà nella successiva inchiesta del ‘78, mirando a risalire dal personaggio alla persona del leader della DC. Nel corso della prigionia, “Moro comincia, pirandellianamente, a sciogliersi dalla forma, poiché è entrato nella vita. Da personaggio a ‘uomo solo’, da ‘uomo solo’ a creatura: i passaggi che Pirandello assegna all’unica possibile salvezza”. Alla forma impostagli dalla funzione di uomo di potere, Moro sfugge solo in prigionia, ritrova la vita proprio quando su di lui incombe la condanna a morte. Majorana ritrova la vita, ancora non formata, decidendo di venir meno agli obblighi imposti dal suo ruolo di scienziato.

Nel gioco delle ricerche, un solo detective avrebbe potuto ingaggiare la partita con la metis del giovane fisico, quell’Auguste Dupin di Edgar Allan Poe a cui Sciascia dedica particolare attenzione nella Breve storia del romanzo poliziesco (Cruciverba, ora anche in Il metodo di Maigret). Il modello a cui Sciascia aspira è il racconto di Edgar Allan Poe, Il mistero di Marie Roget, in cui la verità letteraria indica la via alla verità giudiziaria. Dupin, affidandosi solo agli articoli apparsi sui giornali, scarta le ipotesi formulate dagli inquirenti ed indica la traccia da seguire: la finzione razionale dello scrittore scorge la realtà oggettiva che finirà solo dopo per svelarsi alla polizia. In un mondo dominato dalla menzogna, la letteratura è parsa a Sciascia l’unica in grado di dire la verità, come Marco Belpoliti ha persuasivamente mostrato nel capitolo d’esordio di Settanta (Einaudi, 2001). Ma venuta meno la fiducia neorealistica delle Parrocchie di Regalpetra, come pure l’ideale illuministico di una verità raggiungibile, di cui il giallo costituisce il monumento eminente, il deciframento della realtà è necessariamente incompiuto, ed è il testo nella sua ambiguità ad assurgere in primo piano. La verità che la scrittura conquista non è “rappresentazione”, nel senso del rispecchiamento, della mimesi di una realtà oggettiva, torna ad essere aletheia, svelamento di quanto si cela nell’impostura delle carte. È la coerenza della ricostruzione narrativa che può riscattare un mondo da cui la verità è fuggita. La prospettiva di Sciascia è in tal senso prossima a quella che Pasolini indicava, nel novembre del ’74, nel famoso articolo sulle stragi del “Corriere della sera”; spetta all’intellettuale svelare i nomi dei responsabili materiali e dei mandanti dei tentati golpe e degli attentati avvenuti in Italia a partire dalla strage di Piazza Fontana, dei vecchi fascisti ideatori e dei nuovi fascisti responsabili della “strategia della tensione”. “Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace; che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, la follia e il mistero”.
È nei libri, nei testi scritti che si ritrova quell’intreccio di coincidenze, di corrispondenze, che scandiscono l’ordito coerente della realtà. “Lasciata, insomma, alla letteratura la verità, la verità – quanto dura e tragica apparve nello spazio quotidiano e non fu più possibile ignorarla o travisarla – sembrò generare dalla letteratura”, scrive Sciascia nell’Affaire Moro. Nell’articolo sulla scomparsa delle lucciole del “Corriere”, poi raccolto in Scritti corsari, Pasolini diceva di ritenere Moro, nel cui linguaggio era avvertibile la trasformazione in senso tecnologico e performativo del potere, “il meno implicato di tutti (per una enigmatica correlazione) nelle cose orribili che sono state organizzate dal ’69 ad oggi, nel tentativo, finora formalmente riuscito, di conservare comunque il potere”. Ancor più per Sciascia, sono appunto correlazioni quelle di cui lo scrittore detective va in cerca: “Poiché la nostra giornata è fatta, come tutta la vita, di misteriose rispondenze, di sottili collegamenti”, scrive in Nero su nero. La “letteratura (che per me, e ne ho avuto piena coscienza da quando ho finito di scrivere sulla scomparsa di Majorana, è la più assoluta forma che la verità possa assumere)”, mira dunque ad individuare di volta in volta “l’ordine delle somiglianze”, restituire un senso alle coincidenze.
Ed eccola una prima misteriosa “rispondenza” a proposito della sorte di Majorana, quasi una promessa della verità cercata. Sciascia si reca a visitare un convento, la Certosa calabrese di Serra San Bruno, dove, si diceva, fra i padri in meditazione si trovava nel dopoguerra “un grande scienziato”. Oltre a Majorana, in quel chiostro solitario avrebbe trovato rifugio, stando ad un’altra “diceria”, un membro dell’equipaggio del B-29, preso dai rimorsi dopo aver sganciato la bomba su Hiroshima. Le rovine di Troia, aveva scritto Alberto Savinio, erano quelle scoperte da Schliemann perché, durante la Grande guerra, erano state cannoneggiate dal cacciatorpediniere inglese Agamennone. “I nomi, non che un destino, sono le cose stesse”, scrive Sciascia; in tutto “è ‘razionale’ mistero di essenze e rispondenze, continua e fitta trama […] di significati”. Nel momento in cui ha ricevuto notizia delle presenze convergenti in quel convento, è come se avesse avuto “una esperienza di rivelazione”, metafisica e mistica, “la razionale certezza che, rispondenti o no a fatti reali e verificabili, quei due fantasmi di fatti che convergevano su uno stesso luogo non potevano non avere un significato”.
Nella visita alla “cittadella dei certosini”, fra “lunghi e deserti corridoi […] celle vuote […] ingiallite e tarlate acqueforti”, Sciascia avverte “un senso di dissolvimento e di irrealtà, come di un sogno quando si sa di sognare”. La parola passa ora da Pirandello a Shakespeare e la memoria recupera due battute di Prospero nella Tempesta (atto IV) e le fissa “come tra nude pareti”: “La turpe cospirazione del bestiale Caliban contro la vita, mi è passata di mente”, e poi il finale famoso, il dissolversi nell’aria sottile di attori e addobbi dello “spettacolo senza corpo” che si è svolto sulla scena, e con essi della realtà intera nel gran “teatro del mondo”: “Noi siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, circondata dal sonno è la nostra breve vita”. Sono queste citazioni a muovere le considerazioni finali del libro: “qualcuno qui, in questo convento, si è forse salvato dal tradire la vita tradendo la cospirazione contro la vita, ma la cospirazione non si è spenta per quella defezione, il dissolvimento continua, l’uomo sempre più si disgrega e svanisce in quella stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E non è già un sogno di quel che l’uomo ‘era’ l’ombra rimasta come stampata su qualche brandello di muro, a Hiroshima?”.
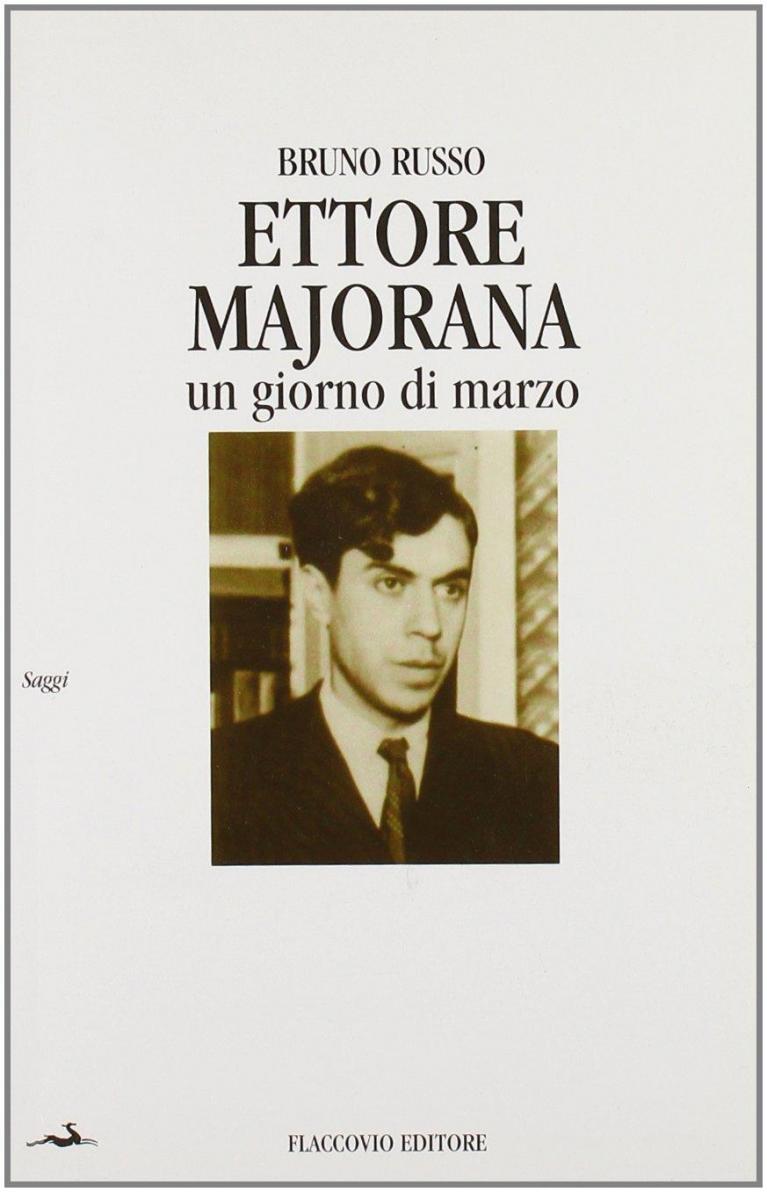
A differenza di Fermi e dei ragazzi di via Panisperna che cercavano e volevano raggiungere la scienza, Majorana la scienza la portava, quasi fosse una funzione vitale a cui adempiere, pur controvoglia. Pensa e calcola sul pacchetto di sigarette Macedonia, subito gettate, teorie che poi ad altri varranno il premio Nobel, ma forse, suggerisce Sciascia, sotto l’apparente gusto mistificatorio e teatrale, agiva l’istinto di conservazione, non solo per sé, ma per la specie umana. Avendo “precorso lo sgomento religioso cui vedremo arrivare la scienza, se già non c’è arrivata”, non poteva far altro che isolarsi, sottrarsi al compimento dell’opera che da lui si attendeva. La nostra scienza è nata ad Hiroshima, ha scritto Michel Serres. In quel punto d’impluvio della scienza classica, la messa a morte della natura, conquistata e soggiogata, è passata dal locale al globale: la capacità d’intervento della tecno-scienza non si limita più ad agire su spazi ridotti e per un tempo limitato, mette a rischio la sopravvivenza stessa dell’umanità e della Terra. La scienza si è posta dal lato della morte, scriveva Serres in un saggio del 1972 (“Tradimenti”, di cui si può trovare un estratto nel volume monografico di “Riga” dedicato al filosofo francese). Siamo entrati nel tempo della Thanathocrazia, la scienza collabora con il Ministero della Morte, si è sottomessa alla logica di Marte, lavora per costituire arsenali nucleari nel fragile equilibrio del terrore fra le superpotenze.
Quando Heisenberg, nel 1932, pubblica la teoria sulla struttura del nucleo, Majorana, che già ne aveva già comunicato ai colleghi le linee salienti, non ne è dispiaciuto, anzi gli è quasi grato, come se Heisenberg l’avesse salvato da un pericolo, “gli ha come evitato un sacrificio”, sostiene Sciascia. Anche la storia delle scienze sembra obbedire alla logica per cui la situazione di crisi, che prelude al faticoso emergere di un nuovo paradigma, richiede una vittima sacrificale, secondo il meccanismo del capro espiatorio studiato da René Girard per la storia delle religioni. La crisi degli irrazionali fra i Pitagorici della Magna Grecia porta alla condanna a morte di Ippaso di Metaponto che avrebbe rivelato il segreto della scoperta; “e fa commettere al testo di Platone un parricidio abbastanza famoso, l’uccisione di Parmenide”, scrive Serres nel Passaggio a Nord-Ovest (Pratiche, 1983). Archimede in Sicilia viene ucciso da un soldato romano all’assedio di Siracusa, mentre delinea una geometria connessa alle tecniche dell’ingegnere, diversa da quella dimostrativa di Euclide. Le crisi della scienza vengono scandite dal sacrificio di una vittima per esorcizzare la violenza, dal ricorso al sangue o dalla caduta nella follia: Galileo in carcere, Bruno sul rogo, Lavoisier alla ghigliottina, Galois in duello, Lazare Carnot esiliato. E la fisica atomica va dal suicidio triestino di Boltzmann alla bomba di Hiroshima, passando attraverso la scomparsa di Majorana, “una vittima della scienza”, come la madre aveva scritto nella lettera a Mussolini. Nel cuore della scienza, si rinnova periodicamente il ritorno alle origini, presso la piramide egizia misurata da Talete, sepolcro di lapidazione: episteme non dimentica la parentela con epistema, il cippo funerario.
La pubblicazione del libro fu motivo di polemiche in particolare sulle pagine de “L’Espresso” con Edoardo Amaldi. Sciascia puntualizza di non aver detto che il giovane fisico avesse potuto intuire nel ’34, da esperimenti a cui non partecipò, il futuro di potenzialità distruttive poste nelle mani dei fisici delle particelle. “Quel che mi pare certo è che Majorana ha avuto a un certo punto paura della scienza e di se stesso in quanto scienziato”. Emilio Segré, nella sua biografia di Fermi (Enrico Fermi, fisico, Zanichelli, 1971), scrisse che “Dio, per i suoi intenti imperscrutabili, ci rese allora tutti ciechi di fronte al fenomeno della fissione”. In realtà non tutti, ricorda Sciascia sulla scorta di Robert Jungk, Gli apprendisti stregoni. Storia degli scienziati atomici, (1958, Einaudi). Già sul finire del ’33, il fisico ungherese Leo Szilard intuisce la possibilità di ottenere una reazione a catena bombardando con neutroni l’uranio, senza però mai compiere l’esperimento. Ida Noddack comunica al gruppo romano, nel settembre del ’34, la corretta lettura degli esperimenti: nella fissione dei nuclei di uranio si produce una quantità di energia un milione di volte superiore a quella della combustione.
Quel che preme a Sciascia è la questione della responsabilità degli scienziati ed in tal senso diventa discriminante il confronto fra la scelta di Majorana e quella compiuta dagli scienziati del “modo libero” che parteciparono al progetto Manhattan per la costruzione della bomba atomica. Pressoché nessuno espresse preoccupazione o angoscia per le ricerche e in modo irresponsabile essi consegnarono la bomba ai politici e ai militari, raccomandando di farla esplodere su città “scientificamente” scelte. L’intero “progetto Manhattan”, che vide Fermi in primo piano, evoca per la sua struttura, per la sua funzionale razionalità, “immagini di segregazione e schiavitù” analoghe a quelle dei campi di annientamento hitleriani, scrive Sciascia. Anche a Los Alamos, nel maneggiare la morte, “si è dalla parte della morte e nella morte”. Oppenheimer, che è “uscito da Los Alamos annientato quanto un prigioniero ‘collaborazionista’ dal campo di sterminio di Hitler”, fu tra i pochi ad aver riconosciuto la responsabilità che gravava sugli scienziati. “I fisici hanno conosciuto il peccato”, dirà dopo il lancio della bomba su Hiroshima, e in occasione del primo test aveva ripreso una citazione dal Bhagavadgita: “Sono diventato Morte, il distruttore di mondi”.
“A cena con un fisico. Sto in silenzio ad ascoltare i suoi discorsi sulla scienza. Turbato in principio, poi annientato. Uscendo, mi trovo a ripetere la frase di Matteotti appena sceso dal treno che lo riportava dalla Russia (o ricordo male?): ‘Orrore, amici miei, orrore’” scrive Sciascia in Nero su nero (1979). Il chimico Primo Levi proponeva di estendere anche agli scienziati, fisici e biologi, un giuramento analogo a quello di Ippocrate sottoscritto dai medici. Nel Dialogo con Tullio Regge (1984) ricordava al fisico affermato, che aveva avuto modo di collaborare con Heisenberg negli anni Cinquanta: “I veri padroni del mondo siete voi; dipende da voi che cosa avverrà del genere umano nei prossimi anni. Il potere che avete è sterminato: capite più cose dei profani, e l’energia è tutta nelle vostre mani, nei suoi due aspetti, quella benefica ed inesauribile (dovrebbe diventare quasi gratuita, no?) della fusione nucleare e quella delle testate che cavalcano i missili intelligenti”. Giorgio Agamben, integrando la proposta di Sciascia, ha indicato l’origine della paura del giovane fisico nella consapevolezza che la scienza non si pone più l’obiettivo di conoscere la realtà quanto quello di “comandare”, cioè di intervenire su di essa per governarla (Che cos’è reale? La scomparsa di Majorana, Neri Pozza, 2016). Nella “commedia nera” di Friedrich Dürrenmatt (anch’egli lettore di Robert Jungk), I fisici (1962), tra finti scienziati assunti dai servizi segreti e ricoverati in manicomio, spetta al geniale Möbius la rinuncia alla scienza. Ai suoi occhi la libertà della ricerca rischia di essere un alibi deresponsabilizzante e la sottomissione alla politica di potenza una scelta di comodo e suicida. L’unica soluzione è rinunciare alla ricerca che conduce a scoperte letali, revocare il proprio sapere, chiudersi in manicomio, scegliere pirandellianamente, la maschera della follia, per non correre il rischio che il mondo diventi un manicomio: “oggi è il dovere del genio, restare misconosciuto”.