Speciale
Leggere "Palomar"
“Nasce un nuovo personaggio: il signor Palomar. Forse dandogli il nome di un famoso osservatorio astronomico Italo Calvino ha voluto significare che la realtà contemporanea, la natura e gli atteggiamenti umani sono guardati come da un lontano attento telescopio”. Così si legge il 1°agosto 1975 sulla terza pagina del “Corriere della Sera”, in un trafiletto anonimo, ma certamente dello stesso Calvino. La rubrica “L’osservatorio del signor Palomar” conterà fra il ’75 e il ’77 trentasei avventure, altre seguiranno su “la Repubblica” fra l’80 e l’82. Palomar, che ne raccoglierà ventisette, sarà edito nel 1983, due anni prima della morte improvvisa dell’autore, preannunciata nell’ultima riga del libro, nel capitolo “Come imparare a essere morto”. Già il nome del personaggio manifesta la passione del vedere; il suo sguardo da “scrutatore” si concentra su fenomeni e oggetti circoscritti e concreti – un’onda, un prato, le stelle, un geko, una coppia di tartarughe, un giardino zen, ecc. – di cui cerca di offrire un’accurata descrizione. Palomar ha decisamente i tratti di carattere di Calvino: silenzioso e riservato, d’indole schiva con una punta di malinconia. La sua riflessione è pacata, per nulla assertiva o sapienziale; il tono argomentativo sembra richiamare, non senza ironia, modelli filosofici, un’istanza critica che renda conto della nostra “dubitosa sapienza” – è la formula che Calvino utilizza nel recensire, su “La Repubblica” nel giugno del 1981, La ricerca delle radici dell’amico Primo Levi.
A dieci anni di distanza dalle Città invisibili, la sua opera forse meno visuale, è allo sguardo del signor Palomar che Calvino affida l’impresa conoscitiva che muove la sua scrittura: il suo ideale di “letteratura come filosofia naturale” mira a offrire “una mappa del mondo e dello scibile” (Scienza e letteratura, 1968, poi in Una pietra sopra), nell’intento di organizzare l’insieme disperso dei dati del mondo. Il progetto è chiarito in un brano incluso nel capitolo “Il mondo guarda il mondo”, la prima delle tre Meditazioni di Palomar che chiudono il libro; è il momento in cui il protagonista ha deciso di abbandonare il ricorso a modelli mentali da sovrapporre a quel il mondo offre al suo sguardo e di accogliere “i richiami che gli arrivano dalle cose”. “In seguito a una serie di disavventure intellettuali che non meritano d’essere ricordate, il signor Palomar ha deciso che la sua principale attività sarà guardare le cose dal di fuori. Un po’ miope, distratto, introverso, egli non sembra rientrare per temperamento in quel tipo umano che viene di solito definito un osservatore. Eppure gli è sempre successo che certe cose – un muro di pietre, un guscio di conchiglia, una foglia, una teiera – gli si presentino come chiedendogli un’attenzione minuziosa e prolungata; egli si mette ad osservarle quasi senza rendersene conto e il suo sguardo comincia a percorrere tutti i dettagli, e non riesce più a staccarsene”. A differenza del Monsieur Teste del cartesiano Paul Valéry – uno dei riferimenti letterari che ispirano Palomar, insieme a Francis Ponge (“il Lucrezio del nostro tempo”), autore di piccoli poemetti in prosa su oggetti d’uso quotidiano come una saponetta, e il Leopardi delle Operette morali –, Palomar si sforza di aderire alla concretezza delle cose, sembra rinnovare con altri mezzi il proposito (in gran parte smarrito) che era stato della fenomenologia husserliana: “Tornare alle cose stesse”.
Per colmare il vuoto che si stende fra l’occhio e l’oggetto non si può ricorrere al fucile, l’oggetto magico e fiabesco nelle mani del ragazzo dalla mira infallibile del racconto Ultimo viene il corvo (1949). Chi come Calvino non ha mai avuto dubbi sulla corposa realtà del mondo nemmeno può accogliere forme di idealismo pronte a immergere la realtà nel buco nero del soggetto. Il brano più filosofico di Palomar, La spada del sole, s’interroga sullo statuto di realtà del riflesso che si forma sul mare al calare del sole, quel triangolo dorato che giunge allo sguardo del nuotatore. Nel prendere in esame le diverse ipotesi gnoseologiche in merito, Calvino evoca il solipsismo – ognuno ha il suo riflesso –, l’immaterialismo alla Berkeley - «Sto nuotando nella mia mente; è solo là che esiste questa spada di luce»; richiama poi il costruttivismo fisico-matematico che scorpora la natura per ridurla a campi di forze e diagrammi vettoriali. La prospettiva accolta dall’autore al termine della riflessione è un materialismo nutrito dall’approccio evoluzionistico: «Puntuale un dardo di luce parte dal sole, si riflette sul mare calmo, scintilla sul tremolio dell’acqua, ed ecco la materia diventa ricettiva alla luce, si differenzia in tessuti viventi, e a un tratto un occhio, una moltitudine di occhi fiorisce, o rifiorisce ...». È lo stesso percorso che, attraverso emissioni e riflessioni di vibrazioni luminose, portava, nel racconto La spirale delle Cosmicomiche (1965), allo sviluppo del senso della vista, narrato da un mollusco che si scopre sottomesso allo sguardo degli altri. La storia che si apre con l’uomo si radica, nell’anti-storicismo di Calvino, in una «storia della materia» dentro la quale l’episodio umano appare «solo la migliore occasione a noi nota che la materia ha avuto di dare a se stessa informazioni su se stessa», scrive lo scrittore in una lettera del luglio 1970 a Sebastiano Timpanaro, uno dei massimi interpreti del pensiero materialista. L’avventura della nostra specie va compresa – nel duplice senso di inclusa e spiegata – nell’orizzonte più ampio di una “memoria del mondo” in cui sono già tracciate le condizioni che rendono possibile il conoscere degli uomini. La “storia naturale” del logos prende avvio già nelle forme organizzative della materia e della vita, su cui si innestano e da cui “germinano” le nostre strutture sensoriali e cognitive. «I sensi sono relazioni lentamente nucleatesi nei millenni di millenni sopra il soppalco logico di preesistenze reali; sopra la luce (già essa complesso di relazioni) si è nucleata una conoscenza della luce», diceva il Gadda della Meditazione milanese (1928). È una lezione di cui Calvino trovava conferma nell’approccio strutturale del Lévi-Strauss del Pensiero selvaggio, per il quale le operazioni di codifica a livello fisico-chimico non sono diverse dai codici grazie ai quali il sistema nervoso, già a livello sensoriale, li decifra. Le strutture cognitive costituiscono un prolungamento dei processi morfologici propri dell’organizzazione dei sistemi viventi, suggeriva l’epistemologia genetica del Jean Piaget di Biologia e conoscenza (1967).
“Non pensare, ma osserva”, potrebbe dire il signor Palomar, lettore del Wittgenstein delle Ricerche filosofiche, ma Calvino sa bene che non si dà osservare puro, ogni vedere è carico di teoria. Lo ha appreso dall’epistemologia di Karl Popper, verso il quale ha sempre manifestato profonda stima, al punto di costruire un racconto, il Conte di Montecristo che chiude T con zero (1967), nelle modalità della metodologia popperiana delle congetture e confutazioni. Le mappe costruiti da Dantès – modelli della struttura del castello di If – sono messe alla prova, e confutate, dai vani tentativi di fuga dell’abate Faria. Per il “razionalismo critico”, il nostro occhio non è uno specchio del mondo, la nostra mente non è un secchio da riempire con le “rappresentazioni” raccolte dai sensi, ma interviene sul mondo per renderlo conoscibile. È un principio ribadito nelle postume Lezioni americane, con il richiamo a colui che Calvino giudica l’altro “filosofo naturale” della nostra letteratura: «Prima ancora che la scienza avesse ufficialmente riconosciuto il principio che l’osservazione interviene a modificare in qualche modo il fenomeno osservato, Gadda sapeva che “conoscere è inserire alcunché nel reale; è, quindi, deformare il reale”». O almeno, suggerisce il capitolo Il modello dei modelli, questa è stata la regola a cui il signor Palomar si è affidato «in un’epoca della sua vita» (direi: anni Sessanta e Settanta): costruire un modello mentale, «il più perfetto, logico, geometrico possibile»; sottoporlo al controllo dell’esperienza per apportare poi le correzioni necessarie. Era questa la metodologia ipotetico-deduttiva, nemico dell’induzione cara all’empirismo, a cui il signor Palomar, si affidava; ma ora il suo sguardo si è fatto sempre più disincantato, diffida delle spiegazioni generali, della capacità dei modelli di contenere una realtà «che si spappola da tutte le parti». Il suo sapere, sempre più insicuro (aggettivo ricorrente in Palomar), fatica a far proprie le qualità di un uomo senza certezze. Non basta moltiplicare i modelli per scavalcare l’abisso fra la realtà e i principi teorici, per cui Palomar «preferisce tenere le sue convinzioni allo stato fluido, verificarle caso per caso», scrive al termine del capitolo.
«Una conoscenza fuori da qualsiasi codice non esiste», ribadiva Calvino nella recensione a L’occhio e l’idea (1982) di Ruggero Pierantoni. La storia dell’ottica è scandita dal succedersi di modelli della visione con cui funziona in ogni ambito la mente umana, cioè “codici” che Calvino definisce “costanti mitiche”. Anche lo sguardo dello scienziato muove sempre da pre-concetti, magari inconsci, che orientano la ricerca, temi (themata) che si ritrovano in tutta la produzione culturale, come ha suggerito Gerald Holton (L’immaginazione nella scienza, Einaudi, 1983). Questa modalità “tematica” dell’immaginazione si presenta in genere in termini di antitesi, di coppie di opposti: atomismo e continuità, semplicità e complessità, analisi e sintesi, ecc. Einstein era un sostenitore del continuo, di un universo semplice e omogeneo, da cui il caso fosse escluso. Non sarebbe difficile indicare quali “temi” orientino lo sguardo e l’immaginario di Calvino, “partigiano del cristallo”, che predilige i saperi dell’analisi e della dissezione, pensatore del discreto e del discontinuo. Nel libro di Pierantoni, lo scrittore ligure poteva trovare altri “modelli”, opposti e complementari, riconducibili all’oscillazione del suo pensiero: da un lato, il neuro-scienziato David Marr tende a spiegare la visione sulla base di una teoria computazionale che, a partire dalla rappresentazione simbolica della geometria delle superfici visibili, possa formulare l’algoritmo in base al quale il cervello interpreta le forme osservate. Dall’altro, la prospettiva “ecologica” dello psicologo James Gibson rintraccia le informazioni nel rapporto fra l’organismo e l’ambiente più che nei modelli cognitivi posseduti dalla mente. Gli organismi sarebbero cioè formati in modo da percepire direttamente, senza ricorrere a inferenze computazionali, le informazioni rilevanti dell’ambiente; la visione, spiegata secondo un’ottica realistica, muove dal presupposto che il mondo stesso contenga le invarianze morfologiche e topologiche che l’occhio-mente scopre più che costruire.
In base a quale trama lo sguardo di Palomar si rivolge al mondo? Se non si dà vedere neutro sul mondo è perché non esiste netta separazione fra occhio e mente, fra guardare e pensare; possediamo sempre degli occhiali, come quelli da vista del signor Palomar, l’importante è sapere di averli e ogni tanto dare una ripulita alle lenti. La griglia frattesa fra sé e il mondo nel caso di Calvino è quella della lettura e della scrittura: così suggeriva in modo persuasivo Marco Belpoliti in L’occhio di Calvino (Einaudi, 1996), – il tema è ripreso nella prefazione a Guardare (Mondadori, 2023) dove sono raccolti i saggi che Calvino ha dedicato al disegno, al cinema, alla fotografia, alle arti. Il mondo, di per sé continuo e indecifrabile, si fa visibile se è riconducibile alla lettura, cioè a una successione di immagini separate, fra le quali c’è un vuoto, perché “vedere vuol dire percepire delle differenze”. Una volta tradotto nella struttura della pagina, diventato foglio/mondo, il mondo è analogo a un testo composto da parole, cioè a un insieme discreto. È il modello su cui si è formata l’intelligenza visiva di Calvino, come lui stesso ha ricordato, il succedersi di figure nei cartoon, nei fumetti che guardava sul “Corriere dei Piccoli”, prima ancor di saper leggere. Come serve una mappa per attraversare una città – che diventa inservibile nelle “città continue” del libro del ‘72 –, così bisogna tessere una rete in cui siano indicati i punti di connessione fra elementi, i luoghi d’incrocio e comunicazione; è questo a consentire di vincere la “sfida al labirinto”. Quel che vale per la matematica, cioè rendere visibile l’invisibile (una formula attribuita solitamente all’arte), riguarda per Calvino ogni ambito del sapere: costruire mappe, cioè visualizzare una cartografia del possibile, consente di mantenere distanza dalle cose e insieme tracciare percorsi per attraversarli. La pratica della scienza, ha suggerito Bruno Latour, è costruzione di mappe, configurazione possibile del territorio, organizzazione di un campo di visibilità che “mette in forma”, e “in scena”, il dominio degli oggetti.
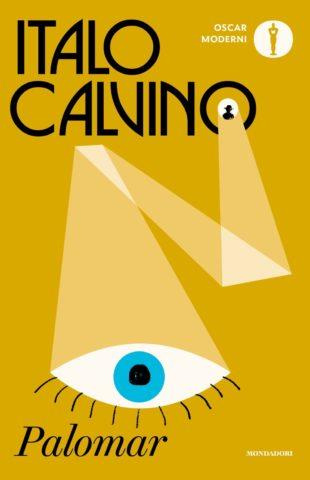
«Quando c’è una bella notte stellata, il signor Palomar dice: – Devo andare a guardare le stelle». Si reca in spiaggia e si siede sulla sdraio; ha portato con sé una lampadina tascabile con cui poter riconoscere la posizione dei corpi osservati sulle mappe celesti. Ma per vederle deve togliersi gli occhiali ed i gesti che è costretto a compiere attirano alle sue spalle una piccola folla che osserva le sue mosse «come le convulsioni di un demente». La contemplazione delle stelle, una delle ultime avventure del signor Palomar (risale all’agosto 1983), rinnova l’attrazione cosmologica che era in una delle prime, I buchi neri (non raccolta nel libro), apparsa sul “Corriere della Sera” il 7 settembre 1975. Lettore della rivista “Le Scienze” come Primo Levi, anche Calvino si ritrova ormai di fronte a un universo «cieco, violento e strano» (Levi, Le stelle nere), in cui si è cancellata ogni parvenza di armonia pitagorica, ogni musica delle sfere. Lo spazio caosmico, come pure il tempo, si è fatto curvo e lacunoso, crivellato di crateri e voragini, annunciatore di catastrofi in forma di esplosione o di implosione. Sulla pagina del mondo ogni recto ha il suo verso: è il meccanismo che Calvino ha prediletto nelle Città invisibili, si pensi a Perinzia, una delle cinque nella rubrica “Le città e il cielo”, costruita cercando di rispecchiare l’armonia del firmamento. Ma le vie di Perinzia – a ribaltare l’illusione del platonismo – si riempiono di storpi, gobbi, donne con la barba, nelle cantine e nei granai le famiglie nascondono figli orrendi. Forse gli astronomi che hanno progettato la città hanno sbagliato i loro calcoli, oppure «l’ordine degli dei è proprio quello che si rispecchia nella città dei mostri». Il tentativo di dare espressione a quanto ha capito dei black holes, «inimmaginabili oggetti celesti», nel duplice senso di invisibili e impensabili, incorre nelle garbate critiche dell’astronoma Margherita Hack, a cui Calvino replica nella rubrica “Osservatorio del signor Palomar” il 29 ottobre 1975. Una in particolare è per lui rilevante, di essersi fatto “incantare dalle immagini”: «Per uno che pensa per immagini, e che va continuamente in caccia d’immagini al limite del pensabile, questo è un duro colpo: come incontrare un cartello di ‘caccia vietata’ in un bosco (la scienza) che per lui era riserva di pregiata selvaggina». La formula si ritrova identica sotto la penna di Primo Levi che, nei saggi racconti in L’altrui mestiere, si era avventurato in «bracconaggi in distretti di caccia riservata», nei territori di scienze e tecniche, coltivate da dilettante curioso, che erano per lui “formidabili fonti d’ispirazione”, al punto di giustificare il sogno di “romanzi dettati dai grilli”.
Lo scacco di fronte al cielo stellato si rinnova di fronte agli altri fenomeni a cui si rivolge lo sguardo del signor Palomar: ogni frammento di realtà si rivela infinitamente complesso, sfuggente e inesauribile e i tentativi di ritrovare ordine si aprono a una proliferazione caotica. L’ansiosa ricerca di precisione ed esattezza (una delle voci delle Lezioni americane), la volontà di adesione alla ricchezza dei dati percettivi, scontano i limiti del linguaggio, contro cui Calvino si ritrova a lottare come il “secondo” Wittgenstein. Sintomatico il caso del primo brano, Lettura di un’onda. Palomar cerca di de-scriverla, di scriverle intorno, di distinguerla dalle altre, si sforza di separarne il moto dalle precedenti e dalle successive; in altri termini, cerca di tradurre il fluire continuo in successione discreta. Ma «non si può osservare un’onda senza tener conto degli aspetti complessi che concorrono a formarla e di quelli altrettanto complessi a cui essa dà luogo». L’immagine dell’onda che Palomar prova faticosamente a isolare s’infrange e si disperde al primo mutare del vento, viene sommersa nell’andirivieni delle altre onde fino a farsi indistinta. Prova allora a delineare le forme e le sequenze che si ripetono, i “punti di catastrofe” del moto ondoso, «ma poi salta fuori sempre qualcosa di cui non aveva tenuto conto». È un po’ il destino che attende ogni tentativo di ordinamento visivo nei vari capitoli del libro, ogni proposito di «padroneggiare la complessità del mondo riducendola al meccanismo più semplice». Nel Prato infinito, il protagonista è intento a strappare le erbacce dal prato intorno a casa, che vorrebbe assumesse la figura di «una distesa verde uniforme». Ma la gramigna spunta dappertutto e il lembo di tappeto erboso sfugge alla volontà ordinatrice, «si rivela una giungla senza legge». Prova allora a procedere prima secondo un approccio geometrico, prendendo in considerazione solo un quadrato; poi si affida a un approccio aritmetico, ma contare tutti i fili d’erba si rivela un compito inesauribile; e lo stesso vale con un approccio insiemistico, perché al soffio del vento pollini e semi se ne volano via, al pari delle relazioni fra gli insiemi inizialmente distinti. Alla fine Palomar non pensa più al prato, ma all’intero universo, in bilico fra ordine cosmico e proliferazione caotica: «L’universo forse finito ma innumerabile, instabile nei suoi confini, che apre entro di sé altri universi. L’universo insieme di corpi celesti, nebulose, pulviscolo, campo di forze, intersezione di campi, insiemi di insiemi …».
Lo sforzo di classificazione del mondo apre un baratro di complicazione crescente che richiede un’apertura enciclopedica, una via verso l’infinito su cui non c’è più controllo (è uno dei temi di Collezione di sabbia, 1984, ma con saggi risalenti alla metà degli anni Settanta, apparsi sul “Corriere” o nei primi anni Ottanta su “Repubblica”). Lo testimonia l’esplorazione avventurosa data dalla visita a una formaggeria parigina (Il museo dei formaggi). In coda, in attesa di ordinare, Palomar contempla affascinato la varietà della merce esposta: «potrebbe memorizzare tutti i nomi, tentare una classificazione a seconda delle forme – a saponetta, a cilindro, a cupola, a palla –, a seconda della consistenza – secco, burroso, cremoso, venoso, compatto –, a seconda dei materiali estranei coinvolti nella crosta o nella pasta – uva passa, pepe, noci, sesamo, erbe muffe», senza contare la differenza dei sapori, dei luoghi di provenienza, dei tipi di lavorazione … Così, quando arriva il suo turno, il disorientato Palomar finisce per scegliere il tipo di formaggio più comune e diffuso.
Allo zoo di Barcellona, il signor Palomar è attratto da “Fiocco di neve”, un gorilla albino, nel cui sguardo scorge la desolazione e la rassegnazione di chi mostra al mondo la sua singolarità. Fra le sue braccia-zampe quel gigante triste stringe un copertone di pneumatico d’auto, con un gesto fra il possessivo e l’affettivo, o forse simbolico, quasi volesse «aprire uno spiraglio verso quella che per l’uomo è la ricerca d’una via d’uscita dallo sgomento di vivere». Sembra di risentire la voce della scimmia kafkiana che, nella sua Relazione all’accademia, comunica al pubblico come sia riuscita anche lei, non a trovare una via di fuga dalla gabbia, ma “una via d’uscita” attraverso l’imitazione dei comportamenti umani. Nella sua notte insonne, Palomar torna a rivedere l’immagine del gorilla; come sempre in Calvino, il mondo animale, nella sua muta alterità, non smette d’interrogarci e ci chiama alla responsabilità (come già era per le capre degli esperimenti atomici a Bikini, nel ’46) e si rivela prossimo: «Tutti rigiriamo tra le mani un vecchio copertone vuoto mediante il quale vorremmo raggiungere il senso ultimo a cui le parole non giungono». Ma, come Calvino rileverà nella conferenza Mondo scritto e mondo non scritto (1983), «leggere il mondo non scritto, il mondo che sfugge alla presa del linguaggio, vuol dire far parlare il silenzio, obbligare il silenzio a parlare di se stesso». Siamo ai margini del paradosso, se non dell’ossimoro: è questo comunque l’intento affidato alla letteratura nel finale delle Lezioni americane: «far parlare ciò che non ha parola, l’uccello che si posa sulla grondaia, l’albero in primavera e l’albero in autunno, la pietra, il cemento, la plastica …».
Lo “sguardo naturalistico” di Calvino si è sempre posto l’obiettivo di conseguire “un’ottica non-antropomorfa”, di concepire un’opera che sfugga ai condizionamenti del soggetto, alla «prospettiva limitata d’un io individuale» (Molteplicità nella Lezioni americane). In Se una notte d’inverno un viaggiatore, la riflessione meta-letteraria giunge ad oscurare il ruolo dell’autore: «Come scriverei bene se non ci fossi! Se tra il foglio bianco e il ribollire delle parole e delle storie che prendono forma e svaniscono senza che nessuno le scriva non si mettesse di mezzo quello scomodo diaframma che è la mia persona!», esclama Sylas Flannery (alter ego dell’autore). Contemplando i corpi celesti è quasi possibile dimenticare di esistere, ci si può considerare «un punto anonimo e incorporeo», come se l’io – «il più lurido di tutti i pronomi», per dirla con il don Gonzalo della Cognizione del dolore – se ne stesse «affacciato ai propri occhi come al davanzale d’una finestra […] Forse l’io non è altro che la finestra attraverso la quale il mondo guarda il mondo. Per guardare se stesso il mondo ha bisogno degli occhi (e degli occhiali) del signor Palomar». Ma quando si ha a che fare con gli altri esseri umani, bisogna volgere lo sguardo verso la propria interiorità: anche l’io è “un pezzo di mondo”. Nell’ultima parte del libro, la più tormentata e rarefatta – dal titolo Meditazioni, ironica replica a quelle cartesiane? –, Palomar si dedica ad esplorare la propria “geografia interiore”, a tracciare il diagramma del suo animo, anche per riuscire a migliorare i suoi rapporti con il prossimo. L’universo di sterminate galassie in fiamme diventa il suo “specchio”, il cielo stellato si svela «pericolante, contorto, senza requie come lui». Anche la coscienza è un caosmo, «una sfera di circonferenza infinita che ha l’io per centro e il centro in ogni punto», come Pentesilea, una delle città continue, che «è solo periferia di se stessa e ha il suo centro in ogni luogo»: ripresa della coincidentia oppositorum (cara a un autore apprezzato da Calvino, Jorge Luis Borge) che Nicolo Cusano attribuiva all’infinità divina e Giordano Bruno applicava al suo universo.
Nella terza Meditazione, Calvino si muove su di un terreno che non gli è usuale, quell’interrogazione psicologica e introspettiva, priva di cadute intimiste, da cui si è sempre tenuto, in modo esplicito, distante. Il suo approccio “cristallino” ha sempre cercato di distendere il tempo continuo nella geometria dello spazio discreto; quando rivolge la sua attenzione al tempo vissuto, a quella che Gilles Deleuze sulla scia di Bergson chiama “molteplicità di compenetrazione”, all’intreccio eterogeneo e simultaneo di qualità che sfumano l’una sull’altra, ecco giungere improvvisa la conclusione: «“Se il tempo deve finire, lo si può descrivere, istante per istante, – pensa Palomar, – e ogni istante, a descriverlo, si dilata tanto che non se ne vede più la fine”. Decide che si metterà a descrivere ogni istante della sua vita, e finché non li avrà descritti tutti non penserà più d’essere morto. In quel momento muore». Come interpretare questa morte? Vi è certo una vena pessimistica che si è accentua in quegli anni Ottanta, al punto che Calvino può affermare in un colloquio con l’editore Giulio Bollati: «Vedo il mondo da uno spiraglio del mio sepolcro» – riporta Domenico Scarpa in Calvino fa la conchiglia (Hoepli, 2023). Credo vi si possa leggere anche il riconoscimento dei limiti del paradigma teorico di un “partigiano del cristallo” che ora cerca di accostarsi al “partito della fiamma”, come diranno le Lezioni americane, ovvero di accogliere “la sfida della complessità”. «Di fronte alla vertigine dell’innumerevole, dell’inclassificabile, del continuo, mi sento rassicurato dal finito, dal sistematizzato, dal discreto», confessava Calvino in Cibernetica e fantasmi. Era la stessa funzione che motivava la (s)mania della collezione e del diario, il «bisogno di trasformare lo scorrere della propria esistenza in una serie di oggetti salvati dalla dispersione, o in una serie di righe scritte, cristallizzate fuori dal flusso continuo dei pensieri» (Collezione di sabbia). Ma di fronte alla inesauribile superficie delle cose, di fronte a una molteplicità non integrabile, cade l’illusione di redimere gli oggetti dal fluire inesorabile, di dominare il tempo o almeno di fare perdere alla morte le proprie tracce. La strategia di leggere il mondo come un seguito di pagine scritte, di ricondurre la dinamica del flusso delle onde alla regolarità della caduta dei granelli di sabbia in una clessidra, lascia dei resti (e dei resti di resti) che l’occhio di Palomar non riesce più a scorgere.
Calvino è un pensatore del complicato più che della complessità. Un sistema complesso, “intrecciato, tessuto insieme”, si compone d’interazione multiple, che non possiamo isolare; «v’è complessità quando sono inseparabili le differenti componenti che costituiscono un tutto», ha osservato Edgar Morin in La testa ben fatta. Palomar prova a leggere il moto vorticoso degli storni, presto colto dall’impressione che anche la scienza, fattasi «incerta, approssimativa», abbia rinunciato a rendere “razionali” fenomeni che implicano grandi numeri e interagiscono in modo, in apparenza, casuale. Se nella nostra memoria ancestrale la migrazione dei volatili, quella “nuvola d’ali” in volo, poteva associarsi «all’armonico succedersi delle stagioni», ora il moto browniano di quei «granelli d’una polverina in sospensione in un liquido» gli lascia un senso di vertigine. Palomar avverte come una sconfitta l’impossibilità previsionale di fronte a fenomeni complessi, alle nuvole di cui non possiamo stabilire la traiettoria, agli insiemi caotici dove la sensibilità alle condizioni iniziali, come il battito d’ali di una farfalla, interviene a sconvolgere ogni certezza sul futuro (un esempio che già troviamo nell’Egoista di Gadda). Mi piace pensare che Calvino sarebbe stato lieto di sapere che, nel volo degli storni nei cieli autunnali di Roma, se non possiamo determinare le singole traiettorie, qualche regolarità la possiamo comunque rintracciare. Come ha spiegato il fisico Giorgio Parisi – premio Nobel per i suoi studi sui sistemi complessi –, facendo ricorso ai metodi della meccanica statistica riusciamo a prevedere la forma probabile che assumerà la “dinamica caotica” dello stormo in fuga dagli assalti di un falco.
martedì 17 ottobre ore 11
Biblioteca Flaminia
Palomar
con Mario Porro
Leggi anche:
Alessandro Giarrettino | Italo Calvino: i classici tra i banchi
Daniela Santacroce | Una pedagogia implicita. Insegnare Calvino nelle scuole
Nunzia Palmieri | Leggere "Il sentiero dei nidi di ragno"







