Due romanzi / Silvia Ballestra e Claudio Morandini. Montagne
Claudio Morandini. Gli oscillanti
A Crottarda si arriva per tornanti bui, penetrando la montagna in gallerie e cupe strettoie, precipitando lentamente nell’oscurità di una valle ombrosa, fino al piccolo borgo adagiato su una terra bucherellata di foibe, cavità e bocche aperte sul cuore ipogeo della Terra.
Crottarda, dal nome che esala aria di grotte e cantine, oscurata dalla parete rocciosa, fluttua su un’enorme dolina e, dal mondo sotterraneo che le si apre tra le radici, risucchia l’umidità che riempie le case, le muffe che fioriscono sui muri coprendo di strati morbidi e odorosi le pareti.
Qui la protagonista di Gli Oscillanti di Claudio Morandini trascorre le vacanze da bambina, estati lunghe impastate di noia e fantasie d’evasione, in stanze piene di umidità e di bicchieri di sale per farla asciugare e nei quali intingere le dita per succhiare di nascosto i cristalli bagnati.
Dal ricordo di quelle giornate di attese e silenzi e delle notti interminabili e fredde riaffiora un canto che si accendeva nel buio, un concerto di “suoni strani, remoti eppure nitidi”, modulati secondo una partitura misteriosa, come canto di balene che risale da abissi lontani.
È inseguendo quella musica di voci sconosciute che la protagonista, alle prese con un seminario di etnomusicologia, ritorna nei luoghi d’infanzia, con la missione di studiare, registrare e catalogare quei melodici richiami che sembravano venire dalle montagne e parevano linguaggi segreti intonati dai pastori sulle cime.
A Crottarda del vecchio albergo in cui soggiornava la sua famiglia non restano che un’insegna sgualcita e un rudere ammuffito; l’unica stanza disponibile si trova nella casa della signora Verdiana e comunica con quella della giovane Bernardetta, ragazza orfana e selvatica che sarà guida e compagna, seppur inaffidabile, in un paese sempre più ermetico e ostile.
A partire dall’accoglienza nel borgo, con recite carnevalesche improvvisate e travestimenti deformi che spaventano i turisti e divertono i locali, la farsa e lo scherno si rivelano il linguaggio d’elezione dei crottardesi in tutti i rapporti con chi viene da fuori, un filtro di affettazione e reticenze dietro cui celare segreti e misteri del luogo.
Misterioso appare anche l’oggetto di indagine della protagonista che, dopo un iniziale apparente interesse verso le sue ricerche, dovrà arrendersi al fatto che dei canti e dei richiami dei pastori ai crottardesi sembra non importare nulla, tutti presi e concentrati come sono dal primo e unico motivo di partecipazione e trasporto della comunità: l’atavica e feroce faida che li lega ad Autelor, borgo di case sparse sul versante opposto e soleggiato della valle.
Ad Autelor i paesani trascorrono le giornate negli orti rigogliosi, si abbronzano sui tetti e ballano sotto il sole, osservati dai cugini di Crottarda, che li spiano con i binocoli dai campi coperti di brina e, sotto il fumo delle stufe che mai si spengono e mai asciugano le ossa bagnate, coltivano sogni di guerre e maledizioni.
Così, i crottardesi allestiscono spedizioni per attraversare il fiume che etimologicamente e geograficamente li divide dai rivali e rompere i loro canali di irrigazione, con la speranza di vedere nei binocoli il colore spento dei loro campi bruciati dal sole. E quegli altri, in risposta, raccolgono pezzi di vetro riflettente e si affacciano ai balconi per proiettare raggi roventi sui nemici al buio, con specchi ustori che luccicano e provocano bruciature sulle pelli diafane e sugli animi offesi.
Racconta qualcuno, sottovoce, che una volta i paesi erano una cosa sola, un mito primigenio di unità e armonia spezzato poi in antinomie inconciliabili e belligeranti: se ad Autelor si vive sui tetti a riparare grondaie e rosolare sulle lastre di ardesia, a Crottarda si scende nelle cantine, a bere vino in cunicoli interrati, in un’opposizione fin troppo netta tra sopra e sotto, luce e buio, ombra e sole, tra una forza che spinge verso il cielo e una che trascina dentro la terra.
Crottarda è incastrata nel mezzo e per questo chi la abita oscilla: “davvero li sento oscillare, questi poveri abitanti di Crottarda, in ogni gesto, ogni giorno, e se li potessi osservare nel corso della loro vita intera li vedrei oscillare da quando nascono a quando muoiono, tra la loro esistenza ufficiale e il loro lato nascosto, tra il bisogno di luce, sempre troppo scarsa e precaria, e l’attrazione per il buio [...] Oscillano, i miei poveri crottardesi, tra bisogno di nascondersi e necessità di uscire allo scoperto, di respirare l’aria di fuori; tra impulso a esprimersi e mutismo, tra tripudio dei sensi, di tutti i sensi, anche quelli che noi non sappiamo più praticare, e chiusura di tutti gli orifizi nel silenzio, nel buio cieco [...] tra un sopra che si allontana, che schiaccia e opprime e un sotto in cui sprofondare, tra umano e non umano, vivo e non vivo”.
Agisce su tutto il romanzo una particolare forza di gravità, un richiamo verso una terra che risucchia, tra un senso di terrore e la tentazione di lasciarsi sprofondare.
Lo stesso accade alla protagonista durante la sua ricerca, inseguendo voci e richiami indecifrabili: più ci si addentra nel buio, più si riscontrano ostilità e chiusura e si avverte come un pericolo e insieme una seduzione.
Attraverso la narrazione in prima persona di una protagonista di cui non conosciamo il nome ma con cui condividiamo una crescente inquietudine, seguiamo il lavoro di ricerca che si ingolfa quasi subito, in note scarabocchiate sul pentagramma, registrazioni a vuoto e una vaga omertà che dilaga in paese.
Chi canta, di notte, quelle frasi melodiche che sembrano portare messaggi inafferrabili? È veramente un linguaggio cifrato, il cui codice viene tramandato dai pastori in severi apprendistati di canto e solfeggio per scambiarsi arcane comunicazioni, o questi ultimi si limitano a chiamarsi, improvvisando e “tutt’al più coltivano l’illusione di condividere qualcosa”?
Con Bernardetta e un registratore vuoto, la protagonista insegue i pastori sulle malghe, arrampicandosi sugli alpeggi per vincere l’apparente impossibilità di “ricostruire un repertorio stabile di questi canti, che nascono dalla solitudine e dal silenzio”.
Ma la ricerca affonda sempre più in un mistero inospitale, a Crottarda nessuno vuole più parlare con lei, non ci sono telefoni né connessioni e il mondo fuori esiste a intermittenza, in qualche sporadico contatto che non riesce a dar voce all’angoscia che dilaga.
L’indagine diventa sempre più una discesa che fa presagire un valore simbolico e iniziatico, ma che sprofonda in una confusione disorientante, mentre prende voce un altro canto, una voce sola, dolente, una specie di lamento, quasi animale, che entra dalle finestre, risale dalle cantine e dalle cavità di quella terra porosa che si lascia attraversare: “queste creature canore delle doline si uniscono ai canti dei pastori, ne imitano le cadenze e i pastori a loro volta si ispirano alle inflessioni di chi vive sotto i loro piedi, in un’emulazione reciproca”.
I due mondi, il sotto e il sopra, si parlano e ne viene fuori un canto, che dell’universo ctonio da cui sgorga conserva il mistero e la forza primitiva.
Bernardetta, con la sua “vitalità che gira a vuoto, non sa come esprimersi e assume forme a tratti mostruose”, sembra essere la chiave per visitare questo luogo occulto e primordiale.
Creatura della montagna, coltiva una particolare familiarità con il mondo delle ombre, con i canti e con le creature che salgono dalla terra e con le quali condivide rapporti e sentimenti istintuali, liberi e arcaici: “non le importa che i suoi siano luoghi dimenticati o ignorati dal resto del mondo. Anzi, le piace l’idea di essere l’unica ninfa che scorrazza e suda su queste pendici rivestite di muffa. Il suo è lo sguardo di chi vive in montagna: resta basso, non si alza sulle cime, non punta ai picchi come fanno gli occhi dei viaggiatori [...] Chi vive tra le montagne non vi sale [...] una fenomenale forza di gravità lo tiene attaccato alla terra. E se potesse ci sprofonderebbe anche, si addentrerebbe tra strati di pietre e sedimenti. Tale è anche lo sguardo di Bernardetta, uguale a quello di tutti gli abitanti di Crottarda, e corrisponde a un radicamento al suolo e alla roccia che pare una condanna”.
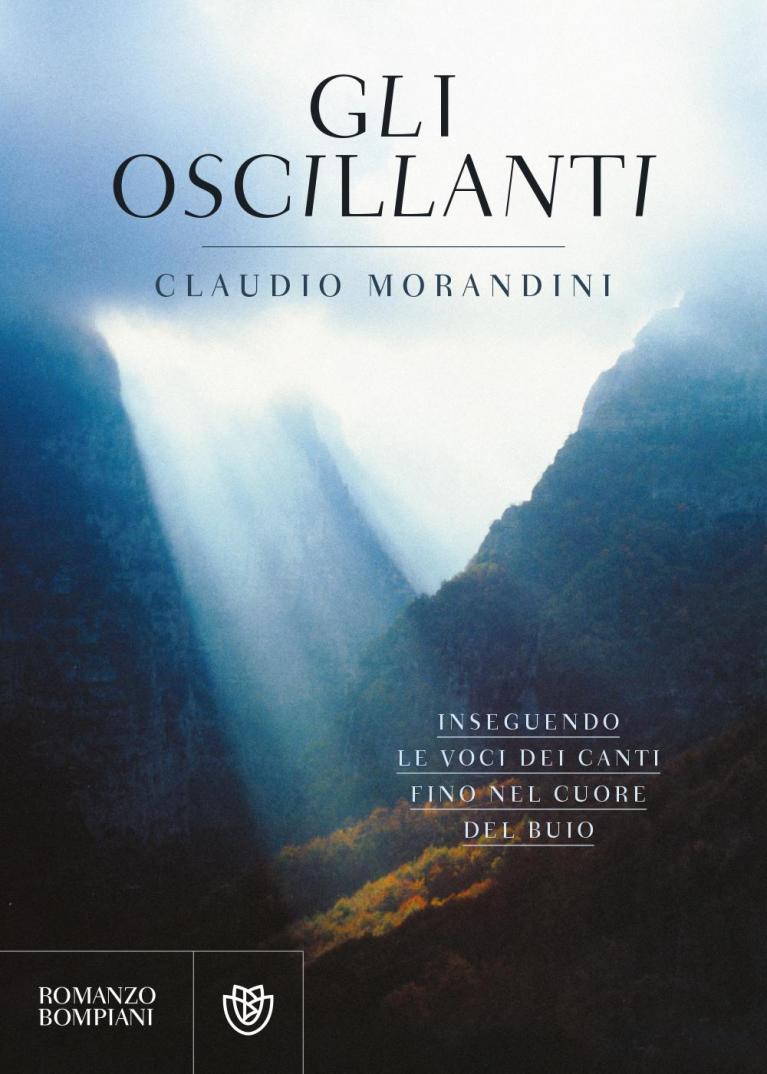
Con una scrittura immaginifica e avvolgente, che apre spiragli su un mondo oscuro, minerale e sotterraneo, la narrazione accompagna in presa diretta la protagonista mentre insegue i suoi canti fin sottoterra, fino a sentirsi sprofondare, come sprofonda Crottarda, lentamente inghiottita dalle doline.
E, più si procede verso il disvelamento, più sembra di entrare in un’allucinazione, in cui le visioni acquistano una consistenza inquietante, come “i sogni dei crottardesi, così intensi da prendere corpo, nascondersi nelle cavità della pietra”; come le carnali visitazioni notturne di Bernardetta, o come i feticci scolpiti nel legno dall’artigiano del paese.
Il romanzo si avvolge intorno a un mistero di cui il canto ipnotico delle doline è solo un’eco emersa dalle profondità di un inconscio collettivo, che serba memoria di un tempo perduto e risveglia voci e creature tanto familiari quanto spaventose, ombre che la terra cava di Crottarda lascia attraversare.
Silvia Ballestra. La nuova stagione
Se il romanzo di Morandini ha il movimento trascinante del lento inabissarsi di Crottarda nelle doline, La nuova stagione di Silvia Ballestra, inizia con un’ascensione, quella di tre donne che si arrampicano sui monti Sibillini.
Una delle tre corrisponde alla voce narrante, che ricostruisce le vicende delle sue cugine, Olga e Nadia, alle prese con un’eredità ingombrante e il tentativo di smarcarsi dalle proprie radici grazie alla vendita delle le terre di famiglia. Dalla corona del monte Sibilla le due sorelle lanciano le loro domande alle profondità della valle che restituisce l’eco di vaticini incerti portati da vuoto, vento e silenzio, i “padroni di quei luoghi da contemplare”.
Come Crottarda, la Valferonia in cui il romanzo è ambientato è un luogo che non esiste nella realtà, ma di fantastico ha solo il nome, perché ricalca la topografia caratteristica e ben riconoscibile delle valli del Centro Italia, il mosaico verde e arancione scuro dei campi della vecchia mezzadria, “un ammasso di gomitoli in fuga verso le montagne”, una terra di creature mitiche, di cime e dirupi immacolati, di piante infestanti e sovrumana bellezza.
Le due sorelle fanno ritorno nelle terre d’origine solo per liberarsene una volta per tutte, dopo aver percorso strade diverse e lontane e aver abbandonato, con il benestare dei parenti, quel patrimonio agricolo e familiare che sembra avversare la potestà femminile.
Il padre, ex padrone delle terre, aveva infatti scoraggiato le figlie dal frequentare il lavoro in campagna, un po’ per proteggerle, un po’ perché “c’era da scombatterci, perché era difficile avere a che fare con certi personaggi, perché capitava di discutere e litigare”.
E nel tempo presente, il tempo delle rivoluzioni epocali della post-mezzadria e di profondi mutamenti sociali, in cui le due sorelle si trovano a doversi definitivamente sganciare dall’eredità paterna, quel tentativo di tenerle lontane assume un valore profetico e stringente.
Secondo il tema topico del lascito della terra, dell’epopea di fatiche e battaglie più o meno paradossali, alle prese con la paralisi della burocrazia e la caparbietà della natura, tra uffici vuoti da piantonare e palmeti da sterminare, le due protagoniste si scontrano con lunghe e vane peregrinazioni in uffici comunali, con i fascicoli dispersi nei corridoi polverosi dei Consorzi locali, con le impossibili telefonate con geometri e funzionari senza nome, con agricoltori disonesti, piani di sviluppo, rilievi topografici, piante che infestano e che si ammalano e soldi da sborsare, carte da compilare, raccomandate da spedire, lettere di esproprio che fanno sudare freddo ed esplodere in pianto.
E allo scontro con una burocrazia sorda e spietata si accompagna quello con i potenziali compratori, nuovi proprietari terrieri, ricchi russi e sceicchi arabi, ex mezzadri e nuove multinazionali dell’agricoltura, in una sequela di buchi nell’acqua e fregature da scongiurare.
Ritornando su quelle terre che pesano come una condanna, Olga e Nadia si scontrano anche con la loro condizione di donna, con la marginalità, la sfiducia e l’incertezza che caratterizzano i loro rapporti con gli antagonisti che si trovano, loro malgrado, ad affrontare, con il senso di pericolo e allerta che le invade muovendosi sole tra campi e frutteti.
Olga e Nadia sono donne forti, risolute, indipendenti, capaci di disinnescare l’arroganza degli uomini che vorrebbero sopraffarle con intelligenza, sarcasmo e autoironia, ma la memoria di quei luoghi racconta una storia diversa, di lavoratrici nei campi relegate in posizioni subalterne, di tentativi di emancipazione femminile schiacciati da prevaricazione, prepotenza ed emarginazione.
Su questi temi si incardina la seconda narrazione racchiusa nel romanzo, una storia antica di violenza piantata nel cuore del libro che racconta di un omicidio spietato.
La vittima è Giancarla Proietti, una donna capace di trasformare un destino di solitudine e rimpianto in un’occasione di incontro e riscatto, per sé e per altre tre donne, vittime anch’esse della loro condizione, che avevano pagato indipendenza, audacia e fragilità con l’internamento forzato nel manicomio di Teramo.
La vicenda di Giancarla Proietti, insieme ad altre storie simili che si tramandavano in quelle valli, è anch’essa all’origine dell’allontanamento di Olga e Nadia da quelle terre pericolose ed è uno dei pretesti per fare i conti con il proprio passato, che riaffiora proprio nel momento in cui si cerca di chiudere un capitolo della propria esistenza.
Continuamente provocate da difficoltà, imprevisti e beghe burocratiche, le due sorelle rivivono gli anni della loro giovinezza mentre percorrono i sentieri petrosi di quei borghi feriti, piangono, ridono, si abbandonano a crolli nervosi e a momenti di inarrestabile, immotivata euforia e affrontano, in ultimo, la difficoltà di sradicarsi dai propri luoghi, di emanciparsi veramente dalla terra in cui si è cresciute, come le palme tenaci che anche una volta strappate “ricacciano” di nuovo.
Al centro della narrazione c’è una terra struggente e ferita, la cui fragilità ancora si sente, a un anno dal terremoto che ne ha squassato la superficie, una terra ballerina, abitata da una Sibilla vendicativa, pronta a rovesciare montagne e a far tremare le valli.
Come ne Gli Oscillanti, anche qui il mondo naturale è vivo e misterioso, un mondo di mostri e creature magiche, di grotte e nascondigli per fate e sibille. Ma se nel romanzo di Morandini la montagna si inabissa, schiacciata da una gravità che lentamente trascina verso il profondo, qui agisce una forza sotterranea diversa, tellurica e improvvisa, quella della montagna che trema e si arrabbia, scrollandosi di dosso gli uomini e la loro sciocca superbia.
La nuova stagione racconta di una terra che non si possiede davvero, che scappa da confini sempre labili, che hanno la stessa goffa imprecisione della posizione umana dentro il mondo naturale, e cerca di coniugare l’aspetto oscuro e sibillino di quei territori con un presente che sembra negarne la forza, e tenta di imbrigliarla in monoculture industriali e di avvelenarla con i pesticidi delle coltivazioni intensive.
Ballestra ne scrive con una lingua che abita spazi naturali e ricerca la poesia dei luoghi, una scrittura che assume una particolare cadenza, che imita il linguaggio sibillino della montagna, lingua di fate e oracoli e di dialettismi torniti dal mondo vegetale e minerale che vogliono descrivere: la lingua delle valli del cuore dell’Italia, che “alla fonte parte tutta contratta e petrosa come le montagne da cui sgorga per poi andarsi a sciogliere lentamente lungo il corso del Feronia”; i reperti melodici di una “cosmogonia pagana che informa la lingua come fosse parlata da un’archeologica statuina di bronzo picena…” e le cui tracce permangono nei toponimi e nelle parole indecifrabili che custodiscono “lu genius loci”.
Anche nel romanzo di Ballestra si insegue quindi l’eco di voci da un mondo perduto e anche qui si riconosce una particolare fascinazione per le creature della terra, per l’incredibile varietà animale e vegetale che la abita senza conflitto, ma anche l’influenza di una dicotomia allegorica che oppone ciò che sta in superficie e ciò che è sotterraneo, e la ricerca di un punto di dialogo e riconnessione. Ne è un esempio il tasso, animale dal forte potere simbolico che vive nelle profondità dei terreni di Olga: “un architetto del sottosuolo, un abitatore profondo dei luoghi”, una “laboriosa creatura capace di tenere uniti il sotto e il sopra, l’essere un po’ soprannaturale e al tempo stesso assai terrestre che aveva accesso alle viscere della collina ove si immergeva segretamente, facendo la spola dentro e fuori per stringere un legame ancora più forte tra ciò che vi era, là sotto, di sepolto e notturno e ciò che invece era all’aria, disteso alla luce”.
In entrambi i romanzi si rintraccia il tentativo di descrivere lo spazio di un incontro, favorito da questi luoghi di mezzo, ancora permeabili a un mondo da cui l’uomo è dolorosamente strappato, che parla una lingua dimenticata, di cui pastori e contadini conservano il suono di qualche parola. Ed entrambi i tentativi si risolvono con una partenza, un distacco che pare salvifico ma provvisorio, e conserva un presentimento, l’idea che non si fugga mai veramente ai propri luoghi, alle proprie radici e che un passato più grande di noi sopravviva sotterraneo, pronto ad affiorare come eco lontana, come verdi e teneri ricacci di palma.







