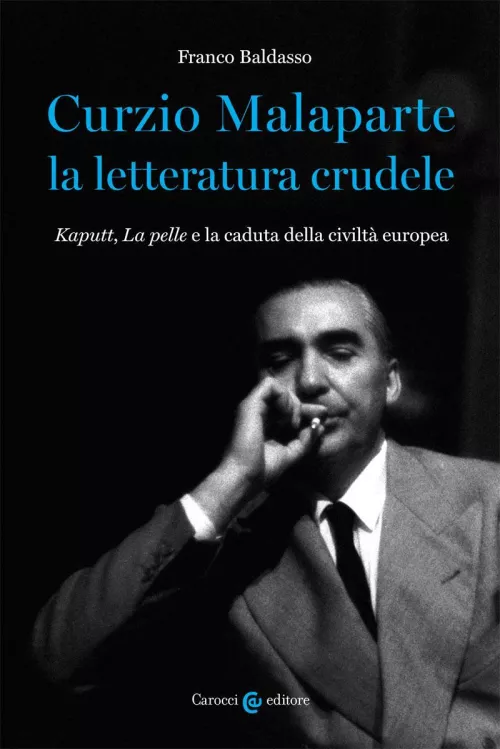Ambiguità e ambivalenze / Curzio Malaparte e la caduta della civiltà europea
Curzio Malaparte è uno dei non numerosi scrittori italiani del Novecento a essere riconosciuti all’estero. Fin dagli anni Trenta, da quando Technique du coup d’État (1931) e Le bonhomme Lénine (1932) furono pubblicati direttamente in francese, la lingua transnazionale dell’epoca, le opere di Malaparte hanno goduto di una circolazione e di una ricezione critica globali – un paio d’anni fa gli è stato consacrato, per esempio, un Cahier de L’Herne. In Italia, invece, Malaparte è stato un autore difficile da affrontare, sia in vita sia dopo la morte. Soltanto nell’ultimo decennio la sua figura intellettuale e le sue opere hanno cominciato a uscire dall’ombra, grazie soprattutto alla riedizione di alcuni scritti e alla pubblicazione di inediti da parte della casa editrice Adelphi (su cui si può leggere un’intervista rilasciata da Giorgio Pinotti all’«Indice dei libri del mese» nel novembre 2017).
Sono almeno due i fattori che hanno reso accidentato il discorso critico su Malaparte: da una parte, una figura pubblica ingombrante e un altrettanto ingombrante narcisismo, che hanno generato uno strascico di inimicizie e antipatie, e la tendenza a prestar più attenzione alla biografia che alle opere; dall’altra, un ambiguo e sfuggente posizionamento nei confronti del fascismo, di cui lo scrittore è stato aspirante ideologo e intellettuale di punta, e all’interno del cui meccanismo coercitivo ha ricoperto tanto il ruolo del persecutore che del perseguitato. Affrontare questa figura e le sue scelte politiche richiede pertanto un discorso storico-critico esente da manicheismi, che non sempre è stato possibile nella storia repubblicana.
Nel suo ultimo libro Curzio Malaparte, la letteratura crudele. «Kaputt», «La pelle» e la caduta della civiltà europea, Franco Baldasso ingaggia un corpo a corpo vittorioso con questo intellettuale aporetico e contraddittorio, senza mostrare indulgenza nei confronti del proprio oggetto ma gestendo con abilità l’intreccio di biografia e analisi delle opere per render conto della vitalità e dell’interesse di queste ultime. Il libro non si occupa se non tangenzialmente degli esordi della traiettoria intellettuale, politica e creativa dello scrittore – non si occupa cioè del Malaparte scandaloso di Viva Caporetto! (1921), del direttore della rivista «La Conquista dello Stato», dell’intellettuale strapaesano la cui mirabolante scalata agli apparati culturali del regime viene interrotta (ma non definitivamente) dalla condanna al confino nel ’33. Baldasso individua infatti il nocciolo più attuale e originale del pensiero dello scrittore nelle opere scritte durante e dopo la seconda guerra mondiale. Nei suoi romanzi più celebri, Kaputt (1944) e La pelle (1949), e in opere meno note come la pièce teatrale Das Kapital, messa in scena a Parigi nel 1949, e il film Il Cristo proibito, presentato a Cannes e al primo Festival del Cinema di Berlino nel 1951, Malaparte si è prefisso il compito di descrivere, investigare e comprendere la «caduta della civiltà europea»: una prospettiva che gli consente di creare con Kaputt e La pelle le uniche narrazioni italiane della seconda guerra mondiale che abbraccino un orizzonte autenticamente mondiale.

Il racconto di Malaparte, attraversando svariati teatri di guerra europei e un’Italia disfatta percorsa da soldati di ogni nazionalità, costruisce un’immagine della guerra anomala ed eccentrica rispetto a quella elaborata nei tardi anni Quaranta e Cinquanta da scrittori e memorialisti italiani, dediti perlopiù alla narrazione di un’esperienza nazionale fatta di imperizia militare, guerra civile, disillusioni e/o rinnovate passioni politiche. L’orizzonte in cui si inscrive la rappresentazione malapartiana, invece, eccede la singola nazione, e non è neppure definibile come internazionale, ma è piuttosto comprensibile, adottando il lessico di una tradizione filosofica successiva, come un orizzonte biopolitico: Malaparte «rivela come il nuovo grande protagonista del conflitto non sia più la razza umana ma la tecnologia» (p. 14), e le sue concrezioni creative, come mostra Baldasso nel corso del libro, possono entrare in dialogo con il pensiero di Arendt, Agamben ed Esposito.
Le opere postbelliche di Malaparte possono essere lette attraverso il filtro di questa tradizione filosofica perché provengono da un intellettuale rimasto ai margini dell’universo culturale e politico del neorealismo e della ricostruzione, e perciò rimasto estraneo anche alla rigidità delle interpretazioni ideologiche del passato recente imposta dalla guerra fredda. La marginalità di Malaparte nel campo intellettuale italiano postbellico dota insomma lo scrittore della lucidità dell’escluso, che lo avvicina ad altri intellettuali insoddisfatti dall’atmosfera culturale e politica dei tardi anni Quaranta: il Pavese degli ultimi romanzi – La casa in collina (1948) e La luna e i falò (1950) – e il Carlo Levi dell’Orologio (1950). Ad accomunare l’ex fascista, lo scrittore che si nasconde in un convento durante la guerra civile, e l’intellettuale antifascista che canta l’elegia del Partito d’Azione, è un approccio obliquo, perché antropologico invece che storico, al trauma della guerra. Nei tre autori troviamo una stessa lettura del conflitto attraverso il nesso di sacro, violenza, sacrificio: la domanda del narratore della Casa in collina («e dei caduti cosa ne facciamo? perché sono morti?»), il sacrificio della collaborazionista Santina nella Luna e i falò, la definizione nell’Orologio del Presidente del Consiglio Parri come rappresentante non di un movimento politico contingente, ma del consesso a-storico dei morti, affondano nello stesso terreno da cui sgorgano le domande inconciliate dei romanzi di Malaparte.
E non dei romanzi soltanto. Il libro di Baldasso sottrae all’oblio Il Cristo proibito, l’ultima rilevante opera creativa di Malaparte, nel cui protagonista – un reduce alla ricerca di una giustizia i cui tratti storici mascherano un sostrato mitico e tragico – possiamo leggere una proiezione dell’autore. Anche Malaparte è un reduce in quanto non può «figurare tra gli eroi», ed è «testimonianza vivente di un passato che si voleva dimenticare» (p. 84). L’identificazione è però parziale e ambivalente, visto che il primo a non voler fare i conti con il passato è stato Malaparte stesso, mai venuto a patti con la propria compromissione con il regime fascista – una compromissione durata ben oltre la disillusione seguita alla condanna al confino.
Ambiguità e ambivalenza, d’altra parte, sono tratti costitutivi anche della cornice formale delle sue opere maggiori: Kaputt e La pelle sono romanzi di autofiction enunciati da un testimone che mescola liberamente, anzi, che dichiara di mescolare liberamente realtà e finzione. L’istanza narrativa di Kaputt e La pelle tanto distanzia i capolavori di Malaparte dall’humus neorealista, affamato di realtà e verità, quanto li avvicina alla letteratura dei nostri anni, come ha messo in luce per esempio lo scrittore Nicola Lagioia. «Mettendo l’artificio in primo piano e strizzando l’occhio al lettore chiedendone la complicità» (p. 33), i romanzi di Malaparte sfidano i lettori di oggi a tentare un dialogo “impossibile” – ma più volte saggiato da Baldasso nel suo libro – con Primo Levi: un altro scrittore-testimone la cui opera nasce nel cuore di tenebra della seconda guerra mondiale; un altro scrittore italiano di rilievo globale ma soltanto tardivo riconoscimento nazionale.