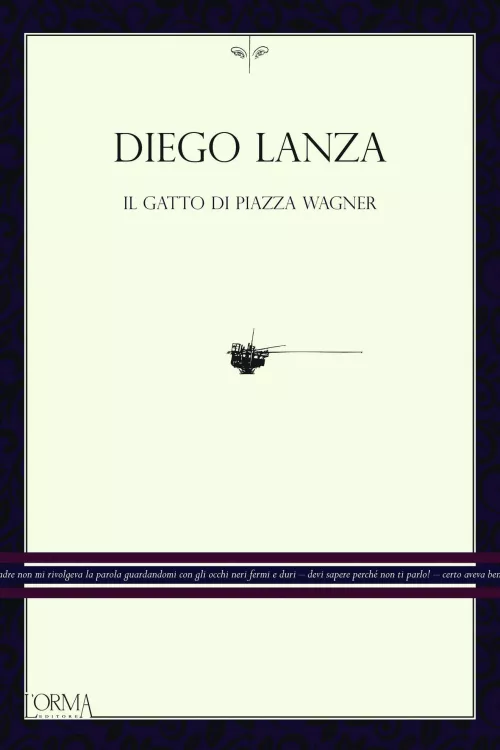Cesare Cases e Diego Lanza / Milano nei ricordi
Destino delle città è cambiare in continuazione, così come compito di ogni generazione, specialmente se urbana, è raccontare la propria storia, una storia che di solito comincia dall’infanzia per salvare i frammenti di un mondo che ogni volta inesorabilmente scompare. Vale anche per Milano, “la città più città d’Italia” (Giovanni Verga), che non abbonda di molta memorialistica che la riguarda, almeno per il XX secolo. Per dire, non esiste l’equivalente di un libro pubblico come i Cento anni di Rovani o di uno privato come le Note azzurre di Carlo Dossi. Milano è l’ambiente di due libri di recente uscita intrecciati da una serie di motivi biografici (il rapporto col padre, l’educazione letteraria) e dalla comune moralità.
Il primo è Cosa fai in giro? di Cesare Cases, un lacerto autobiografico che il grande germanista scrisse in occasione del quarantesimo anniversario delle leggi razziali (1978), con una storia testuale ricostruita da par suo dal curatore del volume (e amico di Cases) Luca Baranelli. Il secondo è Il gatto di piazza Wagner (L’Orma Editore), un memoir tra fascismo e anni Cinquanta, trovato dopo la morte tra le carte di Diego Lanza (1937-2018), insigne grecista.
Cesare Cases, classe 1920, è stato un protagonista della cultura italiana della seconda metà del Novecento: docente universitario di lingua e letteratura tedesca, grande traduttore, saggista e polemista, consulente della casa editrice Einaudi, ha raccontato la sua vita nelle Confessioni di un ottuagenario (2000), un volume un po’ discontinuo che non ha la verve e la sapienza che si ritrova nelle sue raccolte di saggi come Patrie lettere (1974), Il testimone secondario (1985) e Il boom di Roscellino (1990). Milanese, di famiglia ebrea e borghese, marxista dopo la guerra, ha seguito la letteratura e la critica tedesca contemporanea (Lukàcs, Brecht, Hans Mayer, Thomas Mann) con soggiorni nella DDR di cui è stato un estimatore in chiave anticapitalista. È stato un intellettuale militante, un ruolo che ha esercitato con consapevolezza, ma che non si ritrova in questa bellissima prosa di memoria, nella quale il tono è pacato, l’ironia (e forse anche la scrittura) di ascendenza manzoniana, dove rivive una Milano scomparsa in cui, dopo l’8 settembre, un conoscente chiede al padre avvocato: “Cases ‘ste fet in gir?” Risposta: “Fin che gh’è minga de legg”. Conclusione: “Legg o minga legg, quej lì a voialter ve ciapen e ve portan via l’istess”. Cases, allora già al riparo in Svizzera, commenta che il padre “era ottenebrato dal formalismo giuridico (forse di origine ebraica, ma lui non se ne rendeva conto)”, che in quel momento prevaleva sul “realismo milanese”.
La discriminante ebraica comincia con le leggi razziali nel 1938, fin ad allora “essere ebrei significava soltanto costituire a pieno diritto una porzione della borghesia che aveva origini e in parte costumi diversi dalle altre”. Il padre visse questo momento “come un’irreparabile degradazione” in una città dove “i rapporti sono quasi esclusivamente rapporti di lavoro”. Il padre di Cases è il borghese del Novecento, l’uomo tranquillo che vuol lasciare fuori dalla porta di casa gli affanni della vita quotidiana, ma la storia del XX secolo non glielo consente. Cases si prende gioco dell’incompatibilità di borghesia e spirito ebraico predicata da Benjamin, Gershom Scholem e Bloch, diffusa dalle nostre parti da Ceronetti, Calasso, Zolla, ribadendo, al contrario, che essere ebrei è solo un modo di essere borghesi. Per farlo rievoca la cerchia famigliare e amicale dei Cases dove, ultima testimone, vive, quasi centenaria, Franca Valeri, allora Franca Norsa, compagna di scuola al Liceo Parini. Il sionismo non fu popolare tra gli ebrei milanesi che anzi cercarono di non perdere i vantaggi dell’integrazione anche dopo il 1938. Nacque però una scuola ebraica, arrivarono ebrei dall’Europa centrale e l’avanzare della guerra sconvolse un mondo mai destinato a ritornare. A cambiare Cases fu il soggiorno in Svizzera dove fu raggiunto dall’intera famiglia nel 1943. Al ritorno, nel 1945, ogni famiglia ebraica fece il conto dei sopravvissuti o degli scomparsi: singoli individui o intere famiglie. Cases ricorda un incontro con Primo Levi nella Milano del 1945 e il suo enorme bisogno di raccontare “non tanto per spiegare agli interlocutori un’esperienza che trascendeva ogni forza d’immaginazione quanto per affermare il proprio indomito razionalismo”.
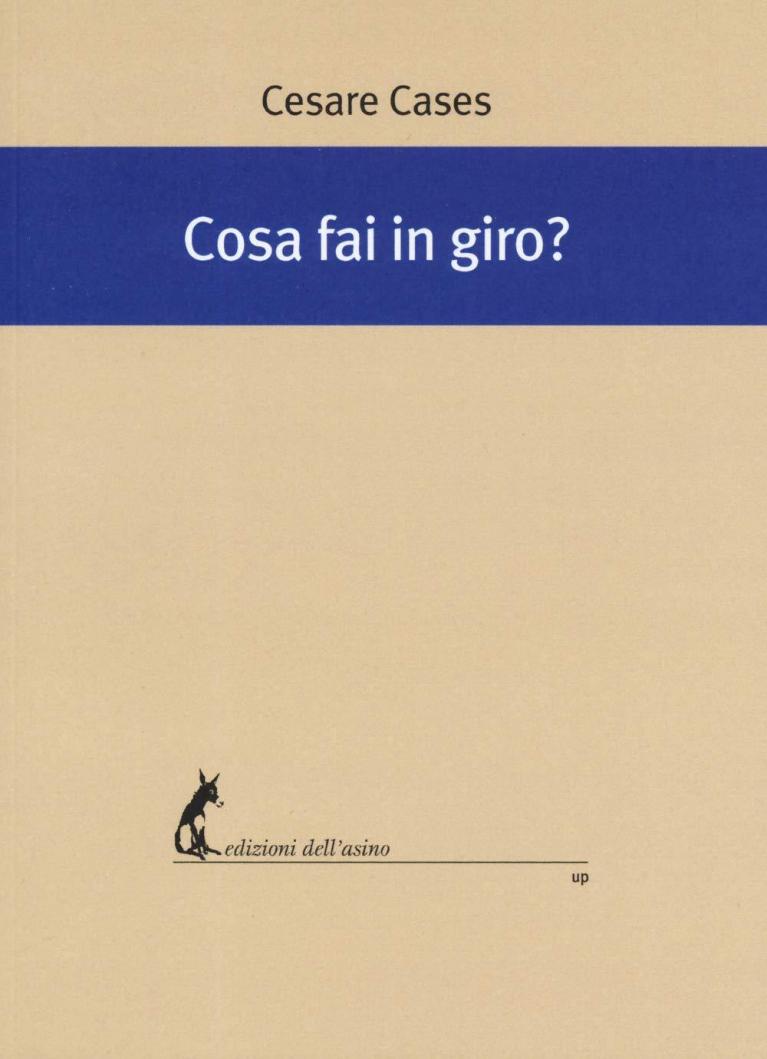
Dopo il 1945 se da un lato cambiò tutto e l’Olocausto dimostrò che l’umanità diventava sempre più superflua – Cases ricorda quanto scrisse al proposito Frantz Fanon: “l’orrore suscitato da quel massacro deriva dal fatto che gli europei avevano applicato a una parte di se stessi il trattamento da loro fino a quel momento riservato ai popoli coloniali” –, non nacque tuttavia una nuova società: “le strutture mentali borghesi si ricostruivano immutate come l’economia, e gli ebrei cooperavano alla bisogna non meno di altri”. Non nacque un mondo nuovo nemmeno in Israele, le speranze palingenetiche si infransero – come ha scritto Bruno Segre, un altro ebreo milanese, in Che razza di ebreo sono io – dopo la guerra dei 6 giorni. Conclude Cases: “oggi, gli ebrei sono riusciti a diventare ‘come tutti gli altri’, cioè armati fino ai denti, oppure sono tutti gli altri che sono diventati come gli ebrei, inermi e superflui davanti al potere che servono”. Sono passati più di quarant’anni e le cose non han fatto che peggiorare. Fu probabilmente la prima volta che Cases si confrontò con se stesso, con la propria autobiografia. Il risultato è memorabile: in questo testo Cases riscatta “la mitezza” del padre e rende universale una vicenda individuale.
“Di chi sono i ricordi? So di ricordare cose che non ho mai visto, che non avrei mai potuto vedere, che si compirono prima, persino molto prima della mia nascita. Eppure anche questi ricordi mi appartengono, sono miei”. È una domanda centrale quella che si pone in avvio Diego Lanza, figlio di Giuseppe, di origine siciliana, aspirante commediografo con gli auspici di Pirandello, poi giornalista e scrittore, amico di Solmi e di Montale, e di una madre ebrea, originaria di Odessa, scappata con la famiglia dopo la Rivoluzione d’ottobre. “La mamma è andata nel paese dei cigni”, così comunicano al piccolo Diego la morte della madre. Ha solo sei anni ed è il sentimento di un’assenza lo sfondo di questi bellissimi ricordi. Il padre, un intellettuale che dopo essere stato una giovane promessa della letteratura ora è pieno di frustrazioni, si sente inadeguato a far crescere un bambino da solo.
Inoltre dopo i bombardamenti dell’agosto 1943 su Milano l’autore è prima messo in collegio a Erba, poi presso una famiglia a Seregno, nella bassa Brianza, dove il piccolo cresce nell’ambiente comunitario di una cascina, un luogo che non è città ma nemmeno vera campagna. Il padre, che deve proteggere la famiglia della moglie scomparsa, gira con documenti falsi, vivendo “alla macchia”. Diego Lanza era cresciuto tra le due guerre nell’ambiente bohémien milanese, fatto di accanite discussioni letterarie nelle latterie dietro il Duomo, anche se, come l’amico Sergio Solmi, era impiegato di banca. Lanza resuscita la memoria famigliare attraverso vecchie fotografie e le corrispondenze del padre (l’amicizia con Montale si affievolisce quando questo diventa noto), ma i ricordi diventano più precisi dopo la Seconda guerra mondiale. Milano è una citta piena di voragini create dalle bombe alleate, dove il consorzio umano si ritrova dopo il diluvio. Sfila qui una galleria di ritratti come la zia Bela, un’amica della madre in cui l’affetto si mescola alle aspirazioni piccolo borghesi, o lo zio Ramik, un vero zio d’America, che gli fa conoscere i primi frutti della società dei consumi, l’American way of life. Il ragazzo ne è affascinato, ma non conquistato. Più tardi nota come i principi di libertà, il sano pragmatismo americano sono piuttosto un’“astratta e spesso vaga dichiarazione di pragmatismo”. Altro ritratto a puntino è quello dei vicini di casa, Iole e Nino, giunti a Milano dalla natìa Sardegna, integratisi nella grande città, ma poi pronti a tornare, o quello di Bixio Cosuli, esule fiumano, fedele alla memoria di d’Annunzio, che traffica nel mondo dell’arte per poi fondare una fortunata agenzia giornalistica.
Lanza ha il dono del ritrattista, con pochi tocchi sa rievocare un mondo di cui si è perduta memoria, una Milano che era il punto d’approdo di vicende famigliari diversissime, unificate attraverso la religione del lavoro. Notevolissime anche le pagine sul quartiere attorno alla Fiera, allora in costruzione, e la vita intensa di via Canonica, arteria commerciale precocemente multietnica. E poi i ricordi di scuola, luogo di mescolamento sociale, ma anche di precisioni distinzioni di classe che terminavano nelle infinite partite a pallone negli spiazzi creati dalle bombe alleate. Lanza ha scritto queste pagine probabilmente in limine vitae e riesce a offrire questa lezione davanti al passo estremo: “quando l’incombere della fine conquista anche l’anima del nostro corpo, allora significa che la morte è già iniziata, e il morente non può donare ai suoi cari che la serenità della rassegnazione”, mentre a noi ha donato questo bellissimo frutto fuori stagione.