Cibo profano e cibo sacro / Seimila anni di pane
Seguire la storia e la geografia del pane vuol dire ripensare da un preciso punto di vista la storia e la geografia del mondo dans tous ses états: l’economia, la cosmologia, la politica, la religione, la socialità, l’arte e ovviamente la gastronomia vi sono coinvolte in modo sempre diretto e pertinente. Si imparano così un sacco di cose. Venendo peraltro indotti a ripensare a tante altre che credevamo di sapere, le quali invece, a conti fatti, risultano rivedibili. Difficile esimersi da un gioco siffatto, troppo importante per metterlo da canto. Difficile affrontarlo, non foss’altro perché fugge da tutte le parti, scoperchiando gli abissi della nostra ignoranza.
Aprire I seimila anni del pane. Storia sacra e storia profana di Heinrich Eduard Jacob – un grosso volume finalmente ristampato da Bollati Boringhieri dopo decenni di rimozione (pp. 463, € 22) – fa un po’ quest’effetto. Basta leggerlo tutto quanto, senza saltare le apparenti digressioni: e cioè quelle dove il pane, sparendo, si fa portatore di istanze e valori ben più grandi di lui. Appaiono così temi come la struttura sociale degli antichi Egizi e i comandamenti di Mosè, i misteri eleusini e l’organizzazione burocratica dell’Impero romano, le invasioni barbariche, il dogma dell’Eucarestia, la grande fame medievale, la peste nera, la scoperta dell’America, la presa della Bastiglia, giù giù fino alla rivoluzione bolscevica, le guerre mondiali, il delirio hitleriano. Il libro è stato pubblicato negli Stati Uniti nel 1944, tradotto in Italia da Garzanti nel ’51, e poi sostanzialmente dimenticato. I molti testi sul medesimo argomento che più conosciamo – per esempio: Il pane e il circo di Paul Veyne (1976), Il pane selvaggio di Piero Camporesi (1980), Il pane di ieri di Enzo Bianchi (2008), Pane nostro di Pedrag Matvejevic (2009), per non parlare della monumentale Storia dell’alimentazione di Flandrin e Montanari (1996), punto di riferimento per ogni discorso sull’argomento – gli devono molto ma, a conti fatti, non lo esauriscono. Il libro di Jacob sul pane è ancora pienissimo di informazioni e riflessioni di prima mano, non foss’altro perché scritto da un autore sui generis, estraneo ai saperi tradizionali sul cibo e la cucina, e proprio per questo portatore di uno sguardo tanto strabico quanto illuminante.
Heinrich Eduard Jacob (1889-1967) non era un storico né un antropologo, semmai uno scrittore (pochissimo noto in Italia) e più che altro un giornalista, un divulgatore, una specie di erudito dilettante, un curioso di talento. Oltre a un certo numero di drammi, romanzi e novelle, ha ricostruito con cura le vite di Mozart, Mendelssohn e Strauss, e ha pubblicato nel ’34 una Biografia del caffè, tradotta in italiano da Bompiani nel ’36 e mai più ristampata. Ebreo tedesco, fu internato a Dachau e poi a Buchenwald, liberato grazie a un parente americano, ed emigrato negli USA. E proprio questa drammatica esperienza nel lager viene descritta in chiusura al volume come un problema basilare circa il pane. Nel campo di concentramento, scrive Jacob, si chiamava ‘pane’ una cosa che non lo era: piuttosto una miscela di patate, piselli e segatura di legno. “L’interno era colore del piombo, la crosta aveva l’aspetto e il sapore del ferro. E questo pane sudava acqua come la fronte di un uomo torturato”. Nondimeno “lo chiamavamo pane, in memoria del pane genuino che avevamo mangiato un tempo. L’amavamo e non vedevamo l’ora che venisse distribuito”. Esperienza estrema che, secondo Matvejevic, motiva l’esistenza stessa del libro, la sua appassionata accuratezza: “Ci si può domandare – leggiamo in Pane nostro – se Jacob avrebbe scritto un testo di quel valore se non si fosse venuto a trovare in quel posto e non avesse dovuto mangiare un pane del genere”.
Ricostruire i seimila anni del pane significa innanzitutto, per Jacob, presuppore i diecimila precedenti, quelli che sono occorsi all’uomo per inventarlo, per passare cioè dalla spiga alla michetta. Se, come a lungo (e giustamente) s’è pensato, il pane è il maggiore prodotto della specie umana (ben più del vino, della birra e dell’olio, suoi compari mediterranei), quello che effettivamente la caratterizza per il suo progressivo distacco dallo stato di natura, è perché si tratta dell’esito di un processo di produzione estremamente complesso. Occorre arare il terreno, seminare, falciare, trebbiare, macinare i chicchi, eliminare la crusca, impastare, far lievitare, dare una forma, infornare… tutte azioni che richiedono un enorme sforzo mentale prima ancora che manuale, nonché l’apposita ideazione degli attrezzi necessari per portarle a termine presto e bene: l’aratro, la falce, il forno... E del resto già il grano, un po’ come il cane, è un’invenzione umana: un qualcosa che esiste in una natura già trasformata dall’uomo a suo uso e consumo, una pianta addomesticata che non solo è ben diversa dal suo avo selvatico ma non può riprodursi se non per mano umana. Insomma “il grano, il quale dà la vita all’uomo, vive a sua volta solo per grazia dell’uomo”.
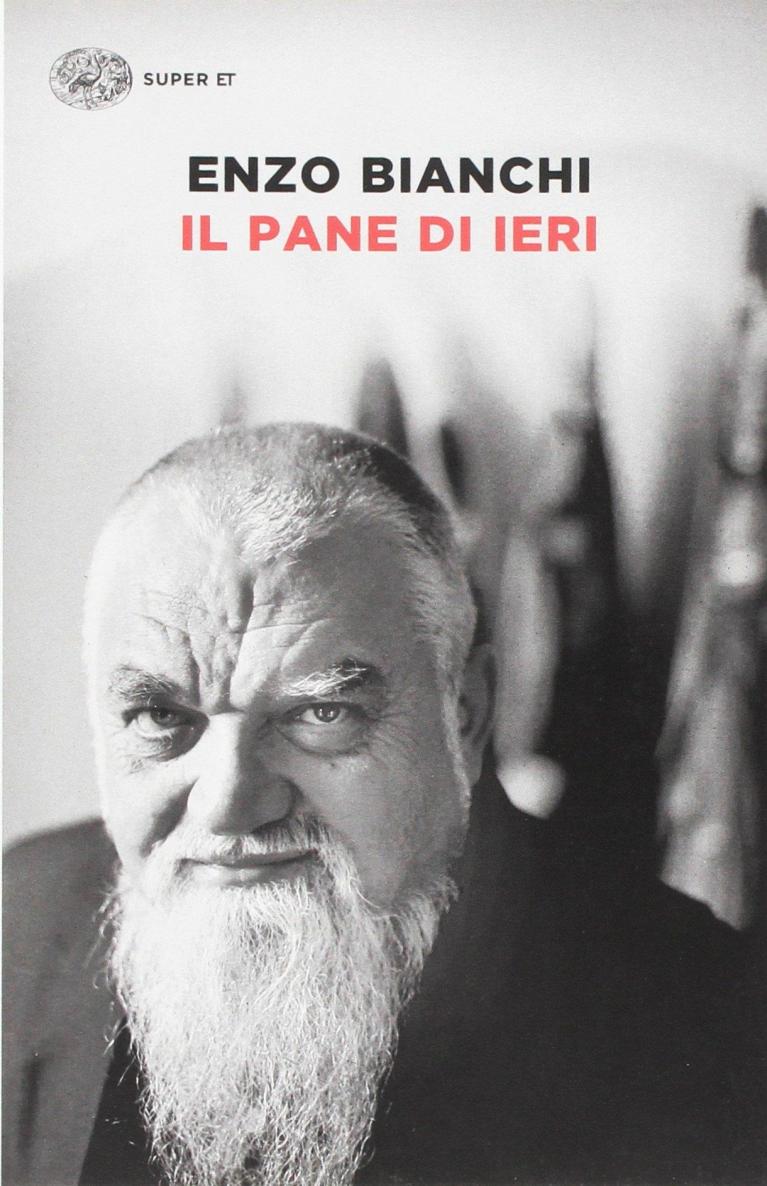
L’ideologia alimentare entro cui il pane si colloca è nota: da un lato la sua esistenza impone una qualche stanzialità, dunque il superamento del nomadismo dei cacciatori e dei raccoglitori; dall’altro esso sta dal lato dei vegetali di contro alle carni e ai grassi animali, tipici invece dell’alimentazione nel Nord. L’invenzione millenaria e collettiva del pane richiede innanzitutto una terra di cui prendersi cura, con la quale entrare in fervido e amorevole contatto quotidiano, una terra amica e generosa, come quella delle valli dell’Eufrate o del Nilo, dove le acque irrigano periodicamente il terreno rendendolo fertile. Grazie al pane nasce l’idea stessa di casa e di villaggio, di cultura e di patria: dalla semina all’infornata passa almeno un anno. Il popolo ebraico, a lungo nomade prima di trovare la terra promessa, mangia ancora pane azzimo nelle occasioni festive proprio per ricordare le sue origini antropologiche più antiche: girovagando, non c’era tempo e modo di far lievitare la pasta. E grazie al pane si fanno e di disfanno imperi come quello romano o quello carolingio. A causa sua scoppiano continue rivolte popolari quando non intere rivoluzioni. In suo nome si istituzionalizzano le relazioni sociali, si impongono tributi e si batte moneta. Nell’antico Egitto, dove è nata per la prima volta l’idea di infornare la pasta lievitata, la gente veniva pagata in pagnotte. E a Roma il popolo era tenuto a bada con distribuzioni regolari di frumento e orridi spettacoli del circo.
Così, la discesa degli Unni, prima ancora di sparger sangue e distruggere civiltà millenarie, diede luogo a un conflitto fra due opposte diete alimentari – la mediterranea vegetariana e la nordica carnivora –, dove entrambi i contendenti dovettero non senza fatica abituarsi all’altro: il panino con l’hamburger è l’emblema più visibile di quella che diverrà l’alimentazione europea medievale e moderna, faticosa sintesi di stanzialità e nomadismo, cibi vegetali e cibi animali. Grazie anche alla considerevole mediazione del Cristianesimo, che parlava di sacrificio divino, trasformando, col miracolo della transustanziazione, il pane in carne.
Dal pane profano a quello sacro, dunque, non c’è che un passo. Il pane è stato a lungo considerato il cibo assoluto, in quanto esito di un perfetto equilibro fra caldo e freddo, secco e umido – fattori ritenuti costitutivi di ogni alimento. Inevitabile che avesse ruoli da protagonista in molteplici forme religiose. In Grecia, dove il terreno assai roccioso non aiutava le pratiche agricole, c’era una dea apposita, Demetra, che s’occupava di proteggere i raccolti, ma anche di seguire tutte le fasi della lavorazione del pane, facendole assurgere al rango di riti sacrali. Coltivare la terra e panificare erano modi per onorare la dea. Nacquero così sul continente e nelle isole, colonie comprese, centinaia di santuari per Demetra, che erano praticamente imprese agrarie. I Greci, guerrieri per vocazione, trasformarono in tal modo le spade in aratri, e fecero del pane il loro alimento preferito. Dal canto suo la dea si premurava di fornire al lavoro agricolo un mito fondatore niente male. Come il seme sparisce nella profondità della terra per tornare alla luce, moltiplicato, dopo mesi di lavorio nascosto, così Persefone, figlia di Demetra, si trova costretta a scendere nell’Ade quattro mesi all’anno, per ritornar su più vitale che mai. Il racconto mitologico fa uso di un’analogia sorprendente, umanizzando al tempo stesso la pianta e la divinità, ma soprattutto facendo del pane un alimento che mette in comunicazione (e in comunione) gli dèi e gli uomini. Nella ciclicità delle stagioni sta la base della civiltà umana. Di modo che l’idea di resurrezione – che il Cristianesimo saprà usare molto bene con l’immagine del Dio fattosi uomo – si configura come un atto simbolicamente agricolo.







