Speciale
Tra gli scaffali del supermercato
Rovinata l’ultima scatoletta, ingurgitato l'estremo sorso di birra, spremuto quel dimenticato pacchetto di crackers nel fondo polveroso dello scaffale su in alto, svuotata del tutto la dispensa, mi tocca far la spesa. È domenica mattina, e il supermercato che frequento da più di vent’anni sarà pieno di gente come me, disperata e indaffarata giusto nel giorno in cui il Signore si riposò, a ennesima dimostrazione che, per noi post-liquidi-moderni, consumare è l’unico modo per riempire il tempo libero.
Ma il problema non è questo. È ben più grave. Entro e al posto dell’arredo da giardino, dei giocattoli e della roba per la scuola trovo le patate e le cipolle, in generale frutta e verdura. Viro a destra alla ricerca del sapone e dello shampoo e mi appaiono snack, frites d’ogni tipo, noccioline, bastoncini con cristalli di sale, cose scricchiolanti varie (grilli?). I detersivi sono un po’ più in là, dove di solito stazionano pasta sfoglia e brisée surgelate, pappardelle fresche, tortellini, insaccati in busta, wurstel e panpizza già infornato. Disorientato, chiedo a un commesso ma temo d’aver già capito: stanno risistemando TUTTO lo spazio vendita, gli scaffali, gli espositori, i frigoriferi, i banconi del fresco, quelli dei salumi e dei formaggi, del pesce e della carne, la zona dell’acqua minerale, di modo che la birra è andata a finire là dove indugiava la carta igienica e il rotolone per la cucina, mentre il vino, mi par di capire, è adesso dove c’erano i pacchi di pasta. Riso, cuscus e granaglie varie sono spariti, o per meglio dire non si trovano, magari adesso stanno al posto dei calzini da palestra, mentre la gastronomia, che negli scorsi decenni era in fondo a sinistra, la trovo vicino alle casse, accanto alle chewing gum, alle batterie e ai profilattici. Il commesso (perplesso, avvilito, sudato) prova a darmene – e a darsene – una ragione: adesso è tutto più chiaro, razionale, facile da trovare, dice a mezza voce mentre la gente tutt’intorno emette furia gassosa dalle narici dilatate. Non si capisce niente, lamentano in molti. Dove saranno il tonno sott’olio, i pomodori pelati, la pasta d’acciughe, i biscotti, i cornetti con la marmellata?
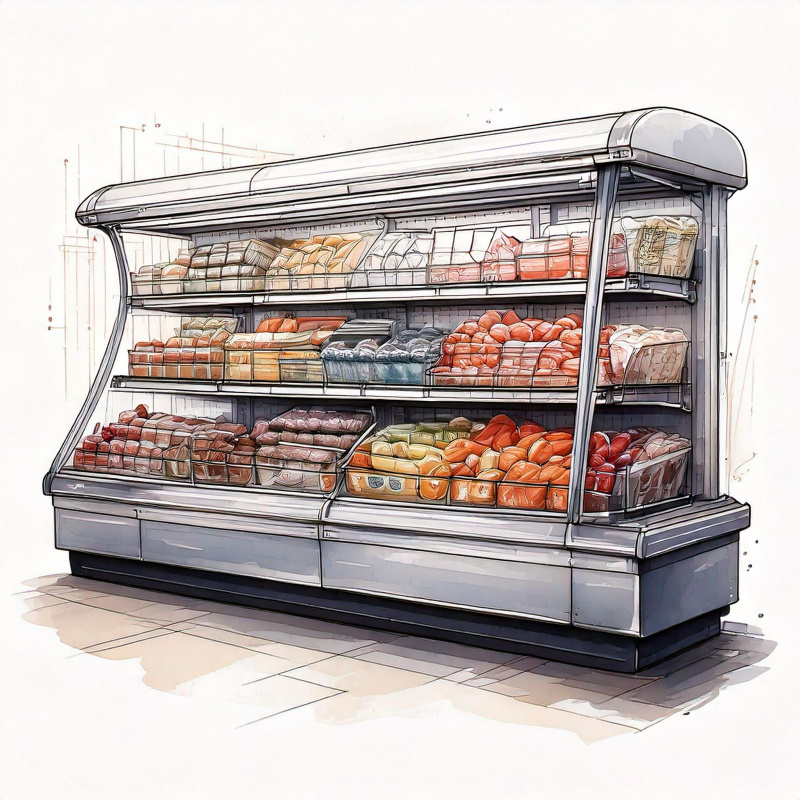
Mi viene da pensare a mia madre, che negli ultimi anni non vedeva più ma di quel posto conosceva ogni anfratto a memoria e si orientava come una guida di montagna, sgattaiolando fra un corridoio e l’altro e riempiendo il carrello che io, ansimando, trascinavo a suo servizio. Ero lì per accompagnarla, in linea di principio, ma nei fatti era lei ad accompagnare me. Se fosse entrata adesso sarebbe caduta in un’angoscia senza pari, come un corpo privo di protesi a sostenerlo, un soggetto senza la più la esse. E io, fresco di raccolta differenziata dei rifiuti appena arrivata dalle mie parti (no comment), raddoppio una risemantizzazione tassonomica dell’universo che nemmeno i futuristi migliori. Appare chiaro che è l’ordine delle cose – artificiale quanto si vuole, ma comunque funzionale – a essere la protesi, appunto, che media fra tali cose e noi, esseri altrimenti senza arte né parte. A casa passo il tempo a capire in quale contenitore stipare il tetrapack e i vetri rotti; qui il mio istante si perde a cercare lo zucchero e l’acqua tonica.
Spreco di tempo? nebbia cognitiva? entropia inutile? Temo sia questione peggiore. Questi qua, presi da una hybris catalogatoria che nemmeno Linneo, hanno cambiato di posto le cose che stanno nel mio supermercato d’una vita; mio per dire, ovviamente, dato che in questo non luogo da tanto tempo familiarizzato insistono migliaia di persone fra due quartieri – ipoborghese l’uno, iperpopolare l’altro – assai affollati. Posso immaginare che le regole del retail marketing che i miei studenti ripetono, compiti e soddisfatti, all’esame del mio collega d’ufficio siano andate a farsi benedire. Altro che strategia espositiva occulta atta a vendere di tutto e di più. Dove cade l’occhio del consumatore, e dove dovrebbe cadere per fregarlo a puntino, non è faccenda che interessa gli addetti specializzati delle mie domeniche mattina. Loro pensano solo a riempirlo di più, ad ammassarlo fino all’inverosimile, magari convinti di fare il meglio per i loro clienti, in barba a ogni albero di Porfirio che vorrebbe aspirare a rendere logica la disposizione dei beni – materiali e immateriali – del mondo. Abbiamo letto abbastanza Perec per aver assimilato l’idea che nessun ordine è definitivo, depositando inevitabilmente un resto inclassificabile, ma che ogni ordine ha tuttavia la sua ragion d’essere pratica, un suo messaggio da inviare alla variegata comunità di uomini e cose.

Italo Calvino, che di supermarket si intendeva sin dalle loro origini, vi aveva spedito un Marcovaldo eccitato dalla profusione dei beni diffusi dal consumismo degli anni Cinquanta. Si ricorderà che il tragicomico manovale di campagna prestato alla città saturava il carrello non per necessità ma per gioco, dato che il suo misero stipendio non avrebbe mai potuto accontentare la signorina occhialuta della cassa. Per lui fare la spesa era un passatempo da ricchi che emulava senza concluderlo. Ma aveva comunque un ordine cui far riferimento, surrettizio come tutti gli ordini, e che adesso mi torna a galla – mannaggia – solo perché non c’è più. Il mio odierno smarrimento è il contrappasso della sua euforia d’allora.
Ma in cosa consiste questo smarrimento? Difficile da comprendere fino in fondo, poiché si tratta di un’ansia soprattutto cognitiva. A prima vista è soltanto una faccenda pratica (mettere a posto le merci negli espositori), ma a ben pensarci quel che rischia d’essere sfiorato è addirittura il confine – ontologico e mentale al contempo – fra la sfera del commestibile e tutto il resto. Le mie certezze circa ciò che posso gustare e ciò che non posso gustare iniziano a scricchiolare perché non c’è più un ordine esteriore che me le conferma. La specie umana, si sa, se pure è onnivora in linea di principio, di fatto si adopera per darsi dei limiti, divieti, interdizioni e tabù d’ogni sorta che gli impediscono di mangiare il commestibile come anche, invertendo la rotta, di cucinare i veleni. Ogni messa in opera di un qualche ordine del mondo – foss’anche quello di un supermercato di provincia – ricrea così, ripensandola di continuo, la soglia fra cibo e non cibo, alimentazione e tutto il resto. Quelle cosine crispy accanto alle patatine fritte saranno forse grilli? Il sospetto l’ho avuto subito. E che ne farò? Riuscirò a mandarli giù con l’aperitivo serale? Che ne so: succederà che le mele divengano fermacarte e i saponi liquidi salsine per insalata? che le bottiglie di brandy riappaiano come lampade da tavolo e i bastoni delle scope si ripropongano come lunghi wurstel colorati? che lo zucchero e la farina vengano visti come polveri per astinenti disperati mentre i fantasmini si trasformino in fette di salame? E potrà accadere che quel signore forzuto col grembiule sporco di sangue affettante un pescespada gigante compia piuttosto un sacrificio rituale per ingraziarsi il mammasantissima del quartiere? È tutto un bricolage collettivo per arginare l’ansia del caos, ricreando una nuova forma del mondo e un’ulteriore funzione degli oggetti. Il magma generale confonde non le cose in sé ma le classi merceologiche cui appartengono, di modo che ortofrutta e pannolini, carni e prodotti per la prima infanzia, prodotti da forno e quaderni non si separano per orizzontale ma s’impilano in verticale, mentre il caos fa di tutto per trasformarsi in nuovo cosmo. E verosimilmente ci riesce, intanto che io, sconsolato, giungo alle casse col carrello mezzo vuoto e torno a casa lasciando il frigo a languire.

Un afflato metafisico ne consegue. Questa storia sembra insegnarci che l’ordine non si oppone al disordine ma a un altro tipo di ordine. Quel che io là dentro, ho percepito come caos era forse un ordine differente dal mio, un diverso cosmo di cui non ho avuto sentore e che, dunque, mi procurava fastidio, confusione, forse angoscia. Entrando là, di primo acchito, è stato il disastro, non trovavo nulla, e quel che mi arrivava allo sguardo era insoddisfacente, insensato, se non addirittura disgustoso (non comprerò mai quella pasta là, mai berrò quella birra, né mangerò quel pesce…). Il commestibile si è trasformato in immangiabile o, peggio ancora, le cose sono diventate tutte degne d’essere ingurgitate, potenzialmente digeribili. Ma, a ben vedere, comunque un posto lo avevano, e con esso un senso, un valore, una funzione derivante dalla relazione di ciascuna di esse con le altre. Trovare mutande accanto alle fette biscottate, o l’ammorbidente subito sopra le piadine non è senza esito: cambia il mondo, e noi con esso. Lo straniamento (Sklovskij, Brecht, Barthes…) è un processo euforico che assegna nuovi significati mettendo in discussione quelli abituali.
Del resto, qualcosa di importante è comunque successo: le persone, superato il primo momento di scoraggiamento, si davano vicendevolmente consigli: le arance sono là in fondo, il burro dietro l’angolo, i surgelati nei nuovi frigoriferi vicino l’uscita… I veterani, ossia quelli che stavano già là da una buona mezzora, facevano da mentore ai principianti, gli appena arrivati, in un clima di solidarietà diffusa, derivante senza dubbio dall’ansia collettiva, e sfociato in una nuova forma di socialità. La vecchietta era diventata competente del nuovo spazio, e faceva valere con benevolenza la sua expertise. La giovane coppia con carrozzella, il pensionato, il padre di famiglia con undicenne al seguito, si scambiavano dritte sulle collocazioni e, indirettamente o meno, sulla qualità dei prodotti, Nasceva un’atmosfera di euforica condivisione, una nuova attenzione al cibo, un nuovo senso del gusto, una diversa apertura alla vita. In fondo, era una nuova forma di convivialità. Mia madre ne sarebbe stata contenta.
Leggi anche:
Gianfranco Marrone | Santi bagnati, bevitori asciutti







