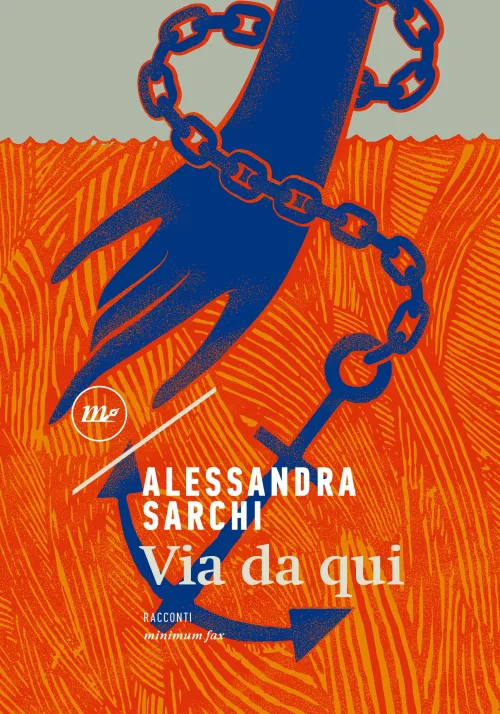Alessandra Sarchi, Via da qui
In un’intervista recente, Alessandra Sarchi afferma che scrivere è un atto di conoscenza: “Solo dopo che le ho scritte molte cose mi si chiariscono e non è solo una questione di messa a fuoco”. Nelle parole di Sarchi riecheggia un’attitudine riconoscibile, condivisa, per esempio, da Grace Paley, maestra statunitense della forma breve: “L’importanza di non capire tutto” è il titolo di una sua celebre conferenza, che tenne verso la metà degli anni Sessanta, sulla scrittura di invenzione, la cui pratica implicherebbe, per l’autrice, l’avallo a una certa ottusità di partenza, “adeguate aree di ignoranza”, come le chiama lei, da riconoscere e da tenere in esercizio. Queste ultime sarebbero indispensabili per trattare letterariamente un argomento, una situazione, atteggiamenti e comportamenti umani, attraverso un processo di ricerca del sapere che, non essendo già acquisito, ha piuttosto a che fare con la posa della prima parola sulla pagina, così come la scelta delle successive, una dopo l’altra, in un ordine arbitrario e parziale che sottrae immagini e fatti al perduto quotidiano, tenendoli fermi in una nuova sequenza che è il risultato di una tessitura nascosta scesa a patti con i limiti e la provvisorietà. Per Paley quindi – e così torniamo alle sue parole – la scrittura avrebbe a che fare con la possibilità di ampliare il proprio mondo e di farlo risplendere.
Nelle cinque storie che compongono il libro di Alessandra Sarchi Via da qui, pubblicato a marzo da minimum fax, c’è luce ovunque. Attrae l’attenzione delle voci narranti e dei personaggi, attraversa interni ed esterni coinvolgendoli in un sottile meccanismo di ipersemantizzazione degli spazi che è coerentemente in atto fino alla fine del libro e che conferisce unità a un universo narrativo aperto e arioso. Da Bologna e dalla provincia di Reggio Emilia a Venezia, dalle colline toscane fino a Los Angeles, è una geografia estesa costituita da molti ambienti privati e personali che non sono mai del tutto privati e personali. Anche nella rappresentazione dei luoghi chiusi (un bilocale, la cucina, la camera da letto, il salotto, il bagno di un ristorante, un pianerottolo…), l’attenzione costante di Sarchi alla resa di un’atmosfera prodotta anche dall’interazione dell’elemento luminoso con gli oggetti, i corpi e la loro superficie rimanda all’assenza della separazione tra un fuori e un dentro e, nei riguardi di quest’assenza, alla messa in moto di un atteggiamento esplorativo che si avvale del processo della visione per l’approfondimento del reale.
La particolare esposizione della casa sui colli vicino a Firenze in cui vivono Evelyn e Monica, le protagoniste del primo racconto, “La tana”, la rende al contempo rifugio e apertura, nel tollerante patteggiare, da parte della coppia, con il proprio tempo e con le sue incrostazioni psicologiche, morali e di costume. In “L’argine”, il secondo racconto, che è ambientato sulle sponde emiliane del Po, Rossella e Ines ricapitolano le loro rispettive esistenze sotto la “luce smorzata” della camera da letto del piccolo appartamento di Rossella. Sono due sorelle, entrambe separate, la prima con due figli a carico, la seconda di ritorno in Italia dopo anni trascorsi negli Stati Uniti da moglie-di.
La “luce calda” che entra dalla finestra del pianerottolo di un palazzo storico nel centro di Bologna pare tracciare, nel terzo racconto, “Il palazzo della principessa”, una via di polvere sospesa nell’aria che porta fino al sottotetto in cui vivono abusivamente Melissa e Filippo. In questo luogo crepuscolare e orientaleggiante, fiabesco, “la bella luce naturale” si espande “come dentro un acquario”, rapendo lo sguardo del loro ospite inatteso, che pare desistere dal denunciarli perché sotto l’incantesimo del pulviscolo che vortica nello zenit.

In “Cherry Street”, il quarto racconto, sotto la “luce spietata” della California, nel giardino in compagnia dell’amica Monty, Annamaria deve decidere in poche ore se rimanere con suo marito o andarsene di casa. Nel frattempo, l’incontro con l’amica si protrae e diventa una lunga chiacchierata durante la quale i pensieri della protagonista vagano in un andirivieni tra passato e presente attraverso cui passare in rassegna le scelte di una vita, prima fra tutte la decisione, presa anni prima, di espatriare (esperienza che l’accomuna a Ines).
Nel quinto e ultimo racconto, “Fondamenta della Misericordia”, Marta, che si sente parte di Venezia “come una delle tante incrostazioni che la città esibiva”, si allontana dalla combriccola di vecchi amici, quando non li sopporta più, per dirigersi al bagno del ristorante, dove la vista della Chiesa di San Michele in Isola, con “un’ultima fascia di sole sulla sommità della facciata”, la dà sollievo. La fuga al bagno in un momento in cui la realtà appare disperante la riporta alle scuole elementari, una mattina in cui, scappata dalle compagne a causa di uno scherzo cattivo e gratuito, dopo avere ascoltato le parole incoraggianti della bidella, si è guardata allo specchio, “nella luce limpida che entrava dalla finestra” e ha smesso di piangere. Può tornare là fuori ora: in classe così come al tavolo con gli amici, sulla Fondamenta.
Il mondo delle figure femminili di Sarchi risplende di una luce che è osservabile e tangibile, la cui onnipresenza implica e allude alla messa a tema della visione umana sul reale: i travisamenti, gli abbagli e gli errori di chi si trova a un certo punto a dovere fare i conti con l’impellente necessità di vederci chiaro e di agire, per non soccombere all’unica possibilità storicamente offerta alle donne, quella di raccogliere i cocci, vale a dire andare avanti stando immobili.
Le protagoniste di questi racconti, ciascuna con il proprio modo di stare al mondo e di sbagliare, scelgono, per dirla con una frase di Laura Lepetit dalla sua Autobiografia di una femminista distratta, di “vivere guardandosi attorno e non dentro”: la liberazione interiore è una prospettiva allettante quanto ingannevole, un fenomeno atmosferico di cui sapere osservare le variazioni, più che una chiave di lettura valida per trame esistenziali in cui invece operano instancabili le contraddizioni della sofferenza umana. Se l’individualità è parte del problema, capire se stesse coincide alla fin fine con l’ingrato, quando non mortificante, sforzo di trovare delle ragioni per essere al mondo, scusandosi sempre e cercando rinnovate forme di pacificazione e di riconciliazione con contesti soffocanti. Via da qui allora è un imperativo da prendere alla lettera, con cui sostituire i vari «Vai qui», «Vai là», «Tieni a mente questo», «Fai quest’altro» di chi, moglie e madre, si autoimpone di sbrigare tutto.
Andarsene, opporsi così all’assorbimento, significa presentarsi con le carte non in regola allo sportello dei bilanci esistenziali. Le vite dei personaggi di Via da qui sono colte nel lasso di tempo che precede una scelta, forse definitiva o forse no (la forma racconto si nutre di ambiguità). Hanno una strada aperta davanti a sé, il che vuol dire averle tutte, comprese quelle che conducono al dolore, tuttavia, così sembrano suggerirci almeno tre delle cinque storie, la solitudine agìta è comunque migliore di quella percepita.
Dei punti di vista sotto i quali vengono presentate le cose, uno prende la parola attraverso la scrittura: è Giorgia, la figlia di Rossella – siamo tornati al racconto “L’argine” –, una bambina di dieci anni che ha appena iniziato a tenere un diario. La narrazione in terza persona della realtà narrativa in cui sono immerse Rossella e Ines si alterna alle sue pagine, in cui, della medesima realtà narrativa, Giorgia illumina alcune parti oscurandone altre, che non le interessano. Registra così, selettivamente, alcuni eventi esterni (i luoghi in cui è andata, le persone incontrate, i fatti della giornata) che mescola alla sua vita interiore con rapide postille sui luoghi prediletti (il fiume sopra tutti), sulle persone che ha conosciuto e che le tornano in mente, sull’aspetto e sull’umore della mamma e della zia.
Le due donne sono molto indaffarate, alle prese con l’idea di una nuova vita da riempire in modo inedito per entrambe. L’incombenza dell’acquisto di una casa le tiene occupate forse più del dovuto, perché una casa nuova richiede anche la costruzione di un immaginario nuovo, così Giorgia ha del tempo per sé, che riempie anche con il compito da svolgere per la maestra: il diario estivo.
In deroga alle martellanti disposizioni che vigono dentro un certo senso comune odierno in materia di genitorialità e di attenzione rispetto alla gestione eterodiretta del tempo dei bambini, a Giorgia capita di stare da sola, ed è liberatorio. Non gestita né raccontata da altri, dalla potenziale condizione di personaggio secondario e in contumacia si affranca presto, vale a dire fin dalle prime righe del racconto: per iniziare la narrazione, Sarchi, tra tutti i punti di vista, sceglie il suo, con la forma diario. E se, prendendo in prestito una frase da Il testo narrativo di Bernardelli e Ceserani, “Ogni vera educazione ha come scopo principale quello di insegnare a nuotare nel mare delle narrazioni”, allora Giorgia, in bilico tra la scelta di tenere il diario per sé o di farlo leggere a qualcuno (“La maestra non ce l’ha spiegato”), in verità ha già messo il suo messaggio nella bottiglia, che ha lanciato da un via-da-qui in cui non è costretta a fuggire perché ci si trova già, essendosene appropriata con i suoi giri in bicicletta. Questo luogo è il fiume, dove “si può essere liberi” senza provare paura.