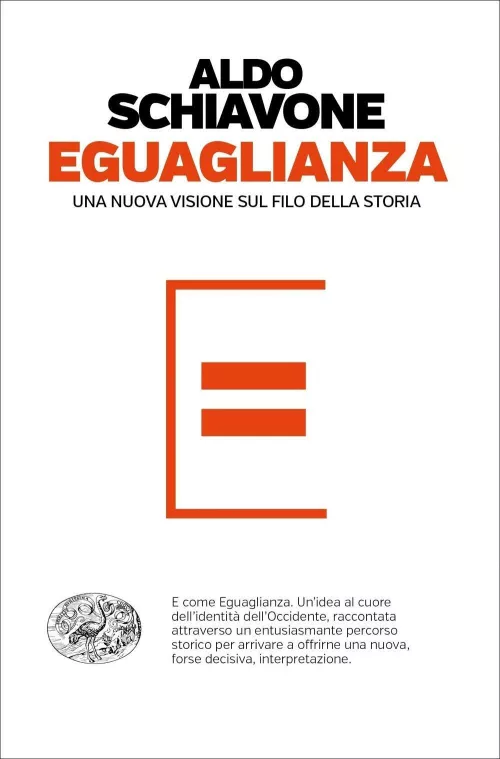Per una giustizia sovrana sui sovranismi / Il futuro dell’eguaglianza
Poco più di una ventina di anni fa, il sociologo tedesco Ulrich Beck ammetteva che non c’è ancora risposta alla domanda chiave che il passaggio alla seconda modernità impone, dopo le trasformazioni repentine del “dopo 1989”: com’è possibile la giustizia sociale nell’era globale? Oppure, più concretamente: cosa significa e come determinare diritti ed eguaglianze al di là dei confini nazionali, in nome di una comune umanità, riconosciuta a livello cosmopolitico? E, ai tempi delle grandi migrazioni? Infatti, come ci ha ricordato nelle sue ultime esternazioni anche Zygmunt Bauman, la partizione umana “noi-loro” ha funzionato ancora bene nella fase della prima modernità, incardinata sul primato dello Stato-nazione, ma appare incompatibile con la prospettiva dell’era globale. Si può dire che il lungo excursus storico sull’idea di eguaglianza e sui modi in cui essa ha generato e innervato dinamiche sociali, economiche, politiche e ideologiche, dall’antica Grecia a oggi, compiuto nel suo ultimo libro da Aldo Schiavone (Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia, Einaudi, Torino 2019), miri proprio a rispondere, o quantomeno ad abbozzare qualche prima risposta, a queste domande cruciali.
Solo per l’ampiezza dello spettro temporale considerato, infatti, il libro potrebbe ingannevolmente indurre a pensare che si tratti di una sorta di contraltare tematico a un classico del liberalismo europeo: il Discorso sulla libertà degli antichi comparata a quella dei moderni di Benjamin Constant del 1819. In verità, la cornice storica, con il vantaggio dell’approccio multidimensionale che include, serve a Schiavone per giustificare meglio la proposta di una prospettiva inedita per reimpostare il problema dell’eguaglianza. Non solo su scala planetaria e globale, al cui livello si sta condensando, per la prima volta, un destino comune condiviso dall’intera umanità in quanto tale, e non esclusivamente come soggetti appartenenti a comunità statuali definite e solidali entro un “noi” etnicamente, linguisticamente, politicamente definito. Si tratta di ridefinirlo anche alla luce del venir meno di quello sfondo sociale del momento taylor-fordista, che, facendo emergere la centralità del “lavoro” come questione dirimente di giustizia, almeno nel mondo euro-occidentale (e in quello “occidentalizzato”), aveva fatto avanzare l’eguaglianza, soprattutto nel Novecento, dal terreno dei diritti civili e politici a quello dei diritti sociali, estendendo l’area dei beni di comune accesso al benessere, all’istruzione, al reddito di base, alla salute, e così via e inaugurando la stagione “welfarista” delle democrazie mature. Il tema, come sappiamo, è decisivo, perché proprio le diseguaglianze, innanzitutto di reddito, cresciute nei singoli Paesi, a inizio secolo, a fronte comunque dell’uscita dalla povertà di ampie aree del pianeta e dell’emergenza di nuove economie nell’arena competitiva mondiale, sicuramente favorite dalla globalizzazione, è il “brodo di coltura” di populismi, neonazionalismi, sovranismi, che stanno scuotendo gli assetti liberal-democratici tradizionali e rendendo accidentati percorsi di integrazione non solo globali, ma anche quello europeo, che ha scontato già la “defezione” britannica.

Qual è allora la novità della proposta di Schiavone?
Il suo suggerimento, che, di primo acchito, può apparire come la rottura di un tabù, è di abbandonare il paradigma dell’età moderna dell’eguaglianza, il perno di tutte le costituzioni liberaldemocratiche, compresa la sua proiezione universalistica nei “diritti umani” consacrati dalle Nazioni Unite, nonché il parametro delle politiche sociali e assistenziali: la persona-individuo. Nonostante sia risultato, peraltro, anche storicamente vittorioso su quello di ascendenza marxista della “socializzazione” o “collettivizzazione”, altrettanto improponibile per Schiavone. O meglio, il suggerimento è di superarlo e conservarlo, in una sorta di Aufhebung hegeliano, in un nuovo paradigma, più efficace nel rispecchiare l’universale umano che emerge con l’ingresso nell’era globale: quello della nuda e impersonale presenza di ogni umano, il chiunque viva una vita e ovunque la viva nella cosmopoli del genere umano. L’impersonale al posto dell’individuale, insomma. E, in una tradizione avara di antecedenti teorici, perché tutta inclinata generalmente sui poli della singolarità individuale o del personalismo, tranne poche eccezioni, un riferimento cospicuo per Schiavone è Simone Weil. È la pensatrice francese, infatti, a indicarci con chiarezza la via per smettere di dire “loro”: rinunciare al piglio rivendicativo dell’“io” e all’identificazione idolatrica e chiusa in un “noi”, per attribuire sacralità non alla persona, ma all’impersonale.
Come scrive in modo sorprendente e folgorante in La persona e il sacro, tra il 1942 e il 1943: “C'è in ogni uomo qualcosa di sacro. Ma non è la sua persona. Non è neppure la persona umana. È semplicemente lui, quest'uomo. Ecco un passante per la strada che ha delle lunghe braccia, degli occhi celesti, una mente dove si agitano pensieri che ignoro ma che forse sono mediocri… Non è né la sua persona, né la persona umana in lui che mi è sacra. È lui. Lui tutto intero. Le braccia, gli occhi, i pensieri, tutto. Non violerei niente di tutto questo senza infiniti scrupoli…” (La persona e il sacro, Adelphi, 2012). Vi è racchiuso nel fondo di ciascuno di noi un nucleo profondo e intangibile, impersonale, appunto, indipendentemente dalle sofferenze subite o inflitte, che consiste nell’aspettativa di ricevere bene dagli altri, di non esserne offesi e nell’esprimere il grido muto e sconcertato contro il male, laddove se ne venga offesi, come può succedere, perché per la Weil la forza regna e soggioga tutto e tutti nella terra, come una necessità, come la gravità (la pesanteur, parola-chiave del suo lessico filosofico) e il bene richiede un coraggio “sovrannaturale”. Da qui, la diffidenza di Simone Weil per l’efficacia del diritto, anche quello legato alla persona ed espresso nel grappolo dei principi del 1789.
Un po’ alla Nietzsche, lo vede genealogicamente scaturire dai rapporti di forza, dalla logica “di spartizione, di scambio, di quantità”, e quindi sempre, nel suo atteggiarsi rivendicativo, “per sua natura dipendente dalla forza”. Mentre all’impersonale di ogni uomo si legano un obbligo incondizionato e la vera Giustizia. Ovviamente, c’è, nello stesso tempo, nello storico e giurista Aldo Schiavone la consapevolezza di riferirsi a una pensatrice tradizionalmente catalogata nel filone “impolitico” (in particolare, è stato fatto, in modo canonico, da Roberto Esposito), convinta cioè dell’impossibilità da parte della politica, in quanto risucchiata nel vortice “mondano” della forza, di attingere la dimensione del bene e della giustizia. Ma, il suo intendimento è di sottrarre l’intuizione dell’impersonale umano della filosofa francese alla curvatura gnostica e misticheggiante in cui, soprattutto dopo i Cahiers, la confina e spenderla nel rilancio di una politica dell’eguaglianza all’altezza dell’era globale, quindi, nella convinzione implicita di base che la politica possa convogliare la “forza” delle non-forze che sono l’amore, la solidarietà, la responsabilità, la misura.

In questa direzione, grazie allo spunto weiliano e alle sue tracce spinoziane e hegeliane, Schiavone sembra suggerire una terza via insperata rispetto ai due poli del vecchio dibattito tra “liberali” e “neocomunitari”, entrambi incardinati sul frame dell’individuale e della pari dignità individuale, a seconda dei casi, o anteposto come principio aprioristico o fatto discendere dalla condivisione collettiva. Infatti, il paradigma dell’impersonale eguale in tutti gli uomini, rispetto a quello dei diritti individuali, che storicamente si è imperniato sulla proprietà e poi sul lavoro, si rivela proficuo per rappresentare l’umano in tutte le sue forme e per delineare una lista di “beni comuni”, da non ascriversi né alla sfera della proprietà privata, né a quella della proprietà pubblica degli Stati, ma alla disponibilità e al godimento universali. Schiavone ne fa un elenco provvisorio: “La vita dell’umano, innanzitutto, nella piena materialità del suo esistere, nelle condizioni determinate dal livello tecnologico raggiunto: inviolabilità, alimentazione, salute. L’ecosistema nella sua interezza, il primo dei beni comuni: l’aria; l’acqua; l’occupazione e la trasformazione equilibrate dell’ambiente, la sua umanizzazione morbida; la protezione del vivente non umano. E poi: l’accesso all’istruzione e alla formazione, tale da consentire, a chi è in grado di raggiungerli, i livelli più complessi dei diversi saperi. E ancora: l’accesso alle tecnologie in grado di modificare lo statuto genetico dell’umano – la grande questione che presto si porrà di fronte a noi e che richiederà la condivisione di un nuovo confine.
Quello posto dal principio per cui l’unità genetica della specie – il risultato evolutivo che ha dato inizio alla nostra storia – deve essere considerata come un’acquisizione inviolabile, nelle condizioni date; e pertanto qualunque possibilità di modificazione ereditariamente trasmissibile potrà essere presa in considerazione solo se accessibile, in condizioni di eguaglianza, da parte di tutto l’umano” (Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia, p. 294). Grandi temi si proporranno, infatti, sempre meno futuribili: tanto, ad esempio, quello dell’eguale accesso a opportunità biotecnologiche di allungamento della vita, quanto quello del diritto di ospitalità universale, già preconizzato da Kant, rispetto ai quali la connessione tra l’umano impersonale, comune a tutta la specie, e l’eguaglianza si rivelerà più fruttuosa della connessione tra l’individuale e l’eguaglianza, già sperimentata con la modernità e da preservare in ogni caso. Sempre, naturalmente, che non si voglia retrocedere rispetto a un ideale – l’ideale dell’eguaglianza –, che la storia millenaria dell’Occidente dimostra esserne una cifra identitaria, soppressa la quale sarebbe l’Occidente stesso a dissolversi.
Costruire politicamente e giuridicamente un’economia e una socialità dell’impersonale, è dunque la traccia che consegna, argomentandola e determinandola storicamente, il libro di Schiavone. E, quindi, senza limitarci ad attendere, come sembra suggerire con fatalismo Simone Weil, nel suo ultimo libro, il momento in cui la forza, che genera ingiustizia, incontri il suo limite, altrettanto necessario quanto la necessità che, nel mondo, la fa irrompere e “cadere”. Convinta com’è della sovranità quasi assoluta, ma non assoluta, della forza nel mondo. Di quella forza che, in Occidente, ella aveva visto entrare in scena con i poemi omerici. Se, invece, come si auspica Schiavone, la politica, nel suo concerto sovranazionale e internazionale, si facesse carico di assicurare “la stessa quantità di rispetto e di riguardi che è dovuto a ogni essere umano in quanto tale” (Enracinement, Gallimard, 1949, p. 17), su scala locale e globale, allora la giustizia affermerebbe attivamente, o cercherebbe di affermare, la sua sovranità sulla sovranità della forza, e, quindi, anche sui sovranismi, che Simone Weil considererebbe l’ultimo ringhio del “Grosso Animale”.