
Due libri / Szeemann dentro la testa degli artisti
Primavera 1969. In un piccolo, tranquillo museo svizzero, la Kunsthalle di Berna, si inaugura una mostra di giovani artisti internazionali, per lo più ancora sconosciuti al mondo dell'arte. Molti realizzano le loro opere proprio in quel momento: c'è chi lancia piombo fuso lungo lo spigolo tra il pavimento e la parete di una sala; chi appiccica grasso animale negli angoli; chi stacca un metro quadrato di intonaco da una parete; chi appende al muro ritagli di feltro; chi sfonda la piazza davanti al museo con una palla da demolizione; chi lascia un telefono sul pavimento con la scritta: se suona, puoi rispondere e parlare con l'artista.
Sono solo alcuni esempi, ma bastano a rendere l'idea del terremoto che avrebbe scatenato quella mostra, destinata a diventare il simbolo del cambiamento epocale che in quel momento stava sconvolgendo l'arte. (I nomi degli artisti citati sono, nell'ordine: Serra, Beuys, Weiner, Morris, Heizer, De Maria; tutti entrati poi nelle storie dell'arte assieme agli altri 63 presenti, tra cui: Andre, Anselmo, Boetti, Haacke, Hesse, Kosuth, Kounellis, LeWitt, Long, McLean, Merz, Nauman, Oldenburg, Pascali, Pistoletto, Ryman, Smithson). Il titolo completo della mostra è: Live in your head: when attitudes Become Form. Works – Concepts – Processes – Situations – Informations. Il suo autore si chiama Harald Szeemann ed è il giovane direttore della Kunsthalle, nominato otto anni prima, a soli 28 anni.
La parola “autore” non è casuale: Szeemann (Berna, 1933-Tegna, 2005) è stato il più carismatico e controverso inventore della figura del curatore-artista, allora del tutto inedita e che oggi molti curatori esaltano e cercano di imitare (come ha fatto ad esempio Massimiliano Gioni con la sua Biennale del 2013). Ma rimane probabilmente un caso unico nella storia dell'arte, perché è il risultato dell'uomo giusto nel momento giusto: un giovane entusiasta dalla personalità vulcanica, con una sensibilità da artista e una grande carica utopica, che coglie il kairos, il momento giusto, e porta in scena il punto di catastrofe dell'arte del Novecento: quegli anni sessanta in cui si impone il “contemporaneo”, mostrando che l'arte può essere anche un coacervo paradossale di concetto, processo, performance, stato mentale, vita, utopia.
Non si tratta tuttavia di un semplice colpo di fortuna. Lo dimostra il piccolo libro della sociologa francese Nathalie Heinich, Harald Szeemann. Un caso singolare, appena tradotto da Johan & Levi. È un'intervista piena di dettagli interessanti, realizzata nel settembre del 1988, e accompagnata da puntuali commenti che testimoniano il fiuto della giovane studiosa, che stava allora cominciando a interessarsi alle dinamiche dell'arte contemporanea. Si rende infatti conto che dietro il successo dell'uomo c'è qualcosa di sociologicamente rilevante: un'insolita valorizzazione della singolarità.
Il termine, che ricorre spesso nei commenti e fa capolino anche nel sottotitolo, non si riferisce genericamente all'eccentricità del personaggio, ma indica una caratteristica importante all'interno del mondo dell'arte contemporanea: lo spostamento del valore dall'opera alla persona, perché a diventare opera è la stessa vita e soggettività dell'artista. (Nei decenni successivi la sociologa esplorerà attentamente questo tema e finirà per considerarlo uno dei tratti tipici del “paradigma contemporaneo”, come teorizza in Le Paradigme de l’art contemporain. Structures d’une révolution artistique, Gallimard, Paris 2014).
In questo caso lo spostamento riguarda addirittura una figura come l'organizzatore di mostre, che diventa una specie di meta-artista, il cui lavoro non è più scegliere e appendere quadri, ma, nel caso di Szeemann, visualizzare idee e ossessioni personali, mettere in mostra la poesia delle intenzioni e delle utopie, e perfino «creare artisti», come dice egli stesso.
La strategia della singolarità emerge già nella risposta alla prima domanda: «Quando le viene chiesto di definire la sua professione, che cosa risponde?». «Mi definisco così: […] Agenzia per il lavoro spirituale all’estero al servizio di un possibile museo delle ossessioni. […] un museo delle ossessioni non si può realizzare, è un museo mentale... Tutto ciò che faccio, in sostanza, è tentare di avvicinarmi a qualcosa che non si può realizzare».
L'agenzia inventata da Szeemannn è mix davvero singolare «fra l’istanza più privata, personale e autoreferenziale che possa esistere, cioè l’io, e un’entità collettiva e impersonale (“agenzia”)». E non è una boutade: dopo la rivoluzionaria mostra che esortava a vivere l'arte “nella propria testa” e metteva sottosopra il museo, Szeemann era stato oggetto di violenti attacchi e aveva deciso di lasciare il suo incarico di direttore, mettendosi in proprio con quel lungo titolo dal sapore dadaista e proponendo di realizzare mostre “dalla visione al chiodo”. E aveva trovato subito una commissione molto importante: la direzione di documenta 5 a Kassel nel 1970, una delle più importanti rassegne mondiali, dove realizzò un'edizione storica continuando e ampliando la visione aperta a Berna.
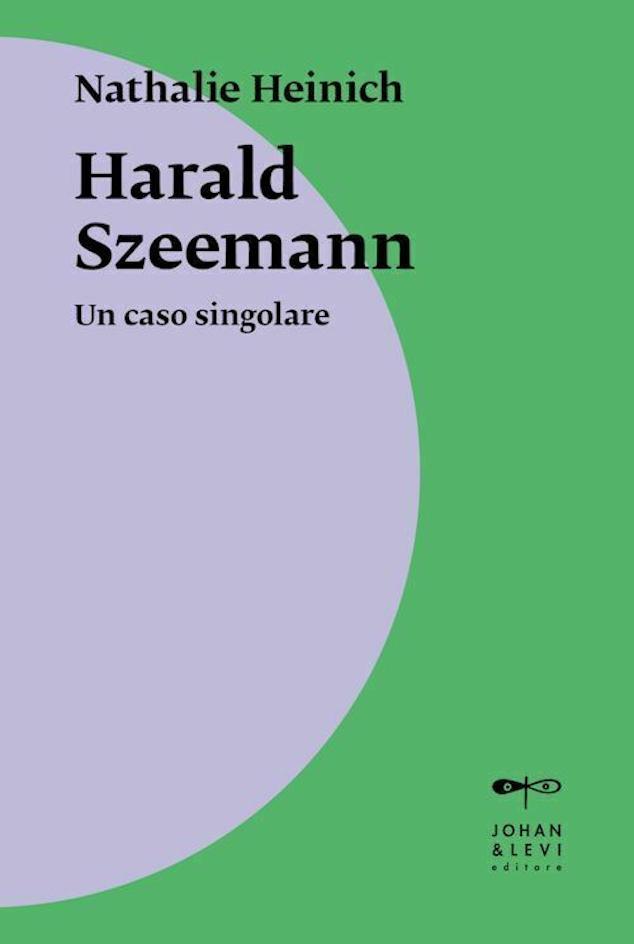
Nell'intervista affiorano anche le radici di questa soggettività da artista, che affondano nella passione giovanile per il teatro dada e surrealista, praticata con spettacoli di cabaret che metteva in scena facendo tutto da solo. Ecco come il curatore rievoca la scoperta della sua vocazione quando, a 22 anni, gli propongono di allestire la sua prima mostra: «Per me si trattava di un mezzo espressivo ideale: avevo fatto teatro, scrivevo i testi, mi occupavo della musica, suonavo, realizzavo le scenografie e così via».
Per Szeemann dunque la mostra è un «mezzo espressivo»; il museo, un «centro creativo»; i suoi strumenti, il «sesto senso» e la complicità con gli artisti: «lavorare a contatto con gli artisti. Scoprire un giovane artista, riuscire a sentire... a sentire l’intensità delle intenzioni: ecco, per me era questo a contare!» Sono tutti tratti evidenti, commenta Heinich, di una «competenza soggettiva non trasmissibile» che permette al curatore di stabilire un legame privilegiato con gli artisti e di costruirsi egli stesso una reputazione da artista.
In questa «posizione di singolarità» rientra anche il rifiuto, dopo i clamorosi exploit di When Attitudes e di documenta 5, di una facile carriera istituzionale. Invece di accettare incarichi prestigiosi, Szeemann decide di rimanere indipendente e fare un nuovo genere di mostre, «con temi che potevo trattare solo io». Ad esempio la piccola mostra del '74 a Berna sul nonno parrucchiere, inventore della permanente (Il nonno, un pioniere come noi); ma soprattutto le grandi mostre incentrate sulle sue tre ossessioni della sua vita.
La prima ossessione è quella sviluppata con la storica mostra itinerante Le macchine celibi (1975). Prendendo il titolo dall'espressione con cui Duchamp definiva la parte inferiore del suo Grande Vetro, la mostra è una complessa messa in scena storico-filosofico-psicoanalitica della figura dell'artista, che per il curatore funziona come una macchina a circuito chiuso, dove il rifiuto della fecondazione è funzionale alla creazione simbolica. È del tutto evidente che non si tratta di scegliere e appendere quadri, ma di «un nuovo genere di mostra, in cui si tentava davvero di visualizzare un’altra cosa, un meccanismo dello spirito, un modello di pensiero, di vita».
Qui il “museo delle ossessioni” prende una forma concreta, dimostrando che non è uno slogan da pubblicitario e che curatore e artista hanno molto in comune. Quando Szeemann dice che «l’artista ci offre un’ossessione controllata», sta in fondo parlando anche di se stesso e delle sue ossessioni, la prima delle quale è proprio il funzionamento della mente d'artista come “macchina celibe”.
Le altre due ossessioni, su cui torneremo più avanti, sono La Mamma e Il Sole, temi vastissimi e dalle risonanze mitologiche, che Szeemann considera matrici della creatività e della cultura del xx secolo, ma che non riuscirà mai a realizzare compiutamente.
Per Heinich, comunque, quel che conta è rilevare come nel racconto di Szeemann questa «dimensione ossessiva» renda le sue varie mostre «un’opera personale, sorretta da un’intima necessità, alimentata dalle circostanze di una traiettoria biografica e non già dal caso o dalle imposizioni di un programma istituzionale». Proprio come l'opera di un artista.
Molto significativo, a questo proposito, è il punto in cui Szeemann afferma che preferisce non aver mai successo e non attirare grandi masse di visitatori, perché è convinto che «le mostre sopravvivono solo attraverso quei pochi che vedono i lavori!» (Quanti curatori oggi avrebbero il coraggio di dire una cosa del genere?).
Heinich sottolinea l'«elitismo» di questa posizione; ma è un elitismo che ha dietro un'etica da artista, come spiega lo stesso curatore in un altro passaggio cruciale: per i suoi «musei di idee» ciò che conta non sono i capolavori, ma «ciò che sta dietro i capolavori! Intendo dire che c’è un’etica, dietro l’arte». E cita con orgoglio l'elogio che gli ha rivolto Mario Merz, uno dei suoi artisti del cuore: «Hai reso visibile il casino che abbiamo in testa noi artisti – un giorno sei vegetariano, un giorno bevi fino ad ammazzarti, un giorno sei anarchico, il giorno dopo sei mistico, un giorno ti interessi alla matematica, un altro giorno ad altro».
Il compito etico del curatore-artista è dunque fare vedere quel casino. Per questo Szeemann costruisce delle mostre che sono un «caos organizzato» (come dice in un'altra importante intervista a Hans Ulrich Obrist). Heinich commenta così: il curatore-autore «può permettersi di essere “incasinato” come gli artisti che espone [...] egli non lascia altre possibilità in futuro se non quella di interessare, come un misterioso essere primitivo, qualche etnologo ossessionato dall’idea di penetrare il mito, anche a costo di non integrarsi nella tribù».
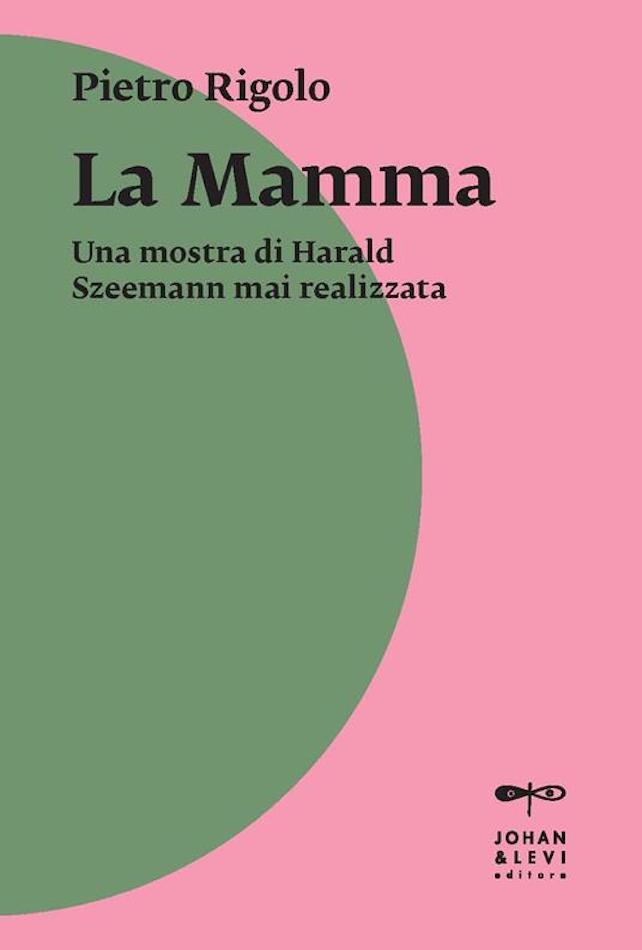
Un etnologo che cerca di penetrare il mito-Szeemann è in un certo senso il giovane storico dell'arte Pietro Rigolo, che lavora da anni su ciò che di più vicino alla mente del grande curatore ci è rimasto: la sua controparte materiale e visibile, rappresentata dallo sterminato archivio, un tempo costipato all'inverosimile nella “Fabbrica Rosa” di Maggia, vicino a Locarno, e dal 2011 acquisito dal Getty Research Institute, dove Rigolo oggi lavora. Anche per questo ha potuto avventurarsi nell'impresa, davvero insolita, di ricostruire una mostra soltanto pensata. Lo fa in un altro volumetto dedicato al grande curatore e pubblicato nella stessa collana, La Mamma. Una mostra di Harald Szeemann mai realizzata (Johan & Levi, 2021), nel quale fa tesoro di alcuni indizi raccolti nell'archivio e li confronta coi contenuti delle mostre realizzate come spin-off delle sue ossessioni incompiute: Monte Verità (1978) e Der Hang zum Gesamtkunstwerk (“La tensione all’opera d’arte totale”, 1983).
Come ideale prosecuzione delle Macchine celibi, La Mamma avrebbe dovuto rappresentare l’energia femminile e la sua possibilità di generazione. Spiega Rigolo: «La mamma, che realizza la propria libertà attraverso il dono della vita piuttosto che nella creazione artistica, rappresenterebbe un’apertura al mondo che reintegra l’idea di tempo e di morte», contrapponendosi alla macchina celibe che implica «un tentativo di abolizione della fine, un bisogno di durata, di immutabilità attraverso l’arte». Conseguenza paradossale: questa sarebbe stata una mostra senza arte.
Szeemann ci lavora assieme ad altri progetti in un periodo tumultuoso: c'è la sfida di proporsi come figura indipendente, la nuova compagna in Ticino, la nascita della figlia. Alla fine, per i motivi analizzati nel libro, decide di realizzare il progetto sul Monte Verità, che ai suoi occhi diventa «il luogo ideale dove far convergere [...] il mito solare del Sud come culla di antichi riti antipatriarcali [...] e il culto di origine agraria della Grande Madre Terra».
La mostra sul Monte Verità, assieme ad altre curiose mostre ticinesi, è raccontata da Rigolo in un libro precedente (Immergersi nel luogo prescelto. Harald Szeemann a Locarno, 1978-2000, Supernovae Doppiozero, 2012). Per essa il curatore raccoglie un'enorme mole di materiali sui personaggi che, a cavallo tra Ottocento e Novecento, gravitano attorno alla collina sopra Ascona con le loro idee spiritualiste e comunitarie: anarchici, utopisti, socialisti, vegetariani e naturisti, riformatori della vita, teosofi e danzatori d'avanguardia. In questo crogiolo si ritrovano vari ingredienti presenti anche nella Mamma. Sulle due mostre aleggia infatti «l’idea di una divinità femminile, promotrice di ideali egualitari e di una società non gerarchica».
Quanto alla mostra mai realizzata, è decisiva la scoperta nell'archivio di Szeemann di uno schizzo che permette di ipotizzarne la struttura e i punti salienti. L'inizio è dedicato a un'inquadramento storico-culturale, dove spiccano le figure dello psicanalista Wilhelm Reich, con la sua idea di una “potenza orgastica” soffocata dall’organizzazione patriarcale-autoritaria della società, e dell'antropologo Johann Jakob Bachofen, con la sua teoria (molto contestata) su un'antica fase matriarcale della civiltà. Il resto della mostra è dedicato in gran parte a ciò che Szeemann definisce «il raddoppio dell’energia tramite il dono della vita», cioè la gravidanza e la nascita. «Con la nascita di un figlio», commenta Rigolo, «il circuito chiuso del celibe è davvero interrotto, e il soggetto giunge ad accettare lo scorrere del tempo, il dolore e la morte».
Ma ci sono anche alcune stanze dedicate alla rinuncia alla maternità, perché il «raddoppio dell’energia» può avvenire a volte anche in questo caso. Tra le figure più interessanti spiccano qui alcune donne davvero atipiche, accomunate da una vita sentimentale non ortodossa, dall'impegno umanitario e dall'adesione a concezione mistiche, teosofiche ed esoteriche: Emma Kunz, una medium guaritrice che realizzava complessi disegni col pendolino e faceva germogliare boccioli di fiori con la sua energia; Helena Blavatsky, l'occultista fondatrice della teosofia che affascinò i padri dell'astrattismo; Annie Besant, la socialista fabiana, protofemminista, attivista per l'indipendenza indiana che le succedette a capo della società teosofica; Mirra Alfassa, la mistica francese che nel '68 fonda la città utopica di Auroville, nel Sud dell’India.
Di riferimenti alla teosofia e soprattutto all'antroposofia di Steiner è imbevuta anche la mostra sull'opera totale realizzata recuperando gli spunti del Sole, la terza ossessione di Szeemann. In essa c'è un parziale ritorno al fare artistico, che diventa ora un percorso verso l’elevazione spirituale attraverso l'arte. L'artista contemporaneo più importante è Joseph Beuys, che incarna perfettamente l'idea szeemanniana di “mitologia individuale”, cioè dell'artista che traspone la propria vicenda in chiave mitica, come base per una conoscenza universale (un'idea, noto en passant, del tutto in linea col paradigma contemporaneo teorizzato da Heinich). E dietro a Beuys e Szeemann c'è il pensiero di Rudolf Steiner, che per il curatore fu «l’unico pensatore capace di creare attorno alle sue idee una comunità viva e una nuova forma di società, attraverso la riforma di tutti i campi del sapere».
Abbiamo iniziato con un giovane iconoclasta che lancia la rivoluzione artistica degli anni sessanta e terminiamo con un cultore di grandi visioni spiritualiste di antica matrice gnostica. Vista così, la traiettoria professionale di Szeemann sembra confermare l'idea di Mario Merz, che nella testa degli artisti c'è sempre un gran “casino”. Ma nel caso di di Szeemann, in quel casino, o meglio in quel suo «structured chaos», c'è davvero una struttura; o almeno un centro di gravità: è quell'anelito mistico che affonda le sue radici nel romanticismo.
Rigolo ricorda che una delle tre diapositive con cui, negli ultimi anni, Szeemann chiudeva le conferenze sulla sua carriera, è un'opera di Bruce Nauman del 1967, un neon con una scritta a spirale: “L’artista vero aiuta il mondo attraverso la rivelazione di verità mistiche”.







