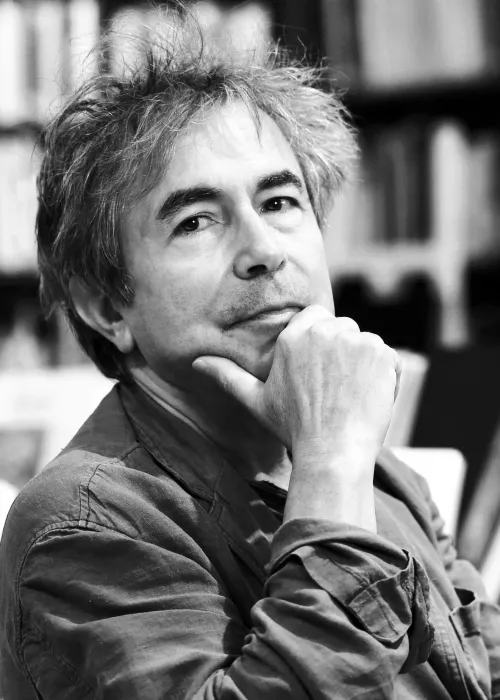Speciale
Progetto Jazzi / Jullien. Vivere di paesaggio

Continua l’intervento di doppiozero a sostegno del Progetto Jazzi, un programma di valorizzazione e narrazione del patrimonio culturale e ambientale, materiale e immateriale, del Parco Nazionale del Cilento (SA).
La nostra prima dimora è stata un giardino. Così raccontano i testi fondativi delle religioni del libro e del deserto, la Bibbia ed il Corano, ed è tema che si ritrova nell’India antica. Quando, nel III secolo a.C., venne compiuta la traduzione del Pentateuco che diciamo dei Settanta, per il giardino dell’Eden si preferì ricorrere al termine paradeisos di origine iranica piuttosto che al greco kepos, in cui si conserva anche il senso di grembo materno. Paradeisos indica un luogo recintato, chiuso da mura, con significato analogo all’indoeuropeo ghorto, da cui deriva hortus. Nel luogo che Dio ha affidato ad Adamo perché desse un nome ad animali e piante e ne fosse custode e padrone, la natura è messa al riparo e perfezionata. Il confine che separa l’interno dell’abitare protegge dalla natura selvaggia, dalla foresta senza limiti, luogo delle tenebre e dei pericoli: il giardino rappresenta la serenità delle origini, l’infanzia colpevolmente perduta dall’umanità, ribelle alla legge del padre. Lo spazio chiuso del giardino è congruente all’esigenza greca di tracciare un limite per sfuggire al terrore dell’illimitato; horos, in origine la pietra che segna il confine, che assume poi significato di “definizione”. Il giardino, ancor più quando nella modernità si offre allo sguardo sovrano del soggetto, compiaciuto di avere imposto il suo ordine geometrico alla Natura, obbedisce ai canoni della razionalità dell’Occidente.
Concepire anche il paesaggio a partire dall’orizzonte (horismos) che lo delimita significa già mancarne il tratto precipuo, l’apertura che sfuma verso un’indefinita lontananza. Non è allora casuale che, in ambito pittorico, il paesaggio sia rimasto relegato a genere minore; nei Fiamminghi o negli Italiani del tardo Quattrocento serve a colmare i vuoti del quadro, funge da sfondo e scenografia, prima di conoscere una breve fioritura a partire dal Romanticismo, col venir meno del culto del Bello e dell’esigenza della rassomiglianza. La pittura di paesaggio ha conquistato autonomia nel secolo che da Friedrich e Turner giunge fino al Cézanne in lotta contro la variabilità indomabile della montagna Sainte Victoire. Il termine “paesaggio” compare ai primi del ‘500 (forse è Tiziano il primo a utilizzarlo da noi in pittura), per derivazione da paese (pays, come landscape da land); e ancora oggi i dizionari lo definiscono come la parte di un paese che la natura presenta allo sguardo di un osservatore. La nozione resta così impigliata nella “piega” che il nostro pensiero ha assunto fin dai Greci: il rapporto parte-tutto rimanda alla logica compositiva per cui la realtà si forma assemblando elementi, sul modello della struttura alfabetica che compone parole a partire da atomi-lettere.
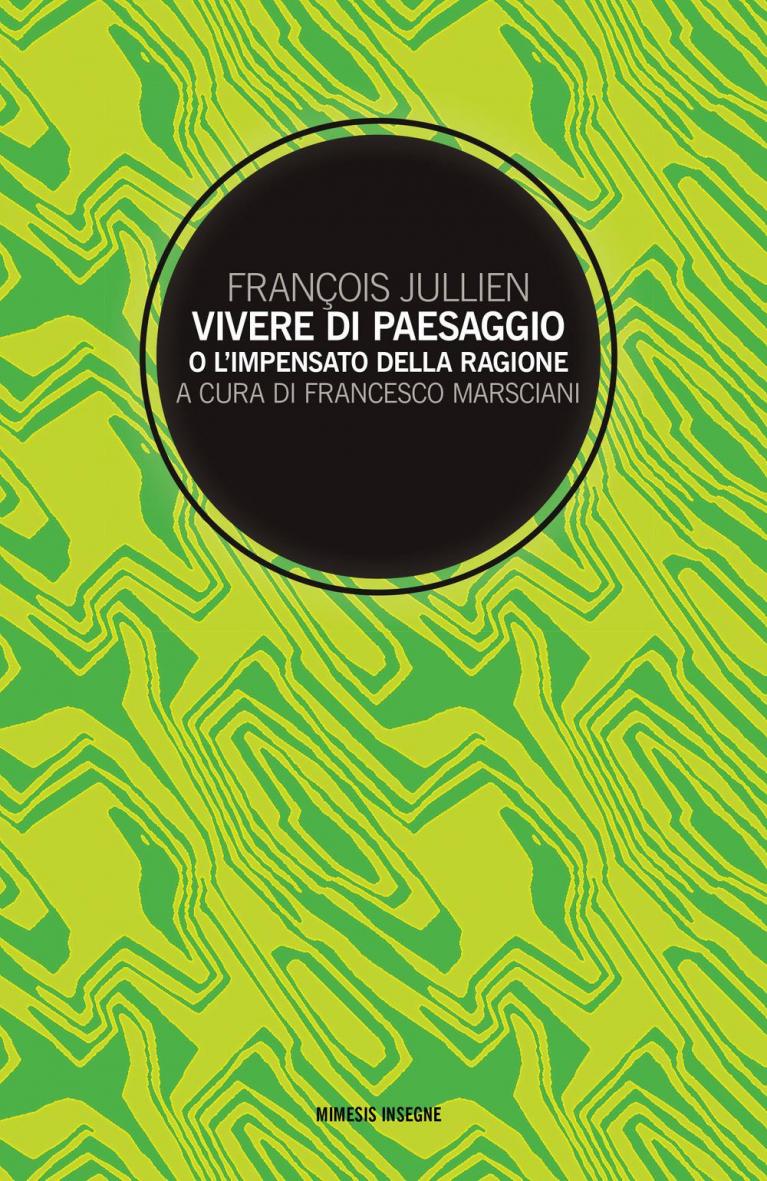
Se oggi abbiamo riscoperto il pensiero del paesaggio soprattutto per le urgenze ecologiche, restiamo comunque eredi inconsapevoli di categorie che ci rendono difficile comprendere come si possa vivere di paesaggio, come suggerisce François Jullien, il filosofo e sinologo che da oltre trent’anni propone un faccia a faccia fra la cultura dell’Occidente e la tradizione cinese. Quest’ultima ha promosso mille anni prima di noi la pittura (e la poesia) di paesaggio, tralasciando quella delle figure umane e del nudo in cui la nostra classicità ha visto rifulgere il Bello ideale. Un passo di Su Dongpo (XI secolo), uno dei primi pittori di paesaggio, esprime con chiarezza l’emancipazione dall’obbligo infantile della rassomiglianza: “gli uomini, animali, case, mobili hanno una forma costante. Invece montagne e rocce, bambù e alberi, increspature dell’acqua, nebbie e nubi non hanno una forma costante, ma hanno una natura interiore costante”.
Non è nella riproduzione della forma umana che il pittore manifesta la sua abilità: “la grande immagine non ha forma”, dice Laozi, una formula da cui Jullien ha tratto il titolo di un altro libro dedicato all’estetica cinese (Colla editore, 2004). Forma (xing) in Cina non è altro che la pausa momentanea di un processo, non c’è forma se non in trasformazione. Del paesaggio non c’è rassomiglianza possibile, esso non si lascia mettere in posa né de-terminare, è inesauribile nelle sue variazioni di grana, di colorazione, di luminosità. L’arte dell’Occidente ha seguito la “piega” ontologica della filosofia, ha cercato, attraverso la consistenza della forma visibile (morphé), di dare espressione alla forma intelligibile (eidos) che costituisce l’essenza dell’oggetto rappresentato. In Cina, non si cerca la rappresentazione, non vi è idea da cogliere; il pittore non è chiamato a riprodurre l’involucro esterno delle cose ma a esprimerne la coerenza interna (chang li), in cui si manifesta la regolazione del processo del mondo. L’alternanza delle fasi yin-yang scandisce il respiro che anima l’universo intero, grazie al soffio-energia (qi) che si rinnova di continuo nelle sue variazioni. Il paesaggio non è una parte ritagliata dal tutto, ma è già il tutto perché in esso è attiva l’operazione del mondo nella sua interezza.
La lingua della Cina costruisce gli enunciati ponendo ogni cosa in relazione al suo opposto: pensare non equivale a comporre ma ad accoppiare. Già il termine “cosa” si dice “est/ovest”, non un che di unitario, ma il binomio, la dualità; e l’ideogramma che designa paesaggio è composto da montagna(e)-acqua(e) (shan-shui), o da rocce-nuvole (le rocce sono “radici di nuvole”), o ancora vento-luce. Come nel lascito di Eraclito, che la nostra filosofia ha ben presto smarrito in nome della logica, dell’Essere e della non-contraddizione, gli opposti, a imitazione dei due versanti della montagna, non si escludono ma si richiamano: il verticale della montagna e l’orizzontale delle acque, lo stabile e il continuo fluire, la forma definita e quel che si adatta alla forma delle cose, l’opaco e il trasparente, il solido e il fluido, quel che si ha davanti agli occhi e quel che si stende da diverse parti. Non è la raffigurazione di un volto (come la Gioconda di cui Vasari diceva che sembrava viva) a far apparire la tensione animante da cui ha origine la vita; nei contorni sinuosi della montagna, nelle svolte continue di rocce e nuvole, nelle linee di forza (il cinese utilizza il termine mo, lo stesso delle arterie che fanno battere il cuore umano) del rilievo si scorge l’energia che anima il corso del mondo. Picasso potrà dire, rivolgendosi al “cinese” Malraux, che proprio i Cinesi hanno compreso quel che conta davvero in pittura, non imitare la vita, ma lavorare come lei: dipingere rinnova il gesto con cui la natura genera le forme.
Il paesaggio prediletto non è quello del Mezzogiorno, dai contorni definiti e dalle ombre nette; non è il paesaggio mediterraneo, la cui luminosa trasparenza consente alle cose di stagliarsi, facendo credere a un’identità di essenza, ad una fissità pietrificata dal sole. Il pittore cinese non raffigura stati distinti, determinati, ma coglie il mondo nella sua transizione essenziale, nel momento in cui vapori e nuvole rendono evanescenti le cose, cominciano a cancellarle. Il paesaggio rivelatore è quello in cui le cose sfumano progressivamente e le forme si fanno incerte. Occorre un lungo processo di addestramento per giungere a far sì che la natura stessa operi attraverso lo slancio del pennello, per dare ad ogni tocco respiro di vita. Nella pittura tonale, l’artista raffigura la profondità delle montagne in lontananza, stagliate su sfondi resi fluidi dall’inchiostro diluito in acqua; il pennello delinea i contorni, l’inchiostro rende le variazioni d’intensità della luce, vela e rivela, a seconda che la macchia sia diluita o concentrata.
“Le cose devono essere presenti e insieme assenti”, scrive Wang Wei (VIII sec.); col gioco di pieno-vuoto, tenendo scostati alcuni peli per lasciare all’interno zone bianche (la tecnica del bianco volante), si traduce in forma visibile il respiro della natura. Il pennello vola leggero come una folata di vento sulla superficie della carta, insuffla nell’inchiostro l’energia germinale che avvia il processo di generazione della forma. Il pittore cinese dipinge il mondo che emerge dalla confusione originale o ripiomba in essa, secondo la grande alternanza respiratoria che lo fa esistere; dipinge non secondo le categorie dell’Essere e del Nulla, ma secondo quelle di un processo continuo, dove le cose stanno per accadere o tendono a scomparire.
A differenza del pittore occidentale, che si pone di fronte al paesaggio da un punto di vista unico e statico, esterno all’immagine che raffigura (ritagliato dalla finestra albertiana che seziona la piramide visiva), lo sguardo del pittore cinese è mobile, contempla dall’interno il paesaggio fino a perdersi in esso (lo racconta una delle Novelle orientali di Marguerite Yourcenar).
Si tratta di una “visione interiorizzata”, suggerisce il titolo di un capitolo di Nell’occhio del pittore di Giuseppe Di Napoli (Einaudi, 2017). Non è l’Io a imporre il suo punto di vista, non siamo più spettatori, vincolati alla posizione fissa della veduta prospettica; lo sguardo si lascia assorbire, passeggia nel paesaggio, lo scopre da diverse angolazioni, non è attivato dagli stimoli ottici ma dalle forze che agiscono all’interno della natura. E quanto viene percepito nel paesaggio si rivela portatore di una componente affettiva; il mondo non-umano non è più estraneo e indifferente, un paesaggio è come un archetto, diceva Stendhal, fa risuonare qualcosa nell’interiorità, non tanto un suono distinto quanto una vibrazione, una risonanza che fa ritrovare l’accordo, l’intesa di fondo fra l’io e il mondo. Nel respiro che anima il paesaggio, troviamo di che “nutrire la vita”; non è necessario ricorrere al cattivo lirismo, allo sfogo soggettivista con cui l’Occidente cerca di compensare la scissione fra mondo fisico e coscienza, siamo ricondotti a monte di quella frattura, nell’indistinto in cui non si è ancora instaurata la frontiera fra materia e spirito.
Grazie alla correlazione fra il vento, che fa vibrare invisibile gli oggetti fisici, e la luce del sole che produce l’alternarsi di ombra e chiarore, il pittore cinese mira a cogliere lo spirito del paesaggio, la dolcezza-ambiente che da esso emana. Lo spirito, il qi, evoca la forma di una nuvola, poi il vapore che si innalza dal riso che cuoce, ed è in primo luogo quel che emana dai corpi, ma senza separarsene, nel senso che da noi sopravvive in “spirito del vino” o del sale. Lo spirituale è il sottile, la quintessenza che procede da una decantazione, non appartiene a un diverso piano della realtà, non è dell’ordine dell’Essere, ma del processuale; si sprigiona dal sensibile e si fa evasivo. Seguire placidamente, in un mezzogiorno d’estate, una catena di monti all’orizzonte oppure un ramo che getta la sua ombra sull’osservatore, fino a quando l’attimo, o l’ora, partecipino della loro apparizione – ciò significa respirare l’aura di quei monti, di quel ramo”. Anche l’aura è l’esito di uno sprigionamento, termine anti-metafisico per eccellenza, che sfugge alla presa ontologica. È a questa nozione che Jullien ricorre per comprendere come dalla nostra prima vita possa emergerne una seconda, non dopo la morte, ma qui, nel quotidiano dell’esistenza (Una seconda vita, da poco edito da Feltrinelli). Prendendo distanza dai solchi in cui resta bloccata la vita ordinaria, possiamo imprimerle una nuova partenza; non si tratta di una vita nova, ma di una ripresa che, correggendo scelte precedenti, ci fornisce maggiore spazio di manovra. La “vita sprigionata” consente di “tenersi fuori” – ex-sistere, dice il latino – dai limiti e dai condizionamenti che prima la bloccavano; si apre nel momento in cui comincio a considerare la mia morte come una scadenza e a ritrovare un presente da vivere pienamente.
Quando Petrarca descrive la meraviglia del paesaggio colto dall’alto del Mont Ventoux, con gli occhi che vagano dalle nuvole sottostanti alle cime delle Alpi innevate, subito la lettura delle Confessioni di Agostino lo induce a un ripiegamento su di sé, nell’interiorità che comunica con Dio. Gli uomini vanno a contemplare le cime dei monti, l’immensità dell’oceano, il corso degli astri e non si accorgono che la sola cosa degna di ammirazione è dentro se stessi: “niente è da ammirare tranne l’anima, di fronte alla cui grandezza non c’è nulla di più grande”. Nella poesia e nella pittura di paesaggio cinese resta invece ignoto, rileva Jullien, il varco fra la fisicità e l’interiorità: la materialità tende già da sé allo spirituale, per l’animazione che vi si rivela. I monti risplendono, le creste si stagliano nella luce, mentre nell’ombra dei loro fianchi resta la confusione originaria, traspare il fondo senza fondo da cui viene il mondo. I vapori che si levano dalle valli, che sfumano e fondono le forme del rilievo, sono l’immagine dell’aura che da noi si è trovata confinata nell’occulto e nell’irrazionale. Eredi dei Greci, abbiamo cercato nella lontananza evocata dal paesaggio un’apertura verso l’aldilà, l’altro mondo, platonico e cristiano, della salvezza e della verità. Abbiamo operato la scelta a favore del meta-, l’oltre della tradizione religiosa e meta-fisica, ignorando la lontananza che invita al tra, alla condizione indistinta fra essere e non-essere che induce alla rêverie, a vagare con il pensiero. La Cina pensa il lontano come svolgersi di un processo continuo che dalla prossimità si perde (ma senza abbandonare il sensibile) nel vago e nel nebuloso che il nostro pensiero delle distinzioni ha relegato nella poesia. “Il paesaggio se ne va dissipandosi”, scrive Guo Xi; il lontano è pensato come prolungamento senza fine, non ci avvicina al limite ultimo che apre il varco verso un altro mondo, ma ci immerge nella confusione originaria.
L’esperienza del paesaggio, rileva Jullien, conta sul piano filosofico perché rompe il sigillo dell’opposizione classica fra ragione ed emozione e perché fa scoprire la nostra profonda implicazione con un mondo. Il pensiero cinese non ha edificato la frattura fra l’io e la natura, quella che la modernità ha ulteriormente scavato costruendo una fisica che rompe ogni legame con il vitale; quando alla fine del XIX ha cercato una traduzione per la coppia soggetto/oggetto, la lingua della Cina ha fatto ricorso ad accogliente/accolto, ad indicare il rapporto di ospitalità e non di indifferenza od ostilità. La nostra coscienza ecologica risveglia oggi il sogno di una comunione con la natura, ma in essa non possiamo non vedere anche l’espressione di un rimosso, se non di un senso di colpa. Il paesaggio chiama invece alla connivenza (connivere in latino, cioè intendersi con una strizzata d’occhio), ad un’altra relazione, ad una tacita intesa con le cose. La conoscenza è solo la faccia illuminata del suo inverso connivente, il sapere ombroso a cui resta addossata e a cui ci accostiamo grazie alla poesia e al paesaggio.