Antonio Gramsci, ritratto di un rivoluzionario
“Quando, nel mese di aprile 1919, abbiamo deciso in tre, o quattro, o cinque di iniziare la pubblicazione di questa rassegna, nessuno di noi pensava di cambiare la faccia al mondo, pensava di rinnovare i cervelli e i cuori delle moltitudini umane, pensava di aprire un nuovo ciclo della storia… L’unico sentimento che ci unisse, in quelle nostre riunioni, era quello suscitato da una vaga passione di una vaga cultura proletaria; volevamo fare, fare, fare…”. A poco più di un anno dalla fondazione della rivista “Ordine Nuovo”, che, da scopi genericamente culturali, sarebbe passata in poco tempo a sostenere il movimento dei consigli di fabbrica nella Torino industriale del primo dopoguerra, così Antonio Gramsci rievocava l’inizio di quell’avventura di alcuni giovani intellettuali socialisti (a fianco di Gramsci, segretario di redazione, c’erano Togliatti, Terracini e Tasca), che non si ponevano come detentori della coscienza di classe o come mentori filosofici della classe operaia, ma come analisti e promotori della soggettività rivoluzionaria che essa era in grado di esprimere da sé, in un frangente storico che, in Italia e in altre parti d’Europa, sembrava propizio alla rivoluzione, almeno agli occhi dei gruppi di sinistra più radicali e all’osservatorio speciale del Comintern. In queste poche righe è forse racchiusa la cifra di tutto il pensiero, la militanza politica e l’esistenza stessa di Gramsci. Per tutta la vita, Gramsci informò le sue scelte politiche e il suo stile intellettuale a una convinzione che esplicitò in modi diversi e in occasioni diverse: la rivoluzione, in vista di una piena emancipazione umana, non dipende dall’oggettività del processo storico, benché ne determini le condizioni, ma dalla volontà di farla, di prepararla, di organizzarla. Volontà di fare, come quella dei giovani “ordinovisti”, per non restare indifferenti, per uscire dalla pigrizia mentale. Da qui, è possibile ricavare anche il tratto sui generis del comunista Gramsci. Venti anni fa, in uno dei più significativi e controversi studi consuntivi sull’esperienza storica del comunismo in Europa (Il passato di un’illusione. L’idea comunista nel XX secolo, Mondadori, Milano 1995), François Furet spiegava che l’appeal fondamentale del comunismo era consistito nell’incorporare non tanto la promessa di un mondo migliore, di uomini uguali e affrancati dallo sfruttamento, quanto l’illusione che quel mondo si sarebbe realizzato perché conforme allo sviluppo razionale e necessario della storia. Ma di questa illusione, che poteva indurre anche atteggiamenti attendisti, consolatori o fatalistici, il politico sardo fu un nemico coerente e implacabile. Come dimostra innanzitutto la sua interpretazione del marxismo come “filosofia della praxis”, che vede nella storia non il gioco di forze anonime “alle spalle” degli uomini, ma il campo dell’attività umana autoproducentesi, il luogo in cui gli uomini prendono coscienza dei vincoli oggettivi e materiali che li opprimono, per intervenire a modificarli e rimuoverli. Influenzato dalla letture neoidealistiche che ne danno Croce e soprattutto Gentile, depurandolo dalle scorie positivistiche e deterministiche, per Gramsci Marx non è il teorico della “necessità storica” del comunismo, spesso enunciata brutalmente, bensì è “l’ingresso dell’intelligenza nella storia dell’umanità, regno della consapevolezza”, come scrive sul Grido del popolo, il 4 maggio 1918, in occasione del centenario di nascita del filosofo di Treviri.

Un comunista nemico dell’illusione, quindi, che ha avversato la riduzione del marxismo a una metafisica razionalista della storia universale o a una “scienza positiva” della società. In ogni caso, però, la storia di Gramsci è la storia di un comunista. Fino alla fine. Blocco storico, egemonia, intellettuali organici, partito come moderno Principe, rivoluzione passiva, sono concetti e categorie critiche da lui forgiate, che si sono affermate nella storiografia, nella critica letteraria, nell’antropologia, nei cultural studies, nel discorso politico (oggi di meno, ma sicuramente in modo ampio in quello della Prima Repubblica), che fanno di Gramsci ancora la figura della cultura italiana più letta dopo Dante nel mondo. Sono concetti che lo stesso Gramsci ha utilizzato per le sue analisi storiche, ma che rispondono prima di tutto all’esigenza teorico-pratica di come realizzare la rivoluzione comunista. Gramsci sembra sempre porsi come il Lenin dell’Occidente, colui che intende riscrivere Stato e rivoluzione per un altro contesto, per energie diverse, ma in funzione dello stesso approdo. Anche nel momento più drammatico, con l’avvento del fascismo, anche “quando tutto è o pare perduto” (come scrive in una famosa lettera dal carcere del 12 settembre 1927) e la condizione coattiva del carcere lo costringe a ridurre l’agire al solo pensare, Gramsci ricomincia da capo con i Quaderni a tracciare le vie possibili e concrete della rivoluzione, come monito a non abbandonare la lotta confidando nell’imperiosità delle leggi della storia che comunque avrebbero aggiudicato la vittoria finale al socialismo. Cosa ci resta, allora, di questo eroe della passione rivoluzionaria, a 125 anni dalla sua nascita e alla vigilia del centenario di quell’evento, la rivoluzione d’Ottobre del 1917, che segnerà la sua vita e l’intero “secolo breve”? Bisogna rassegnarsi al fatto che anche il gramscismo sia destinato a quella polverizzazione che è toccata in sorte al marxismo-leninismo con la dissoluzione dei regimi comunisti dell’Est Europa e con la fine, in Italia, di quel Partito Comunista, che, nel secondo dopoguerra, aveva reso plausibile il programma gramsciano di utilizzare gli intellettuali per l’egemonia, per l’estensione del consenso, preliminare alla trasformazione socialista della società?
Forse, per rispondere, occorre prima di tutto, ripercorrere brevemente la traiettoria politico-intellettuale di Gramsci. Già nel 1915, con l’Italia in guerra da maggio, mentre i dirigenti del Partito socialista italiano, a cui ha aderito, si attestano su una neutralità “attendista” e rinviano sine die la rivoluzione, consegnandosi agli occhi di Gramsci alla fatalità del processo storico e limitandosi improduttivamente a “seguire” senza “preparare” la lotta, il giovane sardo ritiene invece che essa vada messa all’ordine del giorno, attraverso un’attivazione politica della classe operaia accompagnata da un rinnovamento culturale. E se ne convince tanto più dopo i fatti eccezionali della Russia due anni dopo, quando è da poco segretario della sezione socialista torinese. Mentre i dirigenti nazionali si limitano a salutare la fine dell’autoritarismo zarista ma a restare scettici sulla rivoluzione compiuta nel paese più arretrato d’Europa, laddove Marx l’aveva prevista invece nei Paesi capitalistici più maturi, Gramsci scrive, in un articolo brillante su L’Avanti, intitolato La rivoluzione contro il “Capitale”, che la rivoluzione bolscevica dimostra come la lezione fondamentale di Marx non stia nella centralità assegnata ai fatti economici, ma nel ruolo di protagonisti della storia conferito agli uomini, che quei fatti, comprendendosi tra loro, comprendono, valutano e collettivamente e volontariamente riplasmano. Ecco perché le circostanze eccezionali di una guerra che nessuno aveva previsto, tantomeno Marx, e la sensibilizzazione attuata con la predicazione socialista hanno suscitato la volontà popolare russa di un cambiamento radicale e immediato. E, aggiunge Gramsci, un “collettivismo della miseria e della sofferenza” renderà più sopportabili e meno dilanianti le difficoltà economiche, ancor più evidenti col ritorno alla pace, di quanto potrebbe assicurare la “tappa democratico-borghese”, che, secondo gli schemi meccanicistici della vulgata marxista, avrebbe dovuto seguire alla caduta dello zarismo e necessariamente precedere l’avvento del socialismo. Finita la guerra, sull’onda degli scioperi e delle occupazioni del “biennio rosso” 1919-20, l’imperativo di Gramsci e di altri compagni torinesi, anche per rompere le esitazioni di riformisti e massimalisti italiani, diventa allora come “tradurre” in Italia e in Occidente la rivoluzione dei Soviet. Nasce così il gruppo di Ordine nuovo, dove in un articolo del 21 giugno 1919, intitolato Democrazia operaia, Gramsci lancia per la prima volta l’idea di trasformare le commissioni interne, considerate “nuclei di Soviet”, in “Consigli di fabbrica” e quando, agli inizi di settembre dello stesso anno, i duemila operai della Fiat Brevetti eleggono i commissari di reparto per la Commissione Interna, il gruppo ordinovista annuncia la nascita del primo consiglio di fabbrica.
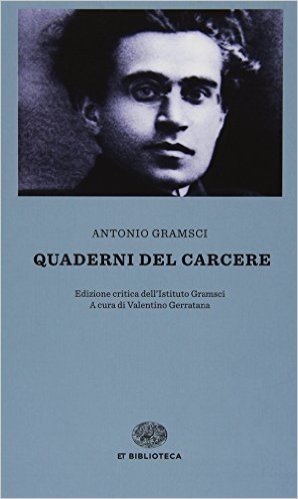
I consigli di fabbrica sono visti da Gramsci come luoghi e momenti di disalienazione, di apprendimento della libertà, in cui gli operai diventano coscienti della loro funzione di produttori e creatori di storia e come motore della rivoluzione in quanto embrione di un nuovo Stato operaio alternativo a quello parlamentare-borghese. Impadronirsi consapevolmente della fabbrica è il primo atto per impadronirsi dello Stato: un processo autonomo di liberazione rispetto al quale, come scriverà in un editoriale del 5 giugno 1920, Partito e sindacato non devono porsi “come tutori o come superstrutture”, ma affiancarlo per rafforzarlo, agevolarlo e accelerarlo. Ma proprio l’aver trascurato il freno “burocratico” del sindacato e del Partito socialista sarà considerato da Gramsci e dal gruppo ordinovista uno dei fattori di insuccesso del movimento consigliare, oltre che il suo mancato collegamento ad altre realtà urbane industriali e alla classe contadina. La parola d’ordine diventa allora la costruzione di un “partito rivoluzionario” a tutti gli effetti, che porterà il gruppo ad essere protagonista della scissione del Congresso di Livorno e Gramsci a diventare un dirigente politico di rango nazionale, entrando nel comitato centrale del neonato Partito comunista d’Italia, il 21 gennaio 1921. In un Paese nel quale la “reazione” contro la “rivoluzione” è sempre più agguerrita e violenta e il fascismo canalizza il risentimento della piccola borghesia in crisi da anni che, scendendo in piazza, “scimmieggia la classe operaia” (così scrive Gramsci su Ordine Nuovo del 2 gennaio 1921, con l’articolo intitolato Il popolo delle scimmie), la preoccupazione del dirigente comunista è di rendere sempre meno settario il partito, dotarlo di una organizzazione “indistruttibile”, in funzione della sua missione di rendere la classe operaia classe dirigente, egemone, capace di allearsi e assorbire altre classi e partiti popolari. Una funzione resa più urgente e complessa dal fatto che, come ha rivelato il fallimento delle insurrezioni del biennio rosso, a differenza che in Russia, nei Paesi industrializzati dell’Europa occidentale il capitalismo ha creato “sovrastrutture” (politiche e ideologiche) più solide della “struttura” (economica), capaci di metterlo al riparo dalle crisi di quest’ultima. Siamo ai temi che Gramsci che comincerà a sviluppare in quegli anni, perno di una nuova strategia e tattica rivoluzionaria, ma che, dopo l’arresto nel novembre del 1926, confluiranno nei Quaderni del carcere, quando Gramsci potrà solo dire come preparare e gestire la rivoluzione, ora che la detenzione lo costringe solo ad una teoria “pratica”, senza poter accedere ad una pratica che ne verifichi circolarmente il presupposto “teorico”. Le Tesi di Lione del 1925 e il saggio Alcuni temi della questione meridionale del 1926 costituiscono la cerniera tra gli articoli del periodo militante e i Quaderni, dove si parla notoriamente di: alleanza fra operai e contadini; funzione degli intellettuali in generale nonché quella storicamente svolta in Italia; rapporto tra intellettuali, classe e partito; Stato come combinazione di società politica e società civile, di dominio e direzione; elaborazione di una nuova filosofia del proletariato, la filosofia della praxis, da contrapporre all’egemonia crociana. Una costellazione di temi che pare avere la sua scaturigine in una questione nevralgica: perché la classe operaia, anche dopo la delucidazione operata da Marx, continua a accettare lo sfruttamento? Cosa le impedisce di costituirsi finalmente come soggetto rivoluzionario? Come possono gli oppressori, i dominanti, avere il consenso degli oppressi, dei subalterni? Una questione che, sconfinando anche in quella più generale dei meccanismi del potere, rende le analisi e le categorie di Gramsci ancora un riferimento notevole per altri contesti e momenti storici, come è accaduto ad esempio nello studio dei processi di dominio coloniale e di decolonizzazione. In effetti, dalla loro prima pubblicazione, nel 1948, fino a oggi, sui Quaderni si è accumulata una bibliografia immensa.
Ora, se il rifiuto costante da parte di Gramsci di ogni materialismo metafisico e naturalistico o dell’idea di una “necessità storica” che salvaguardasse misticamente la prospettiva della salvezza finale dall’incertezza e dalla fragilità delle attività umane gli ha permesso di tenersi fermo ad un marxismo non dogmatico e a un comunismo non messianico, è pur vero che gli accenti, svolti nell’ottica di un leninismo aggiornato, sul ruolo decisivo del partito, sul compito pedagogico degli intellettuali, sulla guerra di classe come “guerra di posizione”, destano oggi perplessità alla luce dei germi di totalitarismo che incubano. Tutta la vita e il pensiero di Gramsci sembrano avviluppati in un’aporia insolubile ma feconda tra il credo militante al comunismo come esito, se non automatico, quantomeno compiuto, della lotta di emancipazione umana, da un lato, e la convinzione filosofica di una storicità integrale della condizione sociale umana, ovvero di un’umanizzazione integrale della storia che rende provvisorio quell’esito e ogni realizzazione umana, dall’altro lato. Ma è nella sua codificazione del marxismo, in particolare delle Tesi su Feuerbach, come filosofia della praxis, tutta impregnata del neoidealismo italiano, da lui percorsa con coerenza, sia nel periodo precarcerario sia nei Quaderni, che possiamo rinvenire il nocciolo attuale del suo pensiero. Non c’è per il filosofo Gramsci prima lo spirito o prima la materia, sicché poi si possa dedurre l’uno dall’altra, ma c’è innanzitutto la prassi dell’uomo, la sua attività nel e sul reale, che si riappropria del suo prodotto per continuare a trasformarlo, senza mai incatenarvisi come se fosse una “necessità” intranscendibile.
Molti interpreti riconoscono oggi il debito gramsciano con Gentile, sin dagli anni dell’attivismo ordinovista e dell’esaltazione degli organi di autogestione operaia come espressione dell’autonomia umana. Successivamente, nei Quaderni, come ha osservato acutamente Salvatore Natoli, Gramsci critica Croce “in forza di un attualismo talmente interiorizzato da poter essere perfino taciuto” (Giovanni Gentile filosofo europeo, Bollati Boringhieri, Torino 1989). Vale per la filosofia della praxis di Gramsci il modo in cui l’amico e liberale Gobetti riassunse in chiave democratica e progressista la lezione gentiliana, un anno prima della marcia su Roma di Mussolini, dell’ottobre 1922, che avrebbe poi tragicamente divaricato i destini politici dei tre intellettuali che si riconoscevano, fino a quel momento, nello stesso paradigma filosofico: “La verità non è ciò che è, ma ciò che si fa, ciò che si sviluppa”. La filosofia della prassi è una filosofia radicale della responsabilità, che pone l’accento sul carattere emancipante dell’autodeterminazione e della cultura critica. Ereditare Gramsci, oggi, potrebbe significare allora tradurre l’esigenza rivoluzionaria che anima da cima a fondo la sua riflessione teorico-pratica nel progetto di una democrazia radicale che abbia di mira sempre l’accrescimento delle libertà degli uomini e nell’impegno politico a difenderlo ogniqualvolta esso si riveli in attrito con il progetto capitalista di ridurre la società umana ad una platea di produttori e consumatori, asservendo tutto e tutti alle “logiche” della produzione presentate come una fatalità inevitabile. E per questo l’insegnamento principale di Gramsci, ancora attuale, è appunto quello di non subire la storia come una fatalità, ma sforzarsi sempre di rimanerne attori.







