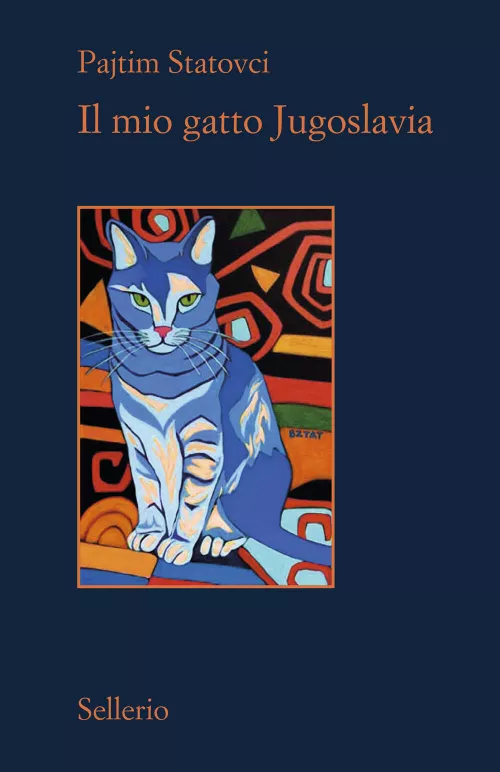Gatti selvatici e serpenti domestici
L’inizio è il linguaggio in codice di una app di incontri online tra uomini, il finale è la morte di un padre cresciuto nel culto dell’epica balcanica. La Finlandia e il Kosovo non sono separati solo da tremila chilometri e tre giorni di viaggio in pullman, ma da ere storiche e politiche dove il rimescolarsi di natura e cultura ha creato ambienti e tipi antropologici sideralmente lontani. Pajtim Statovci, nato in Kosovo nel 1990, aveva ventiquattro anni quando ha scritto Il mio gatto Jugoslavia (trad. di Nicola Rainò, Sellerio, 2024), un racconto vicino-lontano, che parla al passato e al presente, dove il lettore incontra miti e favole, figure archetipiche permeate da usanze rigide e rituali tradizionali, raffinati omosessuali nordici, gatti parlanti e serpenti domestici. Perché solo il mescolarsi dei generi – dall’epopea western, al realismo magico, dal surrealismo al diario – riesce a rappresentare la disgregazione violenta del paese balcanico e le vite dissociate di chi a tutto questo è sopravvissuto.
Le pagine alternano la voce del figlio Bekim a quella della madre Emina. È la primavera del 1980 quando, diciassettenne, viene chiesta in matrimonio da Bajram, il cui nome significa festa e la cui famiglia promette benessere. Ma il bel giovane si rivela indifferente e manesco, collerico e sempre insoddisfatto, Emina diventerà la sua moglie-serva: sempre ubbidiente, sempre picchiata. La data delle nozze – il 4 maggio – decide il suo futuro, ma anche il destino di un paese, perché lo stesso giorno muore Tito. Come nelle fiabe balcaniche il matrimonio si trasforma in un funerale – proprio così inizierà l’assedio di Sarajevo –, e l’eccitazione della festa in pianto.
Emina e Bajram lasciano il villaggio e si trasferiscono con i figli a Pristina, presidiata dall’esercito federale dopo i comizi di Milošević che incitava la minoranza serba alla rivolta. Alla fine degli anni ottanta si apre la caccia all’albanese, arrivano notizie di torture, i processi diventano politici, l’illegalità una pratica diffusa. Pochi nelle altre repubbliche hanno la consapevolezza che nel Kosovo lasciato al suo destino stava andando in scena il primo atto della finis Jugoslaviae.
A Pristina era diventato pericoloso vivere. “La morte era un abito sulla nostra pelle, e l’intera città era avvolta in un sudario cosparso di cenere. Tossiva polvere e intonaco, e intorno c’era una foschia spettrale, così vicina che tutta la nostra vita assunse un’altra forma: non era più un viaggio straordinario, ma una piccola incisione, una puntura di spillo su un polpastrello, una pugnalata in un vicolo buio, e non c’era niente di straordinario”.
L’esistenza di Emina è incalzata da una traiettoria paradigmatica. Da un villaggio ai piedi della montagna, istruita e controllata dall’autorità di un padre che “era come i padri al cinema. Con il suo bel viso affusolato dai tratti occidentali, la voce autorevole e la struttura solida di un soldato, benvoluto e onorato – un kosovaro della migliore specie”, si ritrova madre di cinque figli in un appartamento per profughi in Finlandia. Il mondo fuori è tutto un altro, in famiglia però il copione patriarcale albanese non muta. Intanto, come capita agli immigrati di seconda generazione, i figli parlano sempre più finlandese e sempre meno albanese. I legami con le origini si affievoliscono, il contatto con quanto accade laggiù rimane la televisione.
“Nessuno dovrebbe vedere immagini simili, immagini di cadaveri che non sono più corpi perché ne mancano pezzi, e la pelle non ha il colore della carne ma è un involucro rosso acceso o scuro, e le strade non sono strade ma fosse comuni. Come era possibile arrivare a una condizione simile? Omicidi di massa, stragi, esplosioni, brogli elettorali, vittime, incendi: l’ascolto di queste notizie era diventata la nostra esistenza quotidiana.
A volte avevamo la sensazione che quanto si vedeva in televisione non fosse la realtà. Che fosse un’illusione, un riflesso irreale di eventi irreali.
E invece tutto accadeva davvero, la vita di tanta gente era finita, e io mi sentivo una vigliacca perché ci eravamo rifiutati di morire combattendo. Un giorno saremmo morti tutti, mi dissi, e di nessuno di noi sarebbe rimasto niente. Non era più nobile morire per una causa invece di darsi alla fuga? Morire in battaglia, piuttosto che di vecchiaia?”
Ogni nuova strage porta Emina a dubitare dei valori nei quali credeva. “Dio non fece niente, perché Dio non esisteva. Esisteva la guerra, e la guerra era una trafila di tornado che squarciavano la terra fino alle radici, era una serie di maremoti che uno dopo l’altro inghiottivano edifici, villaggi, città, uno tsunami di acqua che prima li impastava come una sfoglia e poi li risputava”.

La famiglia si dissolve, i figli si allontanano, Emina abbandona il marito e per la prima volta si ritrova a lavorare fuori casa e a vivere da sola; Bajram torna in Kosovo dove decide come vuole morire. Ogni contiguità tra padre e figlio provoca dolore e violenza, si sono solo sfiorati, mai davvero conosciuti. “Lui però riesce a intrufolarsi tra le righe, nelle frasi dove compaiono certe parole, nelle consonanti che sono nel suo nome e nel mio. Viene con me mentre faccio una corsa, si insinua nei miei passi, è lì quando tutti e due i miei piedi non toccano il suolo, e quando lavo lo stesso bicchiere tanto a lungo che mi si rompe tra le mani, lui è lì, nella ferita che sputa sangue nello scarico del lavandino”.
Bekim descrive la solitudine crudele del profugo: “così solo che a volte nel mio appartamento parlavo con me stesso, che ogni tanto facevo una passeggiata nel parco, mi sedevo su una panchina e osservavo per ore la gente che se ne stava in compagnia”. L’unica creatura viva che impara a conoscere, a nutrire e accarezzare è un boa constrictor, il serpente che arriva a casa sua portato da un corriere dentro una scatola. “Non parlava una lingua che potessi comprendere”: Bekim lo ama e lo vuole proteggere, con il suo serpente vorrebbe vivere per sempre.
Nella sua educazione sentimentale è importante anche l’incontro con un partner gatto. È un gatto parlante, forse parente del gatto Behemoth, aggressivo seppur filosofo, che scorrazza nel Maestro e Margherita. Con lui si confida: “Gli raccontai delle persone a cui ogni volta dovevo spiegare il mio nome, e che, quando rispondevo alle loro domande e dicevo da dove proveniva il mio nome, si mostravano sempre deluse. Ecco perché sono così diffidente al riguardo: capisci, da un nome può derivare più male che bene. (…) E quando mi chiedevano di dire qualcosa nella mia madrelingua, qualcuno commentava ad alta voce che era un peccato che quella conoscenza qui non fosse di alcuna utilità”.
Mentre sperimenta diverse forme dell’amore, Bekim cerca di “conquistarsi la vita che vuole”: tenere in equilibrio la relazione con un uomo finlandese, evitando il rischio di ripetere il copione materno di servo-padrone. Ma è condannato a convivere con il suo “doppio sguardo”, in epigrafe cita Il ponte sulla Drina di Ivo Andrić: “Per vedere con chiarezza e capire la configurazione della cittadina e la natura del suo rapporto con il ponte, bisogna sapere che in centro esiste un altro ponte, così come esiste un altro fiume”.
Nelle interviste Pajtim Statovci racconta di essersi rifugiato nella letteratura per cercare di comprendere come la pensano gli altri, e soprattutto chi la pensa diversamente. Con la pubblicazione di Il mio gatto Jugoslavia si è liberato dalla vergogna di essere un immigrato, il ragazzino albanese traumatizzato dalla guerra guardato con pietà. Aveva interiorizzato il razzismo avvertito in Finlandia, in qualche modo evocava la persecuzione subita nel Kosovo dagli albanesi considerati inferiori dai serbi.
Il trauma non può sparire, il male che vedi diventa il male che fai, dice lo scrittore, che nei libri successivi continua a scolpire con una lingua icastica, capace di potenti metafore, figure che cercano un loro io per emergere dalle sorti collettive delle vicende balcaniche. In Le transizioni (Sellerio, 2020) il protagonista inventa continuamente se stesso e non ha più origini né nazionalità; in Gli invisibili (Sellerio, 2021) l’amore di due uomini, uno serbo l’altro albanese, si trova ad affrontare l’orrore della violenza bellica capace di produrre una perversione autodistruttiva.
Con la piccola folla di scrittori sparsi in diverse parti del pianeta, che scrivono in sempre nuove lingue e hanno radici nel paese scomparso, Pajtim Statovci ha in comune l’ispirazione: quel mosaico Jugoslavia che continua a vivere e a ricostruirsi nella letteratura.
Perché, come scrive Aleksandar Hemon in Il libro delle mie vite (qui in doppiozero): “Il bisogno di raccontare storie è profondamente radicato nella nostra mente, e inscindibilmente intrecciato ai meccanismi che generano e assorbono linguaggio. L’immaginazione narrativa – e quindi la letteratura – è uno strumento evolutivo fondamentale per la sopravvivenza. Elaboriamo il mondo raccontando storie e produciamo conoscenza umana stringendo legami con dei noi immaginati”.