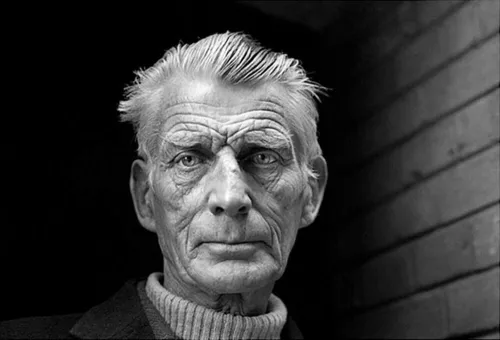Speciale
La capitale delle rovine
Nel luogo in cui un anno fa c’era un pendio d’erba, all’angolo formato dall’incontro delle strade di Vire e di Bayeux all’entrata della città, di fronte a quel che resta della seconda più importante scuderia di Francia, sorge ora un ospedale. È l’ospedale della Croce Rossa Irlandese a Saint-Lô o, come lo chiamano gli abitanti della città, l’Ospedale Irlandese.

L’ospedale è composto da venticinque edifici prefabbricati di legno. In termini generali, sono di qualità superiore rispetto a quelle costruzioni prefabbricate messe in così scarsa quantità a disposizione dei più ricchi fra tutti quelli a cui i bombardamenti hanno ridotto le casa in macerie, o dei più raccomandati, o dei più scaltri, o anche di chi dimostra di possedere le ragioni più evidenti per meritarsela.
La rifinitura di queste costruzioni, sia fuori che dentro, è la migliore possibile, considerate le misure d’urgenza. Sono foderate di lana di vetro e ricoperte da isorel, una strana sostanza disponibile solo in quantità molto limitate. Alle finestre c’è vetro autentico. L’atmosfera che ne risulta è areata e luminosa, confortevole per i malati come per il personale esausto.
I pavimenti, dove le esigenze igieniche sono fondamentali, sono ricoperti di linoleum. Non c’era abbastanza linoleum in Francia per riuscire a fare più di così. Il soffitto e i muri della sala operatoria sono rivestiti da placche d’alluminio d’origine aeronautica, una soluzione pratica e decorativa per risolvere un vecchio problema, una variante spiritosa alla metamorfosi della spada nel vomere d’aratro. Un sistema di passaggi coperti collega le cucine ai refettori e alle sale comuni. Quanto al riscaldamento e alle necessità energetiche, la fornitura di corrente elettrica non lascia affatto a desiderare.
L’ospedale usufruisce d’un riscaldamento centrale a carbone. Il personale medico, di laboratorio, infermieristico e amministrativo è irlandese, e la strumentazione, il mobilio (compresi naturalmente i letti e la biancheria), i farmaci e il cibo sono forniti dal comitato. Credo di non sbagliarmi dicendo che il numero di persone ricoverate (uomini e donne) ammonta a novanta malati circa. Per quanto riguarda le altre, secondo gli ultimi rapporti se ne contano abitualmente fino a duecento al giorno, che vengono qui per la consultazione.

Tra i malati assistiti ambulatorialmente, ce ne sono parecchi che soffrono di scabbia o d’altre malattie della pelle, dovute senza dubbio alla malnutrizione o al regime alimentare poco equilibrato. Gli incidenti sono frequenti. Crollano pezzi di muro quando uno meno se l’aspetta, i bambini giocano coi detonatori e il lavoro di sminamento è continuo. Il laboratorio, ottimamente attrezzato, sta per diventare il laboratorio ufficiale del dipartimento se non addirittura d’una area ancora più vasta. Un considerevole lavoro d’analisi delle acque della regione è già stato portato a termine.
Questi pochi esempi, scelti del tutto non a caso, sono senza dubbio già familiari a chi s’interessa della questione, e forse anche a quelli che oggi mi stanno ascoltando. Certo, possono non sembrare subito particolarmente istruttivi. Che i muri della sala operatoria siano ricoperti d’un metallo costoso, o che il pavimento della sala parto sia rivestito di linoleum, è qualcosa che a malapena riuscirà a suscitare l’interesse di quanti hanno l’abitudine di considerarle come condizioni sine qua non per dei servizi d’ostetricia e di chirurgia degni di questo nome.
Sono persone di buon senso che preferirebbero avere notizie sui canali semicircolari degli abitanti della Normandia, o sulla loro resistenza allo zolfo, piuttosto che sul loro atteggiamento nei confronti degli irlandesi e dei loro doni, e che preferirebbero un resoconto sulle nostre difficoltà alle prese con una farmacopea o con un sistema di misurazione insoliti, piuttosto che sentirsi raccontare il modo con cui ci relazioniamo alla originale e famosa disposizione d’animo che è quella dei francesi.
Eppure, fin dall’inizio, tutta l’impresa ha funzionato perché si è stabilita una relazione alla luce della quale la relazione terapeutica si riduceva a un semplice pretesto. Quello che era importante, non era che noi avessimo la penicillina mentre loro non ne avevano, non era la generosa liberalità del ministro francese della Ricostruzione (come lo si chiamava allora), ma che si riuscisse, a volte, a intravedere noi in loro e – chissà (visto che è un popolo dotato d’immaginazione) – loro in noi, quel sorriso che compare quando si pensa alla condizione umana, un sorriso che nemmeno le bombe sono in grado di cancellare, non più di quanto gli elisir di Burroughes e Welcome possano farlo diventare più grande, – un sorriso che, fra le altre cose, rovescia in derisione gli abbienti e i non abbienti, quelli che danno e quelli che prendono, la malattia e la salute.
Non sarebbe decoroso che un magazziniere, riservato e per di più riservista, descriva gli ostacoli incontrati in tale rapportarsi, o i mezzi, spesso grotteschi, che il temperamento dei locali e quello degli stranieri elaborarono mettendo insieme le proprie energie. Si può solo pensare che non fossero insormontabili, dal momento che hanno smesso da tempo di avere una qualche importanza.

Oggi, quando penso ai problemi ricorrenti in quel periodo, periodo che, in tutta modestia, potrebbe essere definito eroico, quando penso in particolare a un problema tanto arduo e senza soluzione da non poter essere letteralmente neanche formulato, sospetto che i nostri sforzi fossero quelli inerenti a questa semplice e necessaria constatazione, a cui tuttavia era così difficile arrivare, e cioè che il loro modo d’essere noi non era il nostro e che il nostro modo d’essere loro non era il loro. A essere giusti, bisogna anche dire che molti di noi non erano mai stati all’estero prima d’allora.
I bombardamenti hanno cancellato Saint-Lô in una notte. I prigionieri di guerra tedeschi, insieme agli occasionali sterratori attirati dalla relativamente abbondante razione alimentare, e presto però scoraggiati dalle condizioni degli alloggi, a due anni dalla liberazione continuano a sgombrare macerie letteralmente a mano. Le loro anime non sono ancora state illuminate dalle benedizioni di Gallup, e la loro carne non ha ancora scoperto i benefici del bulldozer. Ecco perché saremo senza dubbio scusati se dubitiamo dell’opinione generale secondo la quale dieci anni basteranno a ricostruire completamente Saint-Lô.
Importa però poco il numero d’anni che bisognerà aspettare prima che la città torni ad assomigliare di nuovo al pimpante e prospero centro agricolo e amministrativo che era. Nei giardini tra le strade di Vire e di Bayeux, l’ospedale di case di legno continuerà a svolgere la propria funzione e a dispensare le proprie cure. La parola “provvisorio” non ha più il senso che aveva, in questo universo diventato provvisorio.
L’ospedale continuerà a svolgere la propria funzione anche molto tempo dopo che gli irlandesi saranno ripartiti e i loro nomi dimenticati. Tuttavia, mi viene da pensare che lo chiameranno l’ospedale irlandese fino a quando esisterà in quanto ospedale, e che in seguito, quando i fabbricati saranno stati trasformati in alloggi, saranno sempre chiamati i fabbricati irlandesi. Evoco questa eventualità nella speranza che la cosa potrà far piacere a tutti.
Detto questo, posso forse avanzare un’altra ipotesi, più remota ma probabilmente di portata più grande in certi ambienti, intendo l’eventualità che tra quelli che sono stati a Saint-Lô, qualcuno ritorni a casa rendendosi conto di aver ricevuto per lo meno nella stessa misura di quello che ha dato, e di aver in realtà ricevuto quello che difficilmente sarebbe stato in grado di dare: la visione e il senso immemorabile d’un concetto d’umanità in rovina, e di essere forse riusciti persino a intravedere i termini entro cui dovrebbe essere ripensata la nostra condizione umana. Questi sono gli uomini che sono stati in Francia.
Tratto da Il Reportage numero 8, ottobre 2011. Traduzione di Luigi Toni e Michele Zaffarano