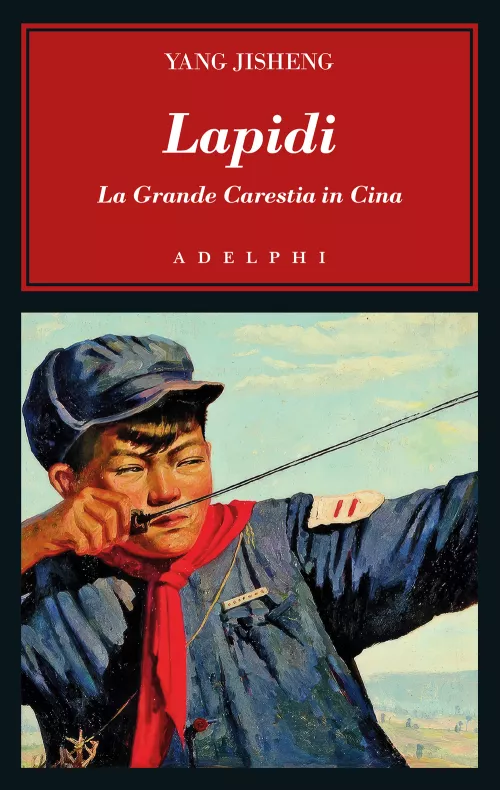Le lapidi del maoismo
Mao Zedong ordinò: “Marx più Qin Shi Huang”. Coniugando Carlo Marx con il primo imperatore della dinastia Qin, che costruì la Cina due millenni orsono, Mao Zedong diceva: costruirò il comunismo e ne sarò l’imperatore. Yuang Jisheng, autore di Lapidi (Adelphi, 2024), ci racconta la grande carestia in Cina negli anni tra il 1958 e il 1962, durante la quale morirono di fame 36 milioni di persone, carestia causata, e l’autore ce lo dimostra a valle di una approfondita ricerca, dalle paranoidi politiche del Partito Comunista Cinese di cui Mao era imperatore indiscusso, e soprattutto indiscutibile. La versione del libro che noi leggiamo, circa ottocento pagine nella bella e avveduta traduzione di Natalia Francesca Riva, raccoglie una messe di documenti enorme sul cosiddetto Grande Balzo in avanti, causa diretta della grande carestia nelle diverse regioni della Cina, documentazione che occupa le cinquecento pagine centrali del libro.
Forse non è necessario leggerle tutte nel dettaglio. Ma le duecento pagine di apertura e le cento di chiusura di questo libro vanno lette con attenzione, perché si tratta di un preciso resoconto di cosa fu e di cosa voleva essere la cosiddetta edificazione del comunismo, e cioè la collettivizzazione forzata della popolazione contadina cinese, con la sostituzione della proprietà privata – la proprietà è un furto, scriveva Prudhon – con il sistema delle comuni popolari nelle quali tutto veniva chiuso, persone e cose, e perfino le opinioni. Un ordine precedente, iniquo, gonfio di disuguaglianze terribili e gravato da relazioni di sfruttamento dell’uomo sull’uomo, dei contadini ricchi su quelli che non lo erano, venne dirigisticamente sostituito – d’imperio, parola azzeccata – da un ordine terribile, fondato sulla coercizione, un ordine vorrei dire innaturale, destinato a sgretolarsi quando non tenuto insieme con la forza. “Dichiaro a partire da oggi (…) l’inizio del comunismo”, tuonava un alto dirigente di una comune modello, quella di Paoma, nell’Hebei, “il comunismo eliminerà la proprietà privata e la famiglia.
A eccezione delle nostre mogli, nulla sarà più privato.” La paranoide proprietà privata delle mogli si sposava – è il caso di dirlo – con la consegna di tutti gli animali e di tutti gli attrezzi di lavoro alla comune, e in molti casi di tutti gli utensili di cucina alle mense comuni. Corollario di questo ‘inizio del comunismo’ fu la costituzione nell’immensa Cina “di un immenso esercito di quadri dirigenti”, diverse decine di milioni: “I contadini dicevano: ‘In passato diversi villaggi mantenevano un solo balivo, adesso un solo villaggio ne mantiene un folto gruppo’”. A un precedente sistema di potere quietamente tremendo, che teneva la gran parte della popolazione rurale cinese in una condizione di immutabile miseria, veniva a sostituirsi un rivoluzionario sistema di potere altrettanto terribile, che provocò la grande carestia del 1958-1962.
Questo è stato il comunismo in Cina – come fu più o meno in tutto il mondo – fino agli albori degli anni Ottanta, dopo la morte di Mao e la fine di un altro flagello, la Rivoluzione Culturale. Poi ci fu la svolta, e disse Deng Xiaoping: “Arricchirsi è glorioso”, avviando il ritorno a condizioni di libero mercato – pur sotto lo stretto controllo del PCC. Io vorrei che tutti quelli – e quanti tra i miei amici… – che ancora si sciacquano la bocca con la parola comunismo – che sì, nella sua spinta originaria era cosa ben diversa – leggessero i primi cinque capitoli di Lapidi, e gli ultimi due.
Ora, un po’ di considerazioni a margine. Yuang Jisheng si domanda nel capitolo 14: perché la grande carestia non ha provocato disordini? La storia della Cina è costellata di periodi di carestia, in alcuni casi per cause naturali, e di grandi rivolte contadine. Ma la Cina negli anni di Mao era chiusa in una morsa ferrea, un sistema di dispotismo che dal vertice dell’impero – dove tutti stavano bene attenti a non passare il limite nelle critiche al monarca assoluto – scendeva fino al livello delle masse contadine, organizzate quasi militarmente, dirette da un esercito di funzionari, dentro a quell’ordine assoluto secondo cui non solo il dissidente andava punito, ma anche chi non partecipava al processo di punizione e di delazione veniva a sua volta considerato dissidente.

Conseguenza devastante fu l’impossibilità di comunicare in modo corretto gli effetti rovinosi della collettivizzazione forzata – compresa qui la convenienza dei quadri locali di comunicare dati falsi. Lapidi è una compiuta descrizione del totalitarismo in un paese comunista, e la tesi centrale del libro è che proprio il totalitarismo sia alla radice della strage. Altra considerazione, sulla censura in Cina oggi: noi leggiamo Lapidi in una versione ridotta della metà rispetto a quella originale che l’autore pubblicò quasi vent’anni fa a Hong Kong – la versione ridotta fu confezionata dallo stesso Yuang Jisheng per renderla digeribile all’editoria europea e al suo pubblico. Perché a Hong Kong? Perché un libro siffatto nella Cina di oggi è censurato. Come agisce oggi la censura?
In modo ambiguo, al punto che Yuang Jisheng dopo la pubblicazione all’estero (allora Hong Kong era indipendente) ha continuato a lavorare come giornalista e ricercatore, anche se la stretta imposta da Xi Jinping negli ultimi anni lo ha consigliato a tenere un profilo molto basso quando il libro uscì in Europa. Racconto sempre di come, analogamente, uno dei più grandi romanzieri contemporanei, Yan Lianke, pubblicò all’estero il suo I quattro libri, che racconta i campi di detenzione per artisti in Cina nei tre decenni del maoismo: bene, Yan Lianke entrò a far parte dell’Associazione degli Scrittori Cinesi, organo dello stato – da cui molti autori si tenevano e ancora si tengono ben lontani – fino ad assumerne cariche direttive. Sono altri tempi questi, rispetto al maoismo, ma il nuovo imperatore Xi Jinping è comunque convinto della necessità di subordinare gli intellettuali ‘alle necessità del popolo’. Oggi in Cina si usa molto il termine ‘autocensura’: limitarsi, prima di incorrere in sanzioni.
Mi domando, poi, come mai Adelphi decida oggi di pubblicare un libro del 2008, che in Francia Editions de Seuil tradusse nella sua versione ridotta già dodici anni fa: forse in Italia siamo più indietro? Penso di sì. Penso che l’elaborazione del lutto sul comunismo – era sbagliato, punto – in Italia non sia ancora arrivata al suo termine. Ancora oggi c’è bisogno di raccontarsi cosa fosse davvero (penso a Vita e Destino di Grossman, sull’Urss, di cui molti si accorgono solo in anni recenti). Siamo molto indietro: mentre leggo Lapidi mi capita tra le mani il recente Mao Zedong di Guido Samarani (Salerno Editrice, 2024). Samarani è stimato docente di Storia e istituzioni dell’Asia a Ca’ Foscari, prestigioso ateneo veneziano: vado a cercare nella biografia di Mao le pagine dedicate agli anni del Grande Balzo in avanti.
Nel suo libro descrive correttamente l’inquadramento della popolazione rurale nelle comuni popolari (il 99% delle famiglie rurali, scrive), e l’abolizione di ogni forma di proprietà privata. In seguito, “lo stesso Mao riconobbe che ci si era spinti troppo in avanti”, scrive Samarani, che poi ci dice che nella seconda parte del 1959 “la situazione agricola ed economica divenne sempre più incerta e problematica”, citando una “consistente contrazione dell’offerta di beni di prima necessità”. Più avanti ricorda la diminuzione del 30% della produzione cerealicola, e cita le varie stime che indicano per quegli anni tra i 10 e i 30 milioni di morti. “Disastrosi sviluppi”, “drammatiche conseguenze”: non utilizzando la parola carestia, l’autore non sembra volerla attribuire alla collettivizzazione forzata, che invece drammatica non gli pare.
Ho sbagliato anch’io nel mio passato: gridavo, in piazza all’inizio dei Settanta, “Mao, Lin Biao, Chen Boda, l’imperialismo non passerà”. Dieci anni dopo, in una tesi di laurea sul socialismo africano di Nyerere, in Tanzania, citavo un economista marxista locale, Issa Shivji, che chiamava quel sistema ‘dittatura della borghesia burocratica”, definendo come una nuova classe sociale l’esercito di funzionari che – in Tanzania come era successo nella Cina descritta da Yang Jisheng – faceva il bello e il cattivo tempo cavalcando la collettivizzazione forzata della popolazione costretta a riunirsi nei nuovi villaggi cooperativi ‘Ujamaa’. La Cina, stanca dopo il Grande Balzo in avanti e la Rivoluzione Culturale, superò “i suoi eccessi” con la svolta di Deng Xiaoping che aprì al libero mercato, dando il via alla inarrestabile crescita e modernizzazione che ha portato il reddito pro capite a moltiplicarsi per venti in tre decenni. La Tanzania crollò su sé stessa – un po’ come l’Urss – e si arrese ai diktat di Banca Mondiale e FMI, aprì al libero mercato, e anche qui il reddito pro capite dopo la forte contrazione triplicò nei tre decenni successivi.
Un’ultima questione: il lessico. Ideologia deviazionista di destra, via conservatrice, avventurismo, tendenze opportunistiche. “Il partito è tenuto a fare attenzione alla prevenzione e correzione delle tendenze conservatrici di destra o avventuristiche di sinistra”. “Dobbiamo opporci all’interpretazione soggettiva di questo concetto”. E poi: cricca, elementi controrivoluzionari, le masse. Mi domando se questo linguaggio abbia radici nel cinese mandarino, o sia una riproposizione della terminologia usata per un secolo e mezzo dal movimento comunista, e dagli stati comunisti. C’è anche, nella storia del comunismo in quel paese, una terminologia più chiaramente cinese, “i cinque venti”, “che cento fiori fioriscano, che mille scuole sboccino”, e il notissimo “servire il popolo”, fino al recente “armonizzare”, utilizzato al posto di ”reprimere il dissenso”: penso, insomma, che su questo lessico si potrebbe scrivere un libro intero.
Penso anche, e qui spero di non essere impallinato, che ci sia un impressionante parallelismo tra questo linguaggio e il linguaggio che si utilizza nelle grandi corporation – in inglese, ovviamente, anche quando lo si usa in Italia. Un linguaggio pieno di enfasi, incardinato su parole chiave, anzi parole lucchetto che, cioè, non si aprono a un significato ma consentono unicamente di connotare il bene e il male (l’utile o la perdita, alla fin fine) costruendo quasi una morale. È un linguaggio – lo definivano ‘cultura d’azienda’ – che consente una comunicazione semplificata tra i vertici e la base – le masse?: qui magari la forza vendita, gli area manager, i promoter, i merchandiser, i product manager. In fondo quel comunismo lì si pose il compito di trasformare un paese in una gigantesca azienda, dove il vertice potesse tirare le fila di ogni singolo aspetto dell’attività economica dei suoi dipendenti. Yuang Jisheng, che a questa ricerca è stato spinto dal ricordo del padre morto di fame nel ’59, scrive: “Personalmente non nutro alcun dubbio sulla sincerità dei fondatori del Partito comunista: probabilmente molti di loro volevano davvero salvare il popolo dalla sofferenza” (…). E poi: “Allora perché il sistema che crearono fu diametralmente opposto all’ideale originario?”