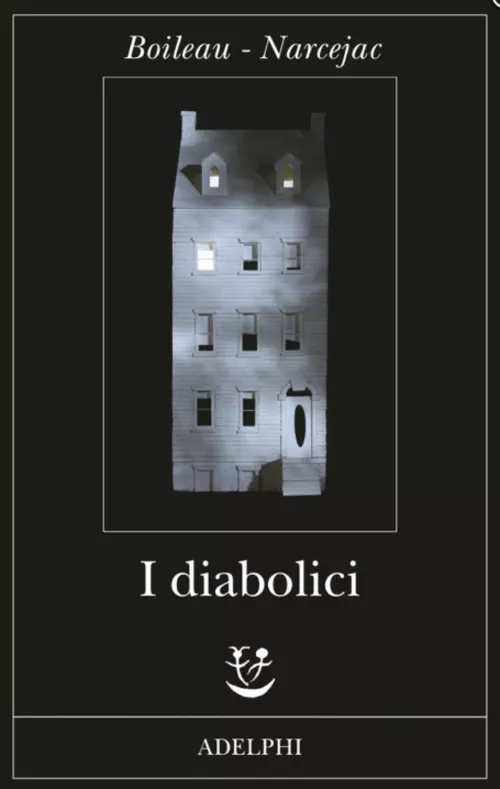Il mondo torbidamente esistenzialista de I diabolici
Adelphi, che con il mastodontico lavoro di recupero integrale di Simenon ha fatto del rilancio di certa letteratura di genere quasi una missione, ha ora inaugurato la pubblicazione di alcune delle opere di una pressoché dimenticata coppia di autori che ha scritto la storia del noir, registrata all'anagrafe letteraria sotto il nom de plume Boileau-Narcejac, con una nuova traduzione di Celle qui n'était plus (Éditions Denoël, 1952). Federica Di Lella e Giuseppe Girimonti Greco, così come avevano già fatto i traduttori che li hanno preceduti (Sarah Cantoni per A. Mondadori nel 1981 e Francesca Rimondi per Fazi nel 2003), scelgono di adeguarsi alla versione cinematografica di Clouzot che di quel libro aveva fatto la fortuna e di intitolare quindi il volumetto I diabolici. D'altronde fin dal 1955, anno d'uscita nelle sale di Les Diaboliques, anche le numerose riedizioni francesi adottano questo titolo a fianco di quello originale (spesso confinato tra parentesi tonde e recuperato soltanto in tempi recenti come titolo primario) – e ciò avviene nonostante il film di Clouzot si discosti non poco dal romanzo di Boileau-Narcejac non soltanto per trama, personaggi e ambientazione, ma persino per spirito e tono. Identico destino dell'altro romanzo del duo divenuto oggetto di culto, D'entre les morts, che dal 1958 diventa Sueurs froides, Vertigo o La donna che visse due volte, a seconda del titolo con cui il capolavoro di Hitchcock da lì tratto è stato distribuito nei diversi paesi. Ed è forse proprio grazie a questa seconda vita sotto la tutela di un altro nome più benevolo, un nome che dopo essersi fatto conoscere torna, per così dire, al proprio legittimo proprietario, che i libri di Boileau-Narcejac vengono ancora letti e strappati all'oblio. Così a volte vengono saldati i debiti che grandissimi artisti hanno contratto con altri artisti meno grandi e noti, senza i quali però i primi non sarebbero appunto così grandi.

Tuttavia bisogna cominciare dal titolo voluto originariamente da Boileau-Narcejac, se si vuole afferrare in un'unica immagine l'idea centrale, quasi l'ossessione, del lavoro dei due romanzieri che per un quarantennio hanno plasmato i motivi e la forma del noir. Celle qui n'était plus contiene infatti in germe tutto l'essenziale di un romanzo la cui ossatura (un triangolo amoroso che si dovrebbe sciogliere tramite un omicidio il cui movente è la riscossione di una polizza assicurativa sulla vita) è altrimenti piuttosto semplice e persino banale – di certo perfettamente in linea con le convenzioni del genere. Il titolo originale dice: c'è una donna, che non era più, che era morta. In quell'imperfetto che getta un'ombra di angoscioso dubbio sul presente – che apre allusivamente una voragine in ciò che è – c'è tutto un mondo: il mondo torbidamente esistenzialista de I diabolici. Con un effetto di sprofondamento paradossale l'unico attributo significativo della donna, l'inesistenza, non è declinabile al presente e quindi, in qualche modo, non è. Quasi che la protagonista dichiarata del romanzo fosse una doppia assenza, un vuoto di secondo grado: e infatti Mireille, la lei (“celle” nel titolo francese) vittima del marito Ravinel e della sua amante Lucienne, manca fin quasi dalle prime pagine perché uccisa, e manca poi anche e soprattutto in quanto, in qualità di morta, quando il suo cadavere scompare inspiegabilmente ed eventi misteriosi sembrano alludere a una sua seconda vita, trascinando progressivamente Ravinel nel mulinello di un mondo che si inabissa e nei tormenti di un delirio paranoide d'interpretazione. “Lei” è, come direbbe forse Lacan, un oggetto che manca al proprio posto, che è sempre spostato rispetto a se stesso («toujours déplacé par rapport à lui-même»), ma che, proprio grazie al vuoto che lascia, permette agli altri elementi del racconto di circolare andando a occupare quella casella libera, un po' come avviene nel gioco del quindici. Il corpo di Mireille non è dove dovrebbe trovarsi – in cambio segni della sua presenza si moltiplicano dove e quando non dovrebbero esserci. Il romanzo di Boileau-Narcejac è costruito dunque intorno a un buco generatore di eventi, o meglio di interpretazioni che a loro volta precipitano gli eventi. Ed è anche per questo che I diabolici è un libro in primo luogo vertiginoso, con quel suo stare sempre sulla soglia di un burrone, di – appunto – un buco di senso.
Il vortice e la vertigine sono d'altronde motivi carissimi a Boileau-Narcejac (intorno a essi ruota, appunto, La donna che visse due volte), e in questo senso il narratore, facendo suo lo sguardo allucinato di Ravinel, ci mette in guardia: «Quello che andrebbe veramente preso sul serio non ha né nome né forma. È un peso. E al tempo stesso un vuoto» (p. 59). Di questa forza scissa al suo interno – un pieno che tira verso il basso e precipita, un pieno che come in un risucchio si sottrae svuotando – Hitchcock ha dato forse la più bell'interpretazione appunto con il dolly zoom di Vertigo: zoom in avanti e carrellata indietro, perfetta sintesi visiva – una sintesi però conflittuale e lacerata – di attrazione e repulsione:
Anche per questo il titolo attuale, per quanto icastico e accattivante, persino azzeccato nel tono nero (efficacissimo nell'individuare immediatamente il genere tanto quanto l'elegante e cupa veste grafica adottata da Adelphi), facendo pensare a personaggi vitali, capaci di tramare attivamente ed essere motori appunto diabolici degli eventi, è sostanzialmente ingannevole. Fatta eccezione per Lucienne, l'amante scaltra ed effettivamente diabolica, ma tutto sommato mossa da passioni elementari e caratterizzata da una logica rigida che traccia confini e distinzioni e che fa di lei il vero antagonista del nebuloso Ravinel, i personaggi di Boileau-Narcejac sono piuttosto degli indiavolati, posseduti e agiti da demoni che li manovrano e di cui sono, sotto la maschera da carnefici, in primo luogo vittime. Il delitto di cui è autore Fernand Ravinel, rappresentante di commercio insoddisfatto della propria vita monotona e protagonista effettivo del romanzo sul punto di vista del quale è focalizzata la narrazione, «è dovuto a una concatenazione di circostanze insignificanti, di piccole viltà a cui ha ceduto per indolenza» (p. 59). Ma ancora di più, Ravinel uccide perché è posseduto da un'idea mortifera che insegue – e manca fatalmente – nell'omicidio, e che trova compiuta soltanto quando, braccato dal fantasma della moglie, credendosi perseguitato dalla sua stessa vittima, rivolgerà questo impulso distruttivo contro se stesso. Quello che fa di Ravinel un buon personaggio noir è d'altronde proprio il suo vivere nel regno dei fantasmi e delle allucinazioni, dove i fatti non sono altro che immagini fuori controllo, virtualità che, troppo intensamente pensate, sfuggono al mondo dei possibili per installarsi in modo inquietante nella quotidianità.
In questo senso lo scivolamento in una realtà allucinata e il precipitare del protagonista nel delirio paranoide con tutta la sua tipica sintomatologia a partire dalle manie di persecuzione, più che il frutto del senso di colpa su una mente sconvolta o troppo debole per sopportare il peso delle proprie azioni, si rivelano come la realizzazione della vocazione infantile di Ravinel a sfuggire alla gabbia della realtà in quel commercio con le ombre che viene significativamente chiamato il «gioco della nebbia»:
Da piccolo, il Limbo se lo immaginava proprio così: una lunga attesa in mezzo alla foschia […]. Chiudeva gli occhi e, ogni volta, aveva l'impressione di cadere nel vuoto. Quella fantasia gli dava le vertigini, lo atterriva, eppure non era sgradevole […]. Sì, in quel gioco c'era sicuramente qualcosa di impuro, di peccaminoso. Eppure non ci aveva mai rinunciato. In seguito era anche riuscito a perfezionarlo. Aveva la sensazione di diventare invisibile, di dissolversi come una nuvola (p. 15-16).

In effetti, si potrebbe dire che I diabolici è un libro sulla nebbia. Fin dalla terza riga del romanzo, appena dopo l'apparizione del nome di Ravinel, Boileau e Narcejac ne mettono in scena di capitolo in capitolo le metamorfosi, ne registrano minuziosamente e regolarmente le variazioni di consistenza, colore e forma che accompagnano e, si ha talvolta l'impressione, determinano lo scivolamento degli eventi e il fluire morboso dei pensieri («Quella nebbia aveva un significato preciso», «Colpa della nebbia», pensa o dice Ravinel a più riprese). Fitta e densa, giallognola o caliginosa, vischiosa, concentrata in volute di vapore o frammentata in goccioline d'acqua, la nebbia avvelena la percezione della realtà, alludendo forse a qualcosa di misterioso, a una dimensione altra che convive con la nostra: imbroglia i giudizi, fa vaghi i confini e i contorni delle cose, rende impossibile distinguere tra bene e male, vero e falso, reale e immaginato. Confonde persino i ruoli, se è vero che Ravinel, lasciandosi invadere e inebriare dalla nebbia con la stessa disperazione e arrendevolezza con cui cede al muscadet o al cognac nell'angoscioso e vano tentativo di vagliare lucidamente situazioni e oggetti che sfuggono immancabilmente alla definizione e comprensione, finisce con l'identificarsi con l'affine Mireille, in un'inquietante inversione delle parti che, come viene suggerito nelle ultime battute di dialogo del libro, si sarebbe potuta giocare diversamente fino all'ultimo istante.
Non trovando il cadavere di Mireille là dove l'aveva abbandonato, Ravinel si chiede che diavolo di allucinazione rovesciata sia mai quella che non gli fa vedere ciò che c'è: proprio come se vagasse in mezzo alla nebbia incapace di vedere oltre se stesso, se non in modo confuso, diventa allora goffo, procede a tentoni con un corpo improvvisamente ingombrante e impossibile da controllare. In quel silenzio privo di riferimenti spaziali e in cui le distanze tra le cose sono annullate, il corpo si fa rumoroso e carico di senso indesiderato come non mai. E là dove la vista non funziona più, gli altri sensi lavorano in modo esasperato nel tentativo di decifrare indecifrabili segni provenienti dal mondo che si trova al di là del muro di nebbia, dove sembrano vigere leggi sconosciute e impenetrabili.
Il nebbioso strizza così l'occhio anche alla dimensione della narrazione, il cui genere si muove nei confini del fantastico così com'era stato inteso da Todorov, proprio per quell'esitazione tra naturale e soprannaturale, per quella sospensione del giudizio sullo statuto di realtà o fantasia degli eventi narrati che non è soltanto della ragione offuscata di Ravinel, ma anche del lettore. Da tale limbo – luogo di mezzo e dell'indecisione carissimo alla poetica de I diabolici – si esce per due porte antitetiche: quella di Lucienne, che ripristina la quotidianità con le sue note leggi, e quella sfondata da Ravinel, che apre sul meraviglioso con il dominio incontrastato delle immagini. L'epilogo del romanzo è così, a ben guardare, doppio: quasi non si volesse del tutto sciogliere l'enigma del fantastico.
Se Boileau e Narcejac sono maestri della suspense è d'altronde proprio perché hanno capito che la tensione si costruisce meglio a partire da uno stallo psicologico ed ermeneutico, piuttosto che sull'attesa di un evento drammatico. Al lettore de I diabolici non interessa sapere cosa succederà, ma come verrà spiegato ciò che è successo, sforzo nel quale si concentra tutta l'esasperante attesa che ha fatto sì che il romanzo venisse giustamente definito – come viene ricordato nel risvolto di copertina di Adelphi – «una sorta di interminabile attacco di cuore» (e forse non a caso Clouzot ha voluto che Christina Delassalle, personaggio che ne Les diaboliques occupa la posizione corrispondente a quella di Ravinel, fosse letteralmente una cardiopatica). Ed è nella rincorsa di quell'attimo in cui si decide di abbracciare il demone del delirio o di accogliere come una liberazione ciò che fa scoppiare il cuore, che a cinquant'anni di distanza dalla sua uscita leggiamo ancora, con un certo piacere perverso, I diabolici.