Speciale
Kafka: la passione teatrale
Per dire dei rapporti di Franz Kafka con il teatro, si leggono soprattutto i suoi Diari, dai quali emerge l’importanza del suo incontro con la compagnia di teatro yiddish frequentata nella Praga degli anni dieci; però nessun critico, se non sbaglio, ha sviluppato il dato forse meno vistoso ma più ricco di implicazioni, vale a dire il fatto che dal 1912, metabolizzando l’incontro fatale con quella modesta troupe di Lemberg (Leopoli, L’viv, in Ucraina), Kafka rinasce come scrittore, sceglie il sentiero da percorrere e realizza qualcosa di unico che consiste nel tradurre in termini letterari, ma non soltanto, forme e modi di quella originale poetica del grottesco, ovviamente declinandola secondo la propria sensibilità. Manca a tutt’oggi un’adeguata spiegazione del perché l’incontro determinante sia stato quello con gli artisti yiddish, ovvero con il loro modo di abitare la scena, e non quello con la loro drammaturgia.
Indagini di un cane (1922) è il racconto incompiuto che offre la principale testimonianza del vero e proprio innamoramento dell’autore per il teatro yiddish. Del tema si occupano Evelyn Torton Beck e Guido Massino, autori di libri preziosi sull’argomento ma appunto concentrati sulla drammaturgia yiddish, mentre a impressionare il Nostro erano soprattutto quegli attori e quelle attrici, la loro tangibilissima poesia collettiva in azione, della quale il testo scritto e il tessuto strettamente verbale erano soltanto uno sfondo secondario.
Ciò che scrive Kafka in proposito è di una chiarezza e di una potenza che non ammettono obiezioni. La sua ‘scoperta del teatro’ consiste nell’intenderlo all’istante come musica, musica che ri-vela il senso degli eventi umani al di là delle apparenze e del dicibile. È lo stesso sentimento che caratterizza le più significative ricerche teatrali del Novecento. In Indagini di un cane quella rivelazione è così ricordata (è il protagonista-narratore che parla): “tutt’a un tratto mi arrestai con la sensazione di trovarmi in un luogo giusto”. È una folgorazione del sentire, un istante che lo cambia irrevocabilmente e gli fa scoprire il punto di partenza per il proprio divenire, la mousike: “la musica mi aveva attorniato come un elemento vitale e indispensabile che nulla mi induceva a scindere dal resto della mia vita”. Nel quadro di questo nuovo sentire coglie la specificità dell’arte drammatica: “Allora ignoravo ancora quasi tutto della musicalità creativa che pertiene soltanto alla specie canina; essa naturalmente era sfuggita finora alla mia capacità di osservazione che andava sviluppandosi soltanto gradualmente”. Anzi, diciamolo meglio, non dell’arte si trattava ma degli artisti, non del teatro in generale ma di coloro che stanno in scena: “...tanto più stupefacenti e addirittura sconvolgenti furono dunque per me quei sette grandi musicanti”, i quali “non parlavano, non cantavano, in genere tacevano quasi con grande ostinazione, eppure facevano sprigionare, come per magia, la musica dal vuoto” [enfasi mia].
Il teatro borghese moderno, pure dal giovane Kafka conosciuto e frequentato, non lo interessava. I Diari contengono diverse annotazioni sul quel teatro, ma lui non si sofferma a descrivere quanto accade in scena – che evidentemente considera irrilevante – e propone piuttosto, come a suo tempo aveva fatto Baudelaire, poche notazioni frammentarie e ambientali. Invece lo affascina il teatro yiddish, un teatro di fisicità e parola, di gioco scenico e varietà di ritmi, capace di interloquire con il mondo mettendolo di fronte a uno specchio grottesco, un teatro dove “tutto era musica”. Iniziava così la sua appercezione (tema al quale Kafka dedica il proprio unico breve saggio), vale a dire quel sapere di sapere che trasforma la coscienza in un cantiere. Facendo propri i protocolli artistici e la postura esistenziale degli attori yiddish, Kafka diventa ciò che è, e, tra l’altro, crea una nuova forma di romanzo.
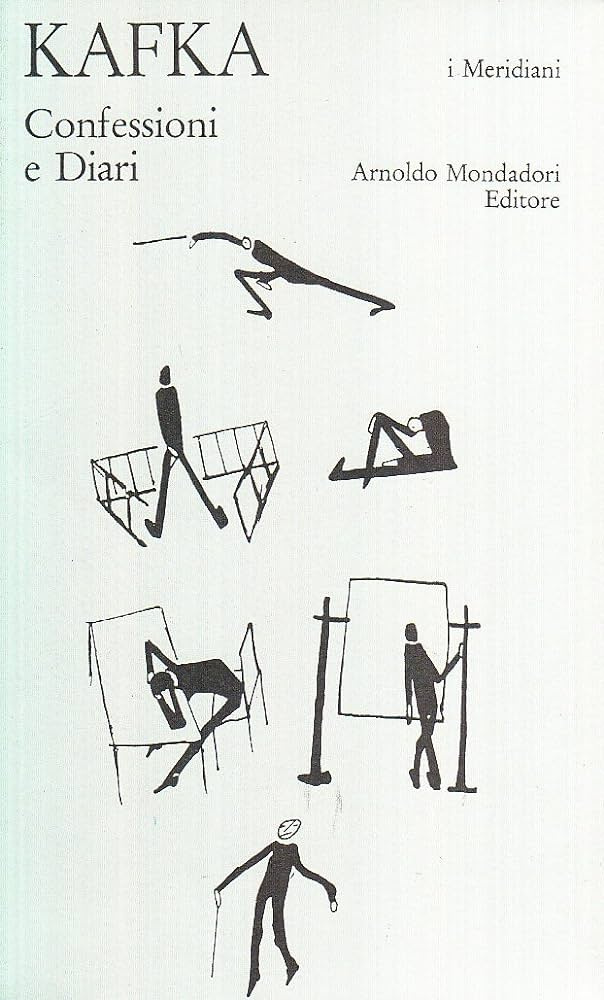
In una lettera dello stesso 1922 – anno in cui è posto in “pensionamento temporaneo” per l’aggravamento della tubercolosi – Kafka si definisce “povero, piccolo uomo posseduto da tutti i possibili spiriti maligni di ogni specie...”, ovvero dichiara di avere trascorso una esistenza più da pensato che da pensante. In effetti non dice il vero, perché da subito era stato consapevole e aveva descritto questa condizione, ed era stata proprio la cura (allopatica e omeopatica al tempo stesso) di quella possessione per mezzo della scrittura, il mondo parallelo dell’arte, in termini artistici a procurargli debolezza e malattie. Prima di allora e segnatamente in Contemplazione (1908), Kafka, proprio come il giovane Antonin Artaud, cercava un editore rivendicando di non saper fare altro, di non sapere bene cosa e come scrivere, insomma di non avere granché da esprimere se non il proprio disagio esistenziale (“la mia presente infelicità è tutta fatta di confusione”, Diari, marzo 1911), e lo faceva con una scrittura dalla costruzione incerta, con frasi sconnesse, descrizioni molto dettagliate, abbondanza di effetti, andatura lenta e caratterizzazioni prevedibilmente vicine alla propria psicologia; mentre a partire dall’incontro con gli spiantati e splendidi artisti yiddish la sua scrittura si fa letteralmente drammatica, ossia privilegia la figurazione delle azioni e dei loro effetti (senza sdegnare di ricorrere anche al monologo interiore), la costruzione del testo si fa più salda, lo stile diretto, il focus ristretto, i personaggi sono ora ben definiti e hanno una vita propria, i gesti e le sequenze sono tracciati con forza, vengono introdotti elementi di forte suspense, si crea un climax che poi viene implacabilmente smantellato. Il suo stile vira verso il visuale e l’istrionico proprio come su quella scena, che sollecita il lettore a inferire la situazione interiore dalle azioni e interazioni, laddove sono le azioni a suscitare i sentimenti e non viceversa.
Questa svolta è sincrona alla scoperta della propria appartenenza e insieme estraneità all’ebraismo. Un passaggio cruciale, dopo l’incontro con gli attori yiddish e l’innamoramento senza sbocco per l’attrice Mania Tschissik (ottobre 1911), è l’irruzione nella sua vita di Felice Bauer (agosto 1912), fervente sionista berlinese. Elias Canetti si sofferma su quel momento di svolta e, pur senza dare la dovuta importanza allo sconvolgimento derivante dalla “scoperta del teatro”, osserva come la nuova alacre attività dello scrittore abbia un carattere contraddittorio, o meglio, mentre comincia a scrivere in modo molto diverso – è la volta di La condanna, del Fuochista e altri capitoli di America e soprattutto, in quindici giorni febbrili, di La metamorfosi – fa pubblicare in volume Contemplazione, la sua prima raccolta di prose, e la invia a Felice. La donna reagisce al proprio imbarazzo con un lungo silenzio. Kafka, fidanzato esigente e piuttosto invadente (in forma epistolare), si dichiara irritato e deluso dal mancato riscontro della donna: “A te non piace il mio libro”, la rimprovera, e il loro legame comincia a mutare di segno, la sua delusione si trasforma pian piano nella consapevolezza di non amarla e il pensiero del matrimonio lo atterrisce: “Il mio tenore di vita è organizzato soltanto in vista dello scrivere [...] l’amore ha bisogno di peso, ha a che fare con i corpi”.
Canetti definisce “splendido” quell’ascesso di iperattività, molto creativo e un po’ folle. Ciò non significa che da allora in poi i racconti di Kafka siano esplicitamente teatrali, ma che sviluppano un linguaggio ormai radicato nell’arte drammatica (yiddish). Tutto ciò, come dice Evelyn Beck, “crea l’illusione che il dramma avvenga in un eterno presente”.
L’incontro con la scena yiddish gli ha fatto comprendere una cosa che ancora oggi sfugge a molti, ovvero, come si è detto, che l’arte drammatica è poesia collettiva e, da autore esclusivo e solitario qual è, si pone la questione di una molteplicità dei punti di vista e di come la scena yiddish faccia del racconto un monologo a più voci e un coro di monologhi.
Il “paradiso di quei tre mesi” (Canetti) che cambiano il corso della sua vita è costellato di diversi episodi, tutti decisivi. Se il teatro yiddish suggerisce allo scrittore un particolare tipo di grottesco (frutto a sua volta dell’intreccio di diverse componenti soprattutto di matrice chassidica e del contestuale contra punctum costituito dall’incontro con la modernità cosmopolita che spinge gli attori yiddish a oltrepassare le proprie tradizioni), a ciò si aggiungono il particolare travestimento metaforico della realtà, utile per scandagliarne la complessità e contemplare i nuovi motivi del tempo, e l’insieme poetico-attorale di parola, canto, danza, insomma di una poiesis in senso pieno o appunto di un’anima musicale (anche) della scrittura. Per quanto riguarda i contenuti, invece, la scena yiddish dimostrava all’autore come i temi più osceni della vita privata e intima possano essere metaforicamente trasfigurati, diventando enigmi esistenziali da non ridurre al senso comune con la pretesa di comprenderli definitivamente. Sono i temi di cui trattano opere come La condanna, Il processo, La metamorfosi, La colonia penale ecc.
Gli attori più di tutti gli altri artisti rappresentavano per Kafka una umanità preistorica. Senza saperlo, ovviamente. Assomigliando agli altri esseri umani, essi credono di fare un lavoro magari un po’ strano, ma niente di più. E quando ragiona sulla loro natura e funzione sociale, Kafka sottolinea la loro differenza e peculiarità consistente nel non essere produttori, nel senso che non si procurano il cibo di cui pure hanno bisogno. Nella “preistoria storica” non era così, tutti erano al tempo stesso attori, procacciatori di cibo e produttori. Kafka è tra i pochi autori che hanno compreso e riflettuto su questa realtà senza cedere a frettolose e semplicistiche conclusioni, tra l’altro con questo lungo racconto senza finale possibile.
Indagini di un cane è stato definito giustamente un apologo, anzitutto con riferimento ai protagonisti animali, tuttavia alcune puntualizzazioni in questo senso sono necessarie. In Kafka è completamente assente la vocazione pedagogica e si privilegiano esplorazioni filosofiche e resoconti che pro-vocano il lettore a compiere un lavoro analogo nel proprio mondo e su di sé (lui lo chiama neue Selbstbeobachtung, “nuova osservazione di sé”). Niente di favolistico, nessun catechismo morale o codici etici, piuttosto fiabe, racconti di iniziazioni, di viaggi tra stati di coscienza: una neodrammatica che trascende lo stesso l’orizzonte ideologico del teatro yiddish e in generale del teatro moderno. Come s’è detto, i pochi autori che hanno colto la metafora teatrale del racconto non si sono soffermati sul suo significato e ancora meno sull’effetto che quel teatro ha prodotto sull’autore, per non dire dell’effetto che si propone di avere anche sul lettore, vale a dire che quel Tutto era musica non è la semplice o raffinata definizione di un’arte dinamica, o della dinamicità di ogni arte, bensì l’esortazione a dare forma, ognuno nel proprio branco, a un’arte di vivere conseguente, o almeno a un mettersi in cammino nel tutto è musica.
Il palinsesto di ogni racconto kafkiano è ispirato all’eterna preistoria sempre soggiacente alla storia, preistoria che “esercita un dominio tanto più illimitato” (Canetti) se non diventa oggetto di rielaborazione simbolica e metaforica da parte dei singoli individui e delle comunità. Metafora e lettera sembrano coincidere in lui. Walter Benjamin sostiene che “Kafka viveva tutto come simbolo” e lo definisce Sinnbilder, costruttore di simboli (non di allegorie). Nelle Indagini di un cane si ragiona soprattutto su ciò che gli esseri umani di oggi hanno dimenticato del loro passato e del loro potenziale. Una volta i cani, tutti, andavano a caccia per procurarsi il cibo, e cantavano, mentre “i nostri avi”, ovvero gli avi degli attori, deviarono verso un’altra forma di vita, forse credendo che avrebbero potuto un giorno tornare indietro: “non sapevano [...] che l’anima si muta prima della vita”. Una volta il cibo era associato all’arte, ora non più.
Di questa preistoria, che esercita sui contemporanei un dominio tanto più illimitato quanto più è ignorata, secondo leggi non conosciute e non scritte, fanno parte appunto gli animali, “depositari del dimenticato” secondo Benjamin. Nella produzione kafkiana gli animali appaiono sempre in riferimento alla primarietà di un corpo che diventa letteralmente mostruoso nel suo disadattamento alle forme attuali della socialità e della cultura. Gli attori sono qui rappresentati come animali per rendere percepibile il senso dell’effetto che producono sugli spettatori quando emergendo dalle tenebre “producendo un rumore così terrificante come non avevo mai udito”, fragore che accompagna una rivelazione senza parole. Se il branco di cani è il corrispondente metaforico di una compagnia teatrale, la compagnia lo è del genere umano (in questo tempo, in questa storia). È come se lo scrittore sentisse il bisogno di ripartire da una interpretazione riduttiva e provocatoria per delineare il carattere della condizione contemporanea, un oggi in cui l’arte è un’attività dissociata dalla produzione di cibo, dalla sopravvivenza. I cani non producono cibo. Gli altri animali non producono cibo ma se lo procurano, mentre i cani, vivendo in mezzo agli umani, ne dipendono. Gli artisti sono dunque al tempo stesso nostri “antenati” e un qualcosa di eccentrico, sono lontani dalla scienza, che ne diffida, però trattano questioni ignorate dalla scienza come il senso della vita, il dolore, la solitudine, il godimento e la morte.
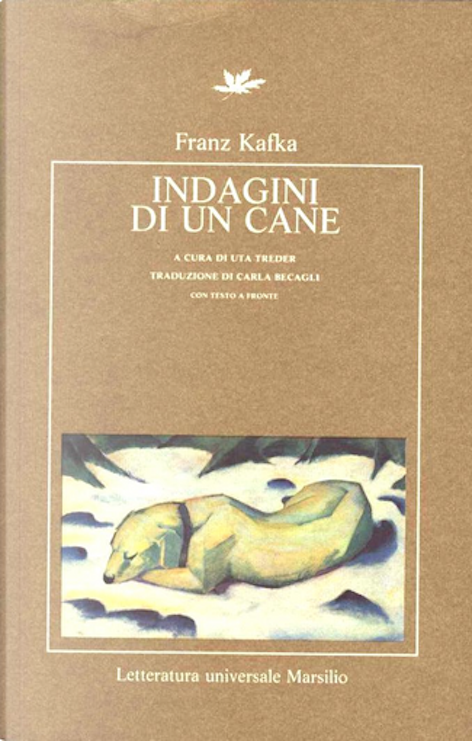
Ancora prima delle pitture rupestri e dei graffiti veniva la musica, l’arte più antica e più astratta, fatta con pietre, legni, mani che suonavano il corpo. Ora la musica non ha più una utilità pratica, non rende fertile la terra, non protegge dal freddo, non guarisce né indica la via di fuga in caso di pericolo, nemmeno è utile come le pitture rupestri per propiziare la caccia o come l’urina dei cani di una volta, nel racconto evocata come un prezioso fertilizzante. Gli animali sono segni del passato e, se interrogati, non parlano, producono strani suoni, o si mettono a fischiare, come accade al popolo dei topi in Giuseppina la cantante (1924). Il teatro fa fischiare le immagini e i concetti, li mette in voce e li ordina secondo un ritmo: produce musica.
Noi, oggi, possiamo provare a rispondere creativamente alla esortazione kafkiana ripartendo dal primo grado delle sue metafore, ad esempio accettando che quella di Indagini di un cane sia una compagnia teatrale, che il popolo dei topi di Giuseppina la cantante sia in prima istanza il popolo ebraico e il Digiunatore l’artista di professione. È senz’altro significativo che Indagini di un cane e Un digiunatore siano stati scritti nello stesso momento, dopo aver definitivamente lasciato il lavoro impiegatizio, e siano entrambi metafore del professionismo artistico. Però Indagini è un racconto incompiuto e destinato alla distruzione, mentre Un digiunatore è stato pubblicato, evidentemente intendendolo come estremo responso possibile sulla questione. Partendo da queste constatazioni si può meditare con profitto sul perché e sulla funzione di queste metafore, ovvero sul rapporto dell’artista con le necessità materiali o sul ruolo delle fischiatrici e dei fischiatori come profeti e autori delle nuove Scritture e persino sugli ideali che muovono o narcotizzano i popoli.
Il mondo degli animali di Kafka è un album di vecchie fotografie nel quale, alle volte, basta riconoscere un volto per potere dare una identità anche a tutti gli altri. Le immagini, interrogate, si metteranno a fischiare. Ma noi, popolo dei lettori di Kafka, sappiamo leggere e guardare? E riusciremo poi a fischiare? In ogni caso nella nostra indagine si dovranno tenere distinte la compagnia teatrale e la specie canina in generale, perché questa è la Storia. Per uscire dall’“infelicità tutta fatta di confusione” il lettore o lo spettatore devono comprendere la non secondarietà del campo di forze artistico e porsi la questione del suo innesto nel (proprio) orizzonte attuale. Mentre nel racconto è il canto del Cacciatore a convincere il protagonista a estendere le indagini alla “musica dei cani”, qui il lettore-spettatore è chiamato a compiere un’acrobazia filosofica in quanto deve ricavare da un mare di parole e di suoni l’indice sommario della propria ricerca e poi intraprendere un’azione sensata dentro e contro le convenzioni letali in cui è immerso.
Si tratta di capire cose non facili. Ad esempio, i cani artisti sono nudi e con i genitali bene in vista. Ciò significa che la nudità teatrale è un’altra cosa, ben più intima ed effettivamente oscena, che il fuori scena della vita è il vero campo di forze dove tutto avviene e si decide. I cani musicanti si distinguono dai loro simili soprattutto perché stanno in posizione eretta. Secondo Elias Canetti questo è il segno di un ambiguo tentativo di emancipazione perché “la posizione eretta rappresenta il potere dell’uomo sugli animali, ma proprio in questa chiara posizione di potere egli è più esposto, più visibile, più attaccabile. Giacché questo potere è anche la sua colpa”. Comunque bisogna farsi una ragione della fatale differenza tra il canto del Cacciatore, accompagnamento funzionale al suo dare la morte per necessità, e il canto dei sette cani musicanti, che ad esempio permette a un cane in agonia di danzare e prendere il volo “spinto dalla melodia, con balzi stupendi”. E non dimenticare mai che essendo ogni arte drammatica collettiva, quale che sia la sua forma, ciò che ne risulta non è propriamente uno spettacolo ma un “concerto”.
Nella vita di Kafka la traiettoria di questa meditazione trasformante ha un momento iniziale e uno finale. All’inizio, nelle Indagini, c’è un adulto che racconta di quando era cucciolo e assisteva allo spettacolo di sette cani che sbucavano “alla luce da qualche punto oscuro – come evocati da me” e intonavano un “canto assordante eppure fatto più di silenzio che di voce [...] qualcosa che non avevo ancora mai udito”. Il cucciolo aveva capito che nonostante la loro apparente irrilevanza sociale aveva a che fare con sette grandi artisti, instancabili nell’esibire la propria mostruosità o anomalia: erano sempre nudi ma non era la nudità che mostravano, quando cantavano e danzavano alzandosi sulle zampe posteriori e non rispondendo quando erano interrogati. Il manoscritto però s’interrompe, la decisione di indagare sulla “musica dei cani” resta sospesa e un vero finale sembra impossibile, come nei Giganti della montagna di Pirandello: lì per sopravvenuta morte, qui per sopravvenuta vita. Una vita comunque senza redenzione. Come in tutti gli altri racconti, anche qui il presupposto iniziale, ovvero la speranza di una metamorfosi positiva si rivela infondata: “Se tu non ti metti per terra in mezzo agli animali, non puoi neanche vedere il cielo con le stelle, e non potresti neanche essere redenta. Bisogna mettersi a terra, in mezzo agli animali, per essere redenti” scriveva Franz a Felice. Dunque finale del racconto impossibile e manoscritto condannato alla distruzione. Eppure nella propria vita Kafka quel finale l’ha trovato, anche se è un finale senza fine. Compiuto il moto di rivoluzione, l’artista canino trova il proprio inizio rinascendo come uomo-scrittura. Ma la fiaba con un epilogo, anche se non propriamente un finale, è il citato Un digiunatore (1922-1924), il cui protagonista non è un attore ma un artista, polo opposto del Cacciatore. Il Digiunatore, per capire se l’arte permette di vivere o fa morire, si rinchiude in una gabbia e digiuna offrendosi in spettacolo. Saranno gli spettatori a decidere il suo destino.
È impossibile dialogare con Kafka pretendendo di risolvere contraddizioni come quelle appena delineate. È proprio la mancanza di soluzioni e di punti d’arrivo a determinare un campo quantico nel quale l’interlocutore dell’artista trova la capacità di guardarsi allo specchio, ovviamente rischiando di ferirsi o persino di soccombere. La conclusione del filosofo Benjamin è questa: “Così si può capire perché Kafka cercasse continuamente di captare dagli animali la presenza del dimenticato. Essi non sono la meta, ma sono indispensabili per arrivarci”. E quella dell’uomo di teatro Mejerchol’d: “Il nuovo teatro, dunque, nascerà dall’interrelazione tra natura e corpo umano, vale a dire dalla fusione tra l’uomo e la parte animale che è in lui”.
Libri citati:
Elias Canetti, L’altro processo. Le lettere di Kafka a Felice, in Id., La coscienza delle parole, Adelphi, Milano 1984.
Evelyn Torton Beck, Kafka and the Yiddish Theater: Its Impact on his Work, University of Wisconsin Press, Madison WI 1971.
Guido Massino, Fuoco inestinguibile – Franz Kafka, Jizchak Löwy e il teatro yiddish polacco, Bulzoni, Roma 2002.
Gilles Deleuze e Félix Guattari, Kafka, Per una letteratura minore, Feltrinelli, Milano 1975.
Franz Kafka, La comunità degli operai nullatenenti, in Reiner Stach, Questo è Kafka?, Adelphi, Milano 2016.
Walter Benjamin, Franz Kafka. Per il decimo anniversario della morte, in Id., Angelus Novus, Einaudi, Torino 1962.
Leggi anche
Marco Belpoliti, Kafka e la vergogna
Guido Monti, Una carezza alla nuca di Kafka
Giuseppe Di Napoli, Kafka, scarabocchi e disegni
Andrea Pomella, Kafka. La vita è qualcosa di più di un gioco di pazienza
Francesco M. Cataluccio, Kafka. Un tram chiamato lampione
Alessandro Banda, Kafka: una volta, sai, ero un gran disegnatore...
Paola Albarella, Tutto “Il processo” a Berlino
Gabriele Gimmelli, Il gabinetto delle meraviglie del dottor K.
Andrea Giardina, Gli animali di Kafka
Marino Freschi, Franz Kafka: assalto al limite
Giuseppe Lupo | Come leggere Kafka
Alessandro Banda | Franz Kafka, La tana







