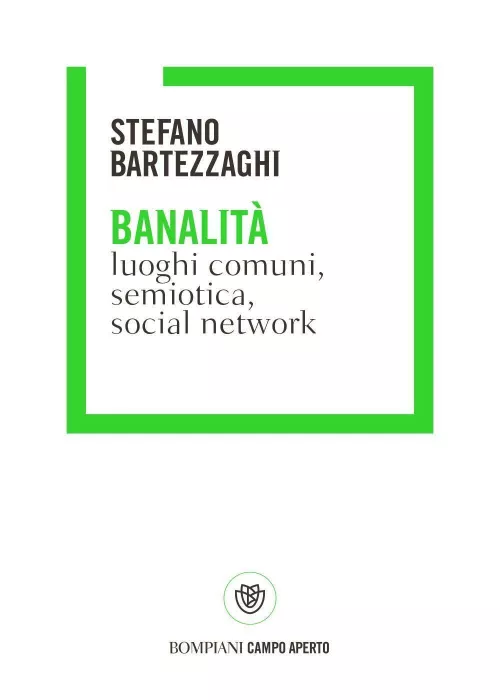Zerubavel e Bartezzaghi / La forza della banalità: normalità e altri contropoteri
“A cosa pensi?”. “A niente”. “Cos’è questo niente?”. “Proprio niente”. “Cioè?”. Dialogo ricorrente tra timidi adolescenti o entro coppie consumate e annoiate? Sì, certo. Il che non toglie che si tratti di qualcosa di estremo interesse. A ben pensarci infatti: a cosa pensiamo quando non pensiamo a nulla? Che cosa passa, sempre e comunque, per la nostra mente tenuta a risposo, quando tutto sembra essersi fermato, e gli apparati cerebrali funzionano, per così dire, da soli, senza intenzioni proprie o stimoli esterni, ma comunque a loro modo ancora in azione e, forse, in agitazione? Come acchiappare e definire questo ‘nulla’ a cui pure in qualche modo stiamo pensando? Ecco un fenomeno che potremmo ascrivere a quella che si usa chiamare normalità, banalità, ovvietà: il va-da-sé, il dato-per-scontato. Fenomeno tutt’altro che banale e ovvio, tutt’altro che evidente, se si prende ad analizzarlo con serietà e curiosità, con rigore metodologico e un necessario tocco di ironica pignoleria.
La mente è a riposo, o almeno così crediamo. Eppure lei va lo stesso, non sappiamo se rallentata o semplicemente sciolta, lasciata libera di percorrere i meandri cognitivi, affettivi, valoriali di ciò che, per comodità, ci ostiniamo a chiamare l’impensato. Sembra qualcosa di orientale, come il suono d’una sola mano dei maestri zen, o il sentir crescere gli alberi dei maestri di haiku. In Marocco, dove lo sguardo occidentale si continua a stupire nel vedere per strada o nelle piazze migliaia di persone che stanno ferme, senza far nulla, senza pensare a nulla, lo chiamano più o meno così: sentire il suono delle proprie ossa. Che è un dono, una capacità culturale da acquisire nel tempo e da padroneggiare con cura. Una pigrizia costruita, e orgogliosamente rivendicata, non senza aver prima dimenticato il lavoro necessario per produrla. Riuscire a non far nulla è molto complesso, laborioso, stancante: non foss’altro perché tutti ci chiedono sempre di far qualcosa, di non stare con le mani in mano (bella espressione), di sbandierare la nostra prestazione quotidiana, di rispondere alla domanda sociale di azione continua e di passione intensa. Lo sapeva bene Oblomov, eroe eponimo di un’accidia dolce diventata virtù intelligente.
Il dato-per-scontato può essere allora oggetto di scienza sociale, di analisi culturale, di indagine fors’anche politica, come accade nel bel libro del noto sociologo americano Eviatar Zerubavel Dato per scontato. La costruzione sociale dell’ovvietà, appena tradotto in italiano dalla casa editrice Meltemi (introduzione di Lorenzo Sabetta, pp. 159, €16). Nella sua analisi Zerubavel parte da una osservazione linguistica: molto spesso nelle lingue si costituiscono forme di opposizione pertinente fra un elemento dotato di una certa proprietà (marcato) e un altro che non la possiede (non marcato); così se in inglese e francese il plurale dei nomi si riconosce per la presenza della lettera esse a fine parola, il singolare si riconosce anch’esso, in negativo, per l’assenza di tale fonema. Nelle lingue, e in moltissimi altri sistemi sociali (dall’abbigliamento alla politica, dall’architettura alla cucina), la mancanza è altrettanto significativa della presenza: solo che non ci si fa caso, la si dà per scontata. Come percepire una cosa che non c’è? Semplice: opponendola a un’altra cosa che invece c’è. È l’opposizione che fa significato, non i due elementi a sé. Di modo che, ne conclude Zerubavel, il potere viene garantito proprio da questo dare per scontate tante cose che, se messe in evidenza, ovvie non sono per nulla.

Per dimostrarlo, basta osservare la patente dissimmetria fra una serie di espressioni apparentemente opposte e complementari. Così, perché si dice sempre che Obama è nero con madre bianca, e non che è un bianco con padre nero? perché si parla di calcio femminile e mai di calcio maschile? perché si può dire ‘donna in carriera’ ma non ‘uomo in carriera’? Esistono i menu vegetariani ma non quelli per onnivori. Si indicano locali gay-friendly ma non etero-friendly. Insomma, il non marcato costituisce quella supposta normalità che, proprio perché non avvertita, finisce per essere serenamente accettata da tutti, diventando l’Ordine Naturale delle Cose. Il primo presidente afroamericano della storia ce lo ricordiamo tutti. Il primo presidente olandese non se lo fila nessuno: e vince sempre. Ecco il potere straordinario dell’ordinario (sottotitolo originale del libro di Zerubavel), ecco l’infra-ordinario di Georges Perec portato a vessillo di un modo diverso di ragionare e di desiderare, di volere e di sapere. Diversità che si istituisce per straniamento, come sapevano Viktor Sklovskij e Bertolt Brecht, ma anche Lewis Carroll, che faceva festeggiare ai suoi personaggi al di là dello specchio un continuo non-compleanno semplicemente variando i posti a tavola nell’ora del tè. E la lingua, ancora una vota, è la potente spia di tutto questo: dice e non dice, non a suo piacimento, ma semmai presupponendo – ossia costituendo – ciò che è normale e ciò che non lo è, ciò che vige silente e imperioso rispetto a quel qualcos’altro che, sottolineato ogni volta, sa tanto di cornuto contento.
La domanda allora potrebbe spostarsi un poco e diventare: che cosa diciamo quando non diciamo nulla? di che cosa parliamo quando formuliamo, senza saperlo, sequenze imbarazzanti di formidabili luoghi comuni – di espressioni linguistiche senza apparente interesse? In altre parole, cosa accade quando passiamo dalla sociologia alla semiotica, dalle politiche sociali alla comunicazione quotidiana e no? Dal problema – enorme – della normalità transitiamo così a quello – non meno complesso – della banalità e delle sue forme semio-linguistiche, a cui è dedicato il nuovo libro di Stefano Bartezzaghi Banalità. Luoghi comuni, semiotica, social network (Bompiani, pp. 268, € 17). Appare significativo, anche rispetto al discorso di Zerubavel, che in una congiuntura culturale qual è la nostra, permeata dal mito dell’originalità come valore assoluto, il semiologo-enigmista prenda una posizione molto chiara: con la banalità occorre fare i conti, e piuttosto che rifiutarla in blocco, è meglio saperla gestire, avere con essa un rapporto il più possibile positivo. I social network, del resto, sono un ottimo terreno per esercitarsi in questo senso, luoghi virtuali e realissimi dove di banalità ce n’è a frotte, ma dove, contemporaneamente, non si fa che innalzare la bandiera dell’originalità.
Da che cosa deriva questa confusione? Il fatto è che, storicamente, quanto meno dall’Illuminismo in poi e per tutta la modernità, il valore della originalità è e resta l’indiscusso punto di riferimento nella cultura dominante, presupposto necessario per le arti, le scienze, i saperi. A un certo punto però, fra i Settanta e gli Ottanta del Novecento, questo principio entra in crisi. La ricerca dell’originalità diventa banale, sostiene per esempio Roland Barthes: meglio ripiegare sulle proprie banalità quotidiane (l’amore, il lutto…). E non è un caso che giusto alla Biennale di Venezia del 1980 il compianto Alessandro Mendini propone una mostra di design intitolata “L’oggetto banale”, mentre lì accanto, nella Strada Novissima, Achille Bonito Oliva prospetta, con la Transavanguardia, un ritorno alla figurazione. In quello stesso anno esce Il nome della rosa di Umberto Eco, che dopo gli anni algidi del Gruppo ’63 inaugura la stagione letteraria del ritorno all’intreccio. E il libro sul postmoderno di Jean-François Lyotard è del ’79: come dire, tutto si tiene. Chiudere con la modernità significa dire addio all’originalità a tutti i costi: che non vuol dire, come si disse allora, cedere al riflusso e al privato, ma, appunto, reintrodurre una soggettività a trecentosessanta gradi, dove anche i sentimenti, spesso banali, giocano un ruolo di primo piano. L’ovvietà della passione amorosa non deve implicare la sua censura, osserva Barthes; è il caso semmai di farne una sociologia, rimbecca Alberoni giusto in quegli anni. E dell’‘80 – per chiuderla lì – è il grande libro di Michel De Certeau sull’Invenzione del quotidiano, dove la vita comune di tutti i giorni diviene specifico oggetto di ricerca delle scienze sociali.
Dismessa l’originalità dalle pratiche culturali e artistiche, non significa però che essa venga meno. Ha soltanto cambiato residenza, e si è trasferita nei media, vecchi e nuovi, i quali non fanno che rilanciarla a ogni piè sospinto. L’eroe mediatico per un giorno deve essere il più stravagante possibile, il più lontano dalla normalità quotidiana, sia esso il cantante di X-Factor o l’ospite fisso al talk show, come anche la platea di Facebook, dove ognuno si sente in diritto, e forse pure in dovere, di dichiarare urbi et orbi le proprie banalissime intimità quotidiane, rivendicandone però l’originalità. “Nessuno è come me”, che significa: “io sono come tutti”.
Bartezzaghi decide allora di prendere di petto la questione e provare a sbrogliare il bandolo della matassa, servendosi degli strumenti della linguistica di Saussure e di Benveniste, della semiotica di Eco e di Greimas. Prendiamo il caso dei luoghi comuni, bestia nera di Flaubert, Twain, Bloy, Flaiano e tanti altri. Siamo certi che non vadano mai bene? che siamo solo portatori di stupide banalità? Un modo per esorcizzarli è proporne una collezione, metterli in fila in un dizionario, come questi autori hanno fatto. Bartezzaghi ne propone piuttosto un’enciclopedia, genere testuale ben più ampio del dizionario, che finisce per comprendere l’intera cultura. Viene così fuori una convinzione essenziale: il luogo comune non sta in quel che si dice ma in chi, ascoltandolo, lo considera tale. Il luogo comune è il giudizio (negativo) che si dà a un enunciato. Senza questo giudizio, niente banalità.
Ma viene fuori anche un’altra cosa: parlare per luoghi comuni è un ottimo modo per socializzare, per instaurare un qualche rapporto di comunicazione, come nei classici primi cinque minuti in cui, incontrando una persona, non si sa mai cosa dirle, e si finisce per parlare del tempo che fa. La categoria dei portieri degli edifici esiste per questo: non per ritirare le buste della spesa alle signore o i pacchi di Amazon, ma per spettegolare sugli inquilini e, con ciò, farli sentire facenti parte della comunità, istituendo il condominio come entità sociale e semiotica. È la comunicazione detta fàtica, quella che serve a istituire, o a mantenere relazioni, senza per questo trasmettere per forza messaggi interessanti. Una proposta potrebbe essere quella di attaccare bottone con una insulsaggine del tipo: “Non bisogna parlare per luoghi comuni”. E aspettare che l’altro risponda a tono. Pensando senza pensare.