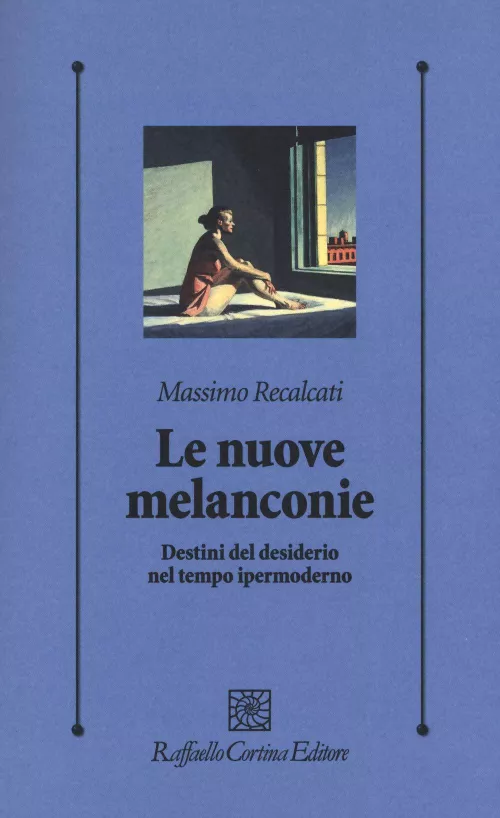Muri e solitudine / Massimo Recalcati. Le nuove melanconie
L’ultimo libro di Massimo Recalcati, Le nuove melanconie, si apre con un esergo tratto dal Vangelo di Giovanni, lo stesso esergo che Giacomo Leopardi scelse come ingresso a La ginestra: “e gli uomini vollero le tenebre piuttosto che la luce”. Il godimento senza limite, cifra del capitalismo, ha assunto oggi un nuovo volto, complementare al primo, diventando godimento della chiusura: dall’iperattività all’autoreclusione. Così i confini – porosi, aperti, essenziali perché si produca relazione – sono diventati muri. L’esito di questo essere-per-le-tenebre sarebbero dunque i disturbi melanconici sul piano della sofferenza individuale – l’esistenza come peso da trascinare, l’assenza del sentimento della vita, il culto del denaro e del possesso –, e la difesa a oltranza dei propri confini identitari sul piano del vivere sociale – una nuova pulsione securitaria che separa gli uni e gli altri.
L’espansione maniacale capitalistica, scrive Recalcati, ha lasciato attorno a sé solo un mucchio di ceneri, e quello cui assistiamo è una nuova deriva melanconica. Il rapporto solipsistico con l’oggetto ha prodotto una chiusura autoconservativa del soggetto su se stesso, spezzando ulteriormente ogni legame sociale: “l’esigenza della protezione si confonde con una condizione di asservimento”. La vita rinuncia alla vita in cambio della sua difesa.
Il discorso fascista trae la sua forza da questo desiderio consustanziale alla vita umana di difendersi dalle perturbazioni del mondo esterno. L’identità è minacciata dallo straniero e i porti devono essere chiusi per evitare ogni contaminazione: rinunciare al gioco della vita per evitare la quota di rischio che ogni gioco implica, la perdita di padronanza che l’assunzione del proprio desiderio chiede.
Per comprendere il passaggio al cuore di questo libro è necessario pensarlo come il terzo movimento di una trilogia che interroga le trasformazioni contemporanee della psicopatologia in rapporto al discorso sociale.
Recalcati accoglie dunque l’insegnamento di Freud: al centro è il rapporto che intercorre tra sofferenza individuale e collettiva.
Freud in Il disagio della civiltà aveva messo in luce come l’ingresso del singolo nel discorso sociale implicasse la rinuncia a una quota di soddisfazione pulsionale. Nel tempo di Freud l’imperativo su cui si reggeva il legame sociale era caratterizzato da un divieto: al cuore – esito del conflitto tra desiderio e Legge – la rimozione, e dunque un desiderio inconscio censurato e costretto a tornare, cifrato, in sogni, atti mancati, lapsus, sintomi nevrotici.
Il passaggio dal contesto in cui Freud elabora le sue riflessioni a quello in cui domina “il discorso del capitalista”, come lo ha definito Lacan, è passaggio che ha sostituito tale divieto con quel nuovo imperativo che caratterizza la nostra epoca: Godi! Non più dunque la castrazione, la necessità di perdere qualcosa del godimento individuale come condizione di possibilità di un vivere collettivo, quanto piuttosto l’enfatizzazione del godimento nella vita individuale e comune.
In La clinica del vuoto e successivamente in L’uomo senza inconscio Massimo Recalcati aveva messo in luce come la caduta delle grandi ideologie avesse portato in primo piano una spinta compulsiva al consumo, una euforia maniacale, una rincorsa verso gli oggetti nel tentativo – impossibile – di saturare una mancanza diventata vuoto. In questi primi due momenti della sua riflessione aveva evidenziato un passaggio fondamentale: se la mancanza strutturale dell’essere umano è ciò che rende necessaria la relazione con gli altri, se dalla perdita originaria dell’unità con il materno segue un’articolazione che evidenzia il rapporto ineliminabile del soggetto con l’Altro, il discorso del capitalista sarebbe responsabile di una trasformazione di tale mancanza simbolica in un vuoto concreto, vuoto che lungi dal farsi motore di una relazione e di un desiderio verso l’Altro, chiederebbe banalmente di essere colmato. Nell’attualità iper-moderna l’esperienza umana della mancanza, matrice del dinamismo del desiderio e della sua funzione di apertura, si trasforma in esperienza del vuoto, esperienza di annullamento, pietrificazione e congelamento del desiderio.

Il passaggio dall’imperativo del “Devi!” all’imperativo del “Godi!” avrebbe avuto dunque un primo essenziale effetto sui legami: all’incontro con l’Altro – aperto, sfidante, inquieto, mai certo –, che sorgerebbe dalla mancanza, si sarebbe sostituita la spinta verso l’oggetto – cibo, sostanza, denaro – effetto di un vuoto da saturare. Tutto questo avrebbe avuto come esito da un lato una frammentazione del legame sociale, una nuova solitudine, dall’altro un rapporto solipsistico con gli oggetti. L’oggetto è controllato e controllabile, la dipendenza strutturale si risolverebbe per una via breve che schiaccia la mancanza su un vuoto concreto e illusoriamente colmabile; l’oggetto si è fatto tappo.
Il senza limite del desiderio – encore – ha preso la forma dell’accumulazione mai risolta, e l’ennesimo oggetto non sarà mai l’ultimo di una catena, seguirà sempre qualcosa di ulteriore.
L’oggetto feticcio, dunque, trionfa, e in questa saturazione diviene impossibile lo spazio del pensiero e del desiderio che necessitano invece, per aprirsi, di uno sfondo di mancanza. La mancanza viene confusa con la privazione e, in questa la lettura perversa della castrazione, del limite, l’inconsistenza dell’Altro non è vista come spazio di apertura simbolica per una possibilità di giocare la partita del proprio desiderio non sottomesso ad attese, ma un’incompletezza concreta che deve essere colmata per poter ricomporre la totalità, l’unità perduta di cui non si riesce a elaborare il lutto. Il soggetto aderisce all’oggetto che si fa presenza sempre presente. Negare l’assenza è un modo di negare l’esperienza dolorosa che accompagna, necessariamente, la vita: l’abbandono, la solitudine, la malattia, la morte, il fondo di non-senso insopportabile dell’esistenza.
Quale l’effetto sulla sofferenza individuale? Il sintomo non esprimerebbe più, in questo nuovo orizzonte, il conflitto tra quel che il soggetto vuole e ciò che la società impone, come voleva Freud, ma avrebbe preso la forma di una pratica solitaria che il singolo intrattiene con l’oggetto. La dipendenza simbolica che lega l’essere umano all’Altro – l’altro che lo mette al mondo, l’altro sociale, l’altro senza cui non c’è vita umanizzata – viene sostituita con una dipendenza concreta da un oggetto di consumo. La crisi della vita collettiva produce un sentimento diffuso di angoscia che a livello individuale prende le ben note forme del panico, della compulsione maniacale al fare (delirio di prestazione) e della conseguente depressione per la propria insufficienza. L’esito collettivo non può che essere l’atomizzazione narcisistica: il discorso sociale non pone limiti al godimento pulsionale dell’individuo – la quota di castrazione messa in luce da Freud – ma anzi non smette di alimentarlo: il mondo “ridotto a una immensa fabbrica di merci”, come scrive Elena Pulcini, e una soggettività “animata da una vocazione all’espansione illimitata delle proprie pretese che la rende cieca ai desideri e alle esigenze dell’altro da sé”.
Se il grande passo di Freud era stato quello di mostrare che il soggetto dell’inconscio era l’artefice di quelle manifestazioni della realtà umana che sfuggivano al dominio intenzionale della coscienza e che avevano il potere di imprimere alla sofferenza sintomatica il carattere metaforico di un messaggio cifrato, di un discorso singolare eccentrico che chiedeva di essere ascoltato, l’attualità della clinica si confronta sempre più con forme di sofferenza che sembrano aver interrotto ogni contatto con l’inconscio. Le nuove forme sintomatiche insegnano che in esse non è più in gioco il desiderio del soggetto che preme per trovare una sua strada, ma il suo annullamento nichilistico. Questo annullamento tende a manifestarsi secondo due direttrici fondamentali: come rafforzamento narcisistico dell’Io che dà luogo a identificazioni solide che irrigidiscono sterilmente l’identità individuale per rispondere a ideali di prestazione, o come un’esigenza senza limite di godimento che travalica ogni principio di mediazione simbolica per imporsi come un comandamento tanto assoluto quanto mortifero. Se la messa in crisi della Legge era un momento essenziale per liberare il soggetto dall’imperativo al dovere, la modalità con cui si è giocato questo passaggio, la dissoluzione degli argini, ha lasciato il soggetto senza riparo, prigioniero di una rincorsa a un soddisfacimento mai capace di essere pacificato e solo davanti all’angoscia della totale libertà.
La mania e la melanconia potrebbero allora essere viste come due facce della stessa medaglia. Il soggetto oscillerebbe dal primo paradigma a questo nuovo paradigma: dalla spinta compulsiva al consumo, all’inclinazione melanconica, alla chiusura conservativa del soggetto su se stesso. Assistiamo, scrive Massimo Recalcati in questo suo ultimo libro, a “una inedita pulsione securitaria”, indice di una perdita del desiderio. Al centro, in questa prospettiva, non sarebbe più l’uomo senza inconscio, quanto una tendenza fascista, una tendenza alla chiusura, al cuore dell’inconscio stesso. La pulsione di morte riappare sulla scena. Recalcati ripercorre qui il grande misconoscimento della pulsione di morte nella storia della psicoanalisi post-freudiana: Freud perturba la visione positivista introducendo nel 1920 questo concetto insopportabile che problematizza il rapporto sia con il piacere che con la realtà. L’essere umano non persegue esclusivamente il proprio bene, l’essere umano non è istinto, è piuttosto pulsione, esorbita il criterio di soddisfazione del bisogno e non ha un programma genetico che assicurerebbe la sua autoconservazione. Esiste una tendenza della vita a rifiutare la vita, una negatività che è eccesso: “rifiuto dell’apertura della vita nel nome di una sua estrema conservazione che finisce per annientarla”. La vita tenderebbe a ritornare sempre nello stesso posto, a “garantirsi”, a rifiutare ogni trasformazione.

La figura della melanconia direbbe dunque una verità dell’essere: la melanconia come quadro clinico mostra l’impatto con il non senso, ed è dunque essenziale per aiutarci a guardare cosa sia la vita umana. La melanconia racconta con grande chiarezza che l’esistenza e il senso non si sovrappongono, ma che piuttosto l’esistenza non può essere del tutto assorbita nel senso. La melanconia può essere intesa come una figura del dolore di esistere, dice di una nota depressiva al fondo della vita umana in quanto vita pulsionale, in quanto insensatezza, abbandono assoluto e unità perduta.
Massimo Recalcati metterebbe dunque in luce, sia sul piano individuale che su quello collettivo, l’esito dell’irruzione sulla scena di questo non senso dell’esistenza.
In Freud la melanconia indicava il delirio morale: proprio perché esisteva una Legge sentita dal soggetto come spietata, la forma che la melanconia poteva assumere era quella del senso di colpa. La mancanza costitutiva dell’umano si fa colpa inemendabile, colpa di esistere.
Oggi emerge piuttosto – come può esserci senso di colpa dove manca la Legge? – l’esistenza sentita come peso, lo spegnimento del desiderio, l’introversione del soggetto su se stesso.
Per evitare il fallimento del desiderio si rifiuta la vita.
Anoressia, apatia, depressione, risentimento, isolamento: sono tutte figure di ritiro dalla scena del mondo e figure che dominano il nostro tempo. Il soggetto si ritira da ogni forma di legame, gli oggetti non bastano più, vive nella nostalgia dell’unità originaria perduta e non è capace di desiderio dal momento che il desiderio è esposizione all’ingovernabile, all’eccedenza dell’esistenza che non può essere padroneggiata. Le nuove figure patologiche fanno dell’argine, del muro, il nuovo oggetto della pulsione. L’odio si rivelerebbe, è Freud a sottolinearlo, più antico dell’amore: l’odio contro il mondo come sorgente di stimoli, l’odio da intendersi come rifiuto della vitalità della vita. Fromm in Fuga dalla libertà mostra come la distruttività, così come il soffocamento della vita, siano radicate nell’incapacità di sopportare l’impotenza e l’isolamento, l’incapacità di sopportare quello che non si padroneggia perché altro, la vita come evento e non come ripetizione. La distruttività è il risultato di una vita non vissuta, di una vita che non sopporta di esporsi al rischio del fallimento: “sembrerebbe che la misura di distruttività riscontrabile negli individui sia proporzionale alla misura in cui viene stroncata l’espansività della vita”.
Massimo Recalcati non ci offre solo una chiave di lettura del ritorno dei fascismi cui assistiamo, un modo per interpretare la chiusura, il rifiuto di ogni differenza che domina il discorso sociale, ma ci convoca come individui su un punto di responsabilità non solo rispetto al nostro desiderio ma, al tempo stesso, rispetto alla possibilità di costruzione di un discorso sociale e politico alternativo. Il dialogo tra clinica e polis consente di vedere con maggior chiarezza le conseguenze di un certo agire individuale. L’ideale di una vita compiuta, autosufficiente, autonoma, di una vita che si smarca dal legame con l’altro e che si vuole padrona di se stessa, corrisponde, sul piano sociale, a muri e difese e rifiuto dello straniero. Così come il sogno di un uomo-macchina, un uomo regolato dal principio di prestazione.
Che ne è dell’ingovernabile? La psicoanalisi ci insegna che negarne l’esistenza è coltivare l’illusione di un Io padrone a casa propria e padrone del mondo intero – quel che anima i deliri totalitari: “L’impatto con l’ingovernabile ci costringe a fare amicizia con lo straniero […] si tratta di fare spazio a una vulnerabilità condivisa. L’arte della poesia e della scrittura offrono già un esempio illuminante di quanto sia necessario accogliere l’esposizione all’ingovernabile per rendere possibile la creazione […]. Il governo etico non è quello che persegue lo scopo di annullare l’ingovernabile, ma quello che lo sa ospitare”.
Le nuove melanconie mostra il rischio politico e sociale del non assumerci la fatica di accogliere l’ingovernabile nella nostra vita, del sostituire l’incontro-esposizione all’altro con il gadget che non ci tradirà, del continuare a essere mossi da un bisogno di riconoscimento che ci assicuri dalla solitudine, più che da un nostro desiderio che è esposizione e possibile caduta ma, insieme, apertura all’altro. Siamo posti di fronte alla verità scabrosa del rapporto che intercorre tra la responsabilità verso la nostra vita e il discorso politico.
“La luce che è venuta nel mondo” che dobbiamo provare a riconquistare, allora, potremmo pensarla, percorrendo questo gioco di rimandi, come la saggezza della ginestra: un invito a assumersi una quota di solitudine, a vivere nel rischio, alle pendici di un Vulcano, e tuttavia in ascolto del cosmo. L’uomo superbo che sfida la natura di cui ci parla Leopardi, l’uomo che pretende di piegarla e saturarla e si illude di poter cancellare la propria fragilità e la propria finitudine, è l’uomo che dimentica che curare il mondo è non ridurlo a una “totalità di mercato” ma renderlo una “totalità di senso”, e che questo senso è da ricercarsi in un essere-in-comune, in una apertura all’Altro, in una cura del Tutto e dello straniero, primo fra tutti lo straniero che lo abita e che solo può rivelargli, al di sotto di ogni delirio di prestazione e ogni volontà di riconoscimento, la verità del proprio desiderio.