Quando la giustizia è giusta?
Quando la giustizia è giusta? Questo interrogativo è normalmente rivolto alle leggi che devono essere rispettate e a come comportarsi se ritenute ingiuste. Il dilemma è antico, con protagonisti celebri come Antigone, ma si presenta anche sotto un altro versante, quello del ‘come’ si giunge al risultato finale. Si tratta del processo, una sorta di motore creato dallo Stato che si avvia con la verificazione di un fatto, che percorre strade investigative per giungere alla sentenza, cioè al ‘ver-detto’. Questo motore funziona grazie a svariati ingranaggi costruiti ed assemblati in un certo momento storico, ritoccati nel tempo per assicurare una migliore funzionalità, per adeguarsi alle mutate condizioni socio-politiche, per aderire più efficacemente ai principi generali. Uno di questi momenti è contrassegnato con un termine forse oscuro (“sussunzione”) ma nel procedere costantemente utilizzato. Esso consiste nel calare il fatto in un modello di reato previsto dalla legge in quanto la condotta di chi ha agito ha rilievo giuridico solo se si conforma al codice. È il caso ad esempio della provocata morte di un altro uomo, che ricade quasi automaticamente nel reato di omicidio. In altri frangenti il meccanismo è più complicato come nel caso dell’uso delle parole ritenute da chi le subisce lesive della sua reputazione. Si tratta di diffamazione? Le cronache recenti dimostrano come il quesito fuoriesca dai confini della stampa e invada quelli della contesa politica, come nella vicenda estiva di Bersani querelato da Vannacci per l’appellativo di “coglione”. L’operazione pone, tra i molti, un interrogativo di fondo: quale condotta occorre considerare? Balza subito in evidenza come protagonista il profilo oggettivo, cioè la ‘nuda scena’ ricostruita con i dati raccolti. Ma, ci si è chiesto, occorre prendere in esame anche il versante soggettivo, cioè la condizione personale del soggetto quando ha agito?
Sotto questa luce il diritto penale ha avuto una storia travagliata e illuminante. Essa è passata, anche con retromarce, dal ritenere responsabile chi ha causato il fatto sempre e in ogni caso al pretendere, per punire, che quel fatto sia ‘proprio’ della persona, cioè psicologicamente gli appartenga. Viene costruito nei secoli, con faticosi passi, il principio della ‘colpevolezza’, cioè dell’autodeterminazione individuale, cui si deve aggiungere la pretesa che l’individuo sia messo a conoscenza in anticipo delle conseguenze giuridiche di un certo comportamento. Non solo: la colpevolezza consente anche che la pena sia graduata in base non tanto per la gravità astratta del fatto commesso, quanto al rimprovero soggettivo da muovere alla condotta tenuta. Gli antichi, non a caso, parlavano di “nullum crimen, nulla poena sine culpa” riferendosi all’azione non causata dalla natura (caso fortuito o forza maggiore), ma riferibile a un soggetto che deve aver ‘voluto’ il fatto verificatosi, peraltro vietato tramite un divieto che si doveva conoscere.
Un recente saggio (Arianna Brunori, Imputazione e colpa. L’invenzione della volontà, Quodlibet, 2023) tratta l’argomento con profonda ricerca e riflessioni accurate, accompagnando il lettore in una cavalcata storica dai molti rivoli e con confortanti punti di arrivo. L’ondeggiamento, nei secoli, poggia principalmente su un quesito: come distinguere gli atti volontari da quelli involontari per punire solo i primi, e come conciliare quest’esigenza con le esigenze collettive e sociali di controllo, sorveglianza e punizione del crimine.
Già nel mondo greco e romano è presente quella distinzione, colorata da un rimprovero etico e religioso, con l’obiettivo di punire differentemente l’omicidio, quello volontario con la morte, quello involontario e senza responsabilità con l’esilio (ad esempio nell’uccisione non voluta di un avversario in combattimento; nell’uccisione in guerra del compagno scambiato per il nemico; nella morte del paziente ad opera del medico nell’esercizio dell’attività). Non solo: decisivo è il rapporto con la divinità da cui si modellano le qualità dell’uomo consapevole e ‘moderno’ (Eva Cantarella, “Sopporta, cuore.” La scelta di Ulisse, Laterza 2013). Ulisse sa che alla volontà degli dèi ci si può sottrarre solo scatenando la loro ira, ma sente di poter-voler scegliere la ‘sua’ strada, attraverso una faticosa presa di coscienza.
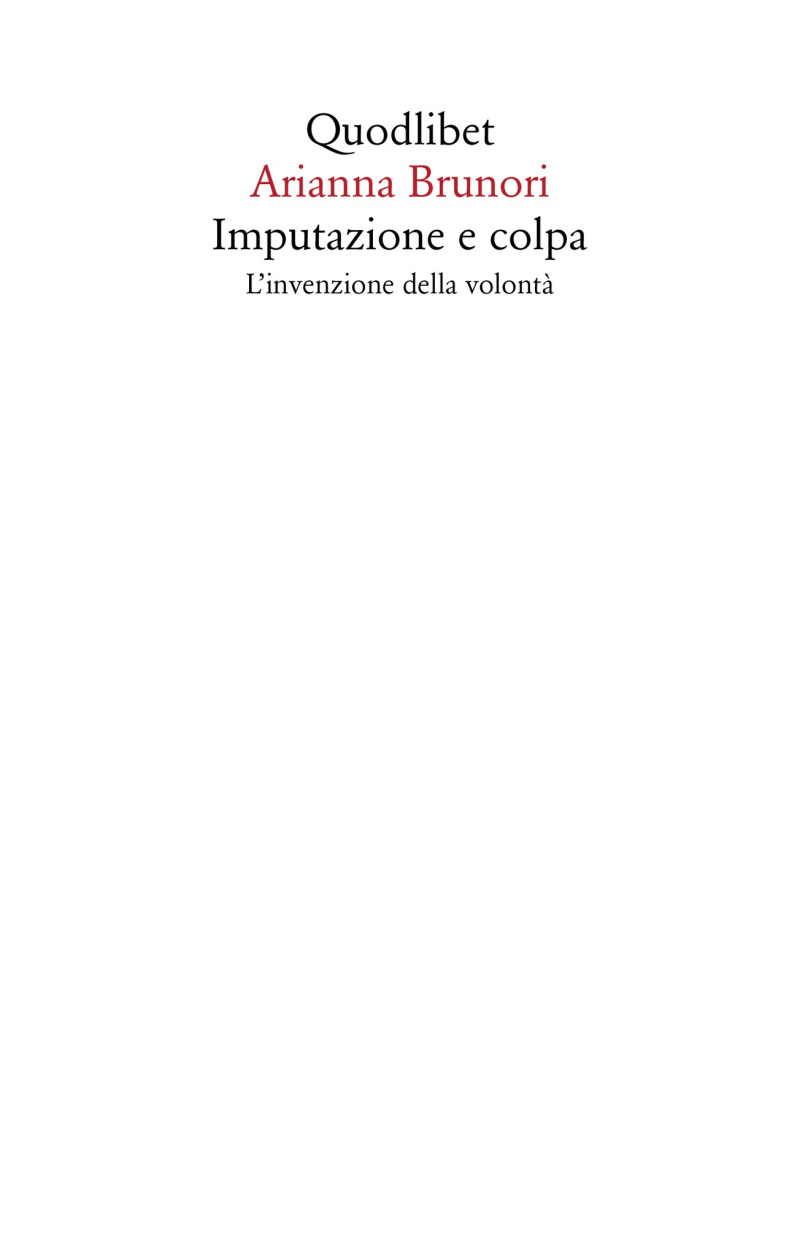
L’autrice passa dottamente in rassegna i passaggi cruciali di quella cavalcata storica soffermandosi su Platone che considera l’azione un riflesso della razionalità, per cui chi vi si conforma non è criticabile, mentre l’inadeguatezza riflessiva provoca azioni censurabili. Successivamente per Aristotele l’atto libero “sta in colui che agisce e che lo compie”, mentre quello non voluto riguarda chi agisce con ignoranza dovuta a sua colpa. Non sempre però vi fu convergenza su questa opinione. Nella tragedia greca, ricorda l’autrice menzionando Eschilo, si delinea la responsabilità delle persone sempre e comunque, anche per gli atti involontari e per le conseguenze accidentali. E questo perché l’agire in generale, e quello violento nel particolare, ‘vive’ negli dei ed è un prodotto della divinità. “Quello che viene dal cielo imprime un marchio sulla terra”. Il mondo romano è meno intransigente e riconosce la sussistenza della volontà colpevole basata sull’“assenso”, sulla scelta, che sarebbe stata presente pur con sfumature nei secoli successivi. Intanto lo Stato introduce norme per limitare le vendette private attribuendosi il compito di punire pubblicamente solo chi ha agito “con prava intenzione e consciamente” (“dolo sciens”), indicato oggi come ‘intenzionale’. Dall’età costantiniana del IV secolo si amplia l’obiettivo della repressione criminale, divenuta di competenza imperiale a scapito dei tribunali e ci si spinge a punire senza tanti riguardi, senza dolo né colpa, oggettivamente. E per questo si afferma una punibilità senza dolo né colpa, collettiva ed oggettiva.
Anche nel mondo giudaico si afferma la spinta repressiva ritenendo indifferenti, per punire, l’intenzione e la volontà trattandosi di “un mancamento a un costume imposto, un atto proibito”. Come per il peccato. Su questa linea si prosegue nell’alto medioevo secondo cui la volontarietà è indifferente, in quanto si tratta della trasgressione di regole oggettive qualunque esse siano e qualunque siano le ragioni, come nella vita monastica. Come ricorda l’autrice, non a caso in questa fase i penitenziali, cioè i libri con le annotazioni di trasgressioni e penitenze in auge nel VII e VIII secolo, si disinteressano della volontà, pur segnalando che la colpa oggettiva non è un segno di volontà perversa (p. 17).
Purtuttavia nei decenni successivi lentamente i giuristi recuperano la nozione di responsabilità fondata sul proposito criminale, sul “dolus malus” derivato dalle fonti romane, nella convinzione che per punire devono essere valutate le cause dell’azione (p.123). Rimane però sempre indefinita la nozione dell’involontarietà, e questo non a caso perché utile per punire indiscriminatamente, senza riguardi, anche quando i comportamenti sono soltanto negligenti e cioè non voluti.
Intanto si afferma un nuovo volto del processo penale: l’esecuzione in pubblico della pena, un classico del passato per mostrare concretamente alla collettività le conseguenze delle azioni colpevoli, perde peso. Si ritiene che la pena invece si incarni nel giudizio cui viene sottoposto l’inquisito e vengono affidati ai tecnici ampi poteri nell’istruttoria centrata sulla confessione e sulla penitenza. “Tutta la pena è nel giudizio e il carcere una sua prosecuzione”, ponendo così attenzione al movente che influenza i gradi di colpevolezza, alle attenuanti ed aggravanti, allo status, all’età, ai “temperamenti” di cui parla Benjamin in “Destino e carattere” come ricorda l’autrice. Nei secoli successivi prende sempre più piede la convinzione che la società, se molto esposta al crimine, sia troppo vulnerabile e che quindi non si debba andare per il sottile nel punire gli atti criminosi. E scandagliare la loro “volontarietà”, quello che i romani designavano come ‘ animus’, viene ritenuta una concessione troppo generosa a scapito della sicurezza della società (siano da considerare le istanze di repressione sociale, così ritenendo troppo restrittivo il concetto di “animus” e troppo limitativa la nozione di atto involontario). La conseguenza è che i crimini devono essere sempre puniti (p. 190).

L’ondeggiamento delle pulsioni storiche non è terminato. L’eccessiva durezza punitiva nel tardo medioevo porta a ribadire il nesso necessario tra imputazione e volontà, (p. 55), e si susseguono gli sforzi per calibrare l’“animus”, i moventi, i gradi di pena (p. 95) delineando forme attenuate di dolo e di colpa negli interstizi della volontarietà del crimine (p. 190). Nei secoli successivi si riproducono questi antefatti storici nella convinzione che l’uomo non sia padrone di azioni non volute, che la colpa è una caduta, un errore, non frutto di intenzione perversa, è involontaria, conseguenza di azioni non volute.
Il saggio della Brunori, leggibile con sorvegliata attenzione, conduce al diritto penale moderno, tormentato come nel passato da istanze confliggenti. Da un lato si pone l’esigenza di sorveglianza a favore della comunità con la conseguente punizione dei crimini, dall’altro si devono tutelare i valori dell’individuo costantemente raffinati da leggi e interpretazioni. L’autrice accenna anche a un tema laterale, l’imputabilità, spesso confuso, ma distinto, dalla consapevolezza. Al di là della volontà di cui si è parlato, non è consentito muovere rimprovero a chi non è in grado di percepire il significato e il disvalore della propria condotta. È necessario che il soggetto sia imputabile, cioè si sia determinato all’azione con sanità di mente e con capacità di intendere e di volere, che non sia affetto da malattie o deviazioni che ne abbiano alterato la personalità, che sia libero di scegliere tra condotte possibili e quindi possa subire le conseguenze della trasgressione. Con questa nozione, cioè con l’imputabilità, oggi e solo oggi si penetra, o meglio si sprofonda, nella discussione sul libero arbitrio. Il diritto penale poggia anch’esso su un accordo sociale: presentarsi come strumento di controllo e nel contempo riconoscere alla persona un’autodeterminazione libera, una capacità di orientarsi e una conseguente punizione se rimproverabile. Questo nei secoli passati è stato raggiunto come traguardo di civiltà e si perpetua ora, anche se sul portone kafkiano dei tribunali bussano le spinte dissacranti del determinismo e delle neuroscienze, che propongono e ritengono, esperimenti alla mano, che il delitto non sia del soggetto umano ma del cervello (Lavazza e Sammicheli, Il delitto del cervello: qui la recensione).







