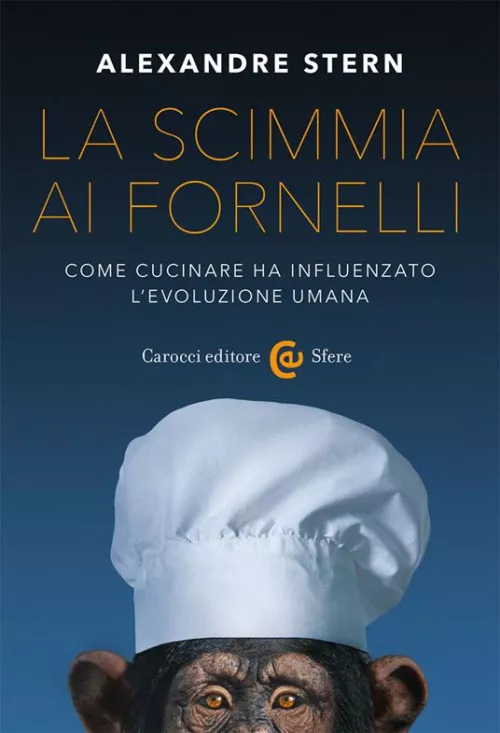Scimmie ai fornelli
Ve ne sarete accorti: tutti a parlar male del Neolitico. O anche, per dirla coi giornali generalisti, tutti pazzi per il Paleolitico. Ma come? L’epoca gloriosa dove è nata la civiltà urbana, la divisione sociale del lavoro, l’agricoltura, l’allevamento del bestiame, la ceramica, la gestione dei metalli, la moneta, le religioni tripartite, financo la scrittura… insomma: tutto da disprezzare? Ricordiamo una canzoncina con annesso balletto sexy passata a Sanremo, poniamo, nei primi anni Settanta: si intitolava Neanderthal man, e aveva fatto scalpore – a seguito dell’ideologia dell’epoca per cui selvaggio è rivoluzionario dato che, in soldoni, sarebbe desiderio puro, provocazione porno soft, isola di Wight de noartri… Poco importa che si trattasse d’un altro ceppo rispetto al sapiens: per l’immaginario comune il primitivo e il selvatico facevano un unico fascio tanto esotizzante quanto vago.
Ma, oggi, a ricomporre il quadro delle nostre fantasie, quello di questi anni mediatici e postmediatici, non è più l’erotismo pruriginoso ma la scienza (l’erotismo della scienza?), dura o molle che sia, naturale o innaturale, umana o disumana. La quale, nelle sue ampie smagliature, è occupata a ripensare alle fondamenta, se non le nostre origini troppo umane (stracariche di retropensieri), il nostro passato ancestrale. Il quale ripensamento, come sempre, darebbe la stura a un differente modo di intendere il nostro presente attuale, il nostro prossimo futuro. Così, la marea di dubbi, se non di critiche, che giorno per giorno si stanno sollevando intorno alla nozione, e alla questione, del progresso, della crescita per la crescita, di una palingenesi mal secolarizzata, sta portando a risemantizzare il luogo e il momento dove tutto ciò sembra aver avuto cominciamento: che è proprio il passaggio, troppo a lungo salutato come molla scatenante di un’euforica marcia verso la civilizzazione, dal Paleolitico al Neolitico. Come dire – di primo ipersemplificatorio acchito – da una condizione dell’homo ancora animalesca a un’altra invece tutta proiettata verso l’onesto e retto conversar cittadino. La quantità di equivoci e precisazioni, di luoghi comuni e distinguo, di pedisseque accettazioni del già noto e ostinata ricerca di riformulazioni è a questo proposito ingente. Da qui, in sintesi, le ombre pensose che oggigiorno si addensano intorno all’età cosiddetta neolitica.
Semplifichiamo con un paio di esempi. Aveva gettato la prima pietra, è il caso di dirlo, Stone Age Economics di Marshall Sahlins (ne abbiamo parlato qui). Il quale, preso dalle rivendicazioni giovanili di fine anni Sessanta, criticava il modo di produzione capitalistico additandone i limiti e, soprattutto, mostrando come l’ideologia dell’abbondanza a esso sotteso abbia permeato perfino la ricerca antropologica sulle condizioni preistoriche di alcune rare popolazioni umane ancora presenti nel pianeta. I paleolitici non vivevano di stenti perché, molto semplicemente, perseguivano– diceva Sahlins – una “via zen all’opulenza” tale per cui tanto peggio tanto meglio o, se si vuole continuare con gli slogan, less is more.
La loro non era un’economia di sussistenza ma una forma di vita in cui non c’era alcun bisogno di accumulazione preventiva, non era necessario pensare come la formica dato che, da nomadi, si viveva benissimo come cicale. Si trovava quel che serviva, il resto era tempo libero, spasso. Ma col Neolitico tutto è cambiato, dato che la vita stanziale ha permesso, coltivando e allevando, di conservare più del dovuto, e di sbandierarlo come simbolo di status: è l’avvento delle odiose gerarchie sociali. Forse una semplificazione, ma sicuramente un’inversione di prospettiva degna di grande attenzione, soprattutto oggi che la scala di valori che mette il lavoro – il valore che produce – alla sommità dell’esistenza inizia fortemente a scricchiolare.
In tempi recenti un critico dell’ecologia come Timothy Morton, in tutt’altro ambito concettuale, è tornato a suo modo sulla questione. In termini molto più critici, pesanti, quasi parossistici. Per Morton l’inizio di tutti i guai del pianeta, quelli che oggi l’ambientalismo prova ad arginare, sta proprio nel Neolitico, là dove nasce quel curioso dispositivo che Morton stesso chiama ‘agrilogistica’: non solo e tanto l’agricoltura in sé come forma di organizzazione produttiva a fini di sostentamento, ma tutta la serie di conseguenze – religiose, politiche, economiche, ideologiche – che essa si tira dietro.
Non è un caso, nota il filosofo americano in Ecologia oscura (Luiss u.p., con ottima introduzione di Gianfranco Pellegrino, 2021), che le grandi religioni nascano parallelamente all’agricoltura, e la salutino come possibile antidoto a un peccato che la precede. La maledizione di Adamo ed Eva, rei di aver voluto innalzarsi a Dio, sta nel dover cominciare a coltivare la terra, passando dallo stato di raccoglitori a quello di agricoltori. Il sudore della fronte, a suon di vanga e spada, è quel che li aspetta. Analogamente nell’antica India l’età dell’oro era ricordata come l’epoca in cui gli uomini vivevano di frutti e di radici che si procuravano senza sforzo alcuno.
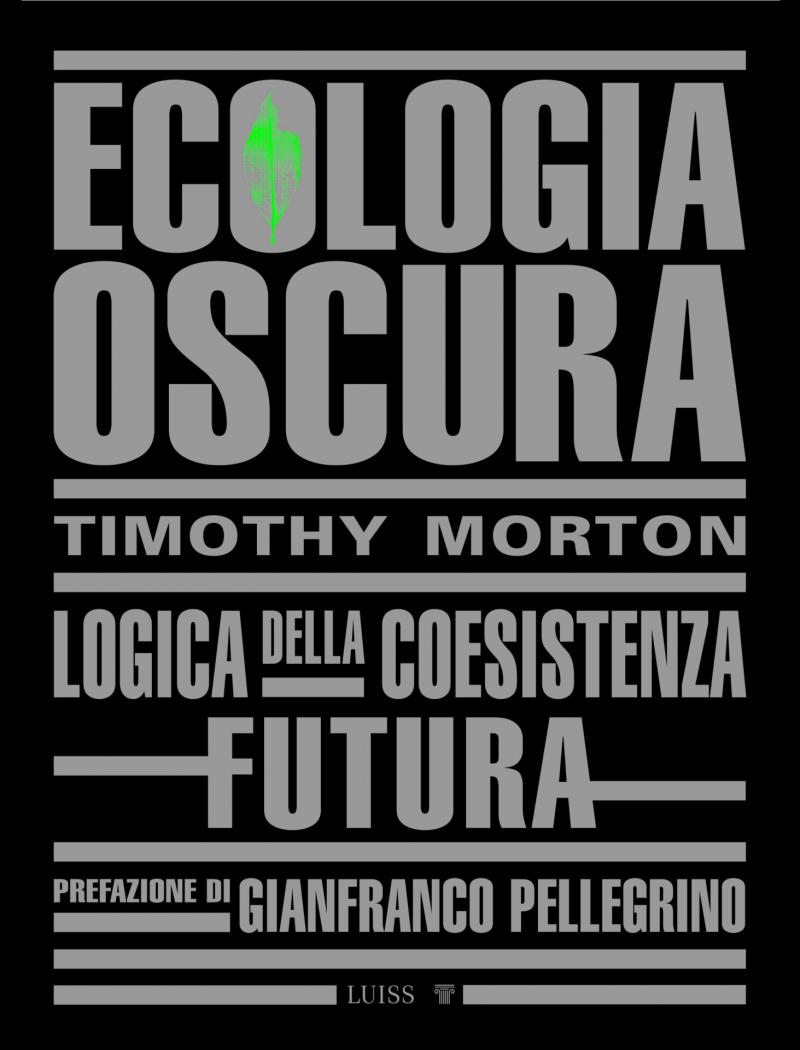
Arrivata l’agricoltura iniziò invece l’abominio, e cioè l’età dell’argento, di modo che coi campi coltivati, da quelle parti, si accorcia addirittura la durata della vita. Di fatto, l’agrilogistica è una specie di programma bimillenario che inizia a sfruttare intensamente le risorse del pianeta distinguendo gerarchicamente fra umani e non umani, imponendo la proprietà privata, ponendo così le prime basi di quella che diventerà l’antropocene. Inventando la Natura come un’entità esterna rispetto alla specie umana, il programma pubblico dell’agrilogistica spadroneggia, mal celandosi dietro un paternalismo che permea di sé, inconsapevolmente, molte frange dell’ecologismo. Volendo proteggere la Natura, gli ambientalisti di mestiere perpetuano la violenza insita nell’agrilogistica neolitica. Altro che progresso civile.
Questa lunga premessa per dire che non ci saremmo aspettati di trovare una presa di posizione altrettanto problematizzante nei confronti del Neolitico in un testo di spessore e di genere assai differenti, dove la posta in gioco appare tutt’altra: se e come la cucina ha influenzato l’evoluzione umana, le sorti biologiche dell’homo fin dai tempi della sua complicata venuta al mondo. Mi riferisco a un bel libro dal goffo titolo, La scimmia ai fornelli, del gastronomo francese Alexandre Stern (Carocci, pp. 167, € 14), che mette in fila una serie di convergenze parallele fra alcune variazioni dietetico-culinarie e certi grandi cambiamenti fisiologici e comportamentali, ma anche storico-sociali, della specie umana. La quale specie umana, secondo Stern, è divenuta tale proprio grazie ai fornelli, o per meglio dire attraverso la capacità di gestire del fuoco che ha portato alla cottura dei cibi e con essa, come sembra, all’allargamento delle aree cerebrali. Lasciamo la parola (un po’ arrischiata) al nostro autore: “il saper cucinare non solo ci distingue dal resto del regno animale, ma è una delle radici della nostra umanità. È stata infatti una maggiore disponibilità di proteine, riconducibile all’invenzione dei primi utensili e poi alla domesticazione del fuoco, ad aver reso possibili la crescita di dimensioni del nostro cervello e i progressi tecnici e scientifici che ne sono seguiti”. Come dire, il progresso tecnico ha portato al progresso tecnico per il tramite della cucina: interessante circolo virtuoso.
Il fatto è che, precisa Stern, affilando le selci “i nostri antenati” (come dire l’homo habilis) hanno cominciato a cercare prelibatezze dieteticamente efficaci: hanno catturato e ingoiato il midollo osseo e la materia grigia dei grandi mammiferi, da cui un incremento del volume del cervello da 450 a 600 centimetri cubici. Mangiare cervella le fa crescere. Ne è seguita la prometeica invenzione del fuoco che, a sua volta, ha condotto, per così dire, a un’esternalizzazione di gran parte del lavoro digestivo. Se ingerire carni crude comportava una assimilazione lenta e laboriosa, arrostirle permetteva di mandarle giù molto più rapidamente, risparmiando un sacco di energia – la quale poteva essere spostata verso altre attività.
Assimilando la lezione lévistraussiana (senza però riversarla sul versante simbolico e culturale) Stern trova un parallelo fra digestione e cucina. Entrambe trasformazioni della materia alimentare, laddove però la seconda – assai più efficace – comporta un’individuazione ulteriore della specie umana. L’uomo, da questo momento in poi, non è un animale semplicemente onnivoro ma più specificamene ‘cucinivoro’. Motivo per cui il focolare non si viene inteso come semplice strumento di preparazione del cibo ma luogo della sua condivisione, dunque della socialità. Ecco affacciarsi la scimmia (non più scimmia ma essere umano) ai fornelli (non più fornelli ma banchetti) e, con essa, la sua travagliata evoluzione storica. Sino ad arrivare, afferma un po’ semplicisticamente Stern, alla rivoluzione industriale alimentare, e cioè all’oggi, dove vige il paradosso per cui “non abbiamo mai mangiato così bene” (esplosione dei ristoranti gourmet) e nello stesso tempo “non abbiamo mai mangiato così male” (diffusione dei prodotti conservati nei supermercati).
Ma torniamo al Neolitico, o per meglio dire al lento passaggio dal Paleolitico a esso. In una trattazione, come si sarà colto, fortemente naturalizzante e deterministica, legata peraltro all’idea di evoluzione lineare, ecco che un andare avanti si configura però come un risultare indietro. La domesticazione delle piante e degli animali, dopo quella del fuoco, ha comportato una fortissima trasformazione degli stili della vita umana, vale a dire la sedentarietà, e con essa l’organizzazione interna di villaggi e centri urbani, il mercato, la scrittura, l’esercito, la scala sociale, la guerra. E con ciò, la crescita esponenziale della popolazione. Nell’arco di qualche migliaio di anni – a partire dal 10.000 a.C. – fra la cosiddetta Mezzaluna fertile (vasta area fra Israele e Iran), la Cina e il Sud-est asiatico e l’America meridionale nasce l’agricoltura, e l’uomo da cacciatore-raccoglitore si trasforma progressivamente in allevatore e contadino. Se prima si andava direttamente alla ricerca di cibo, adesso si va in cerca di nuove terre per produrlo. La terra, intesa come campo da coltivare, diviene un bene preziosissimo e scatena rivalità immense fra etnie, società, culture. Le differenze generano così somiglianza, e viceversa. Ecco la prima forma di globalizzazione: tutti a coltivare cereali e a trasformarli in pappette varie, come anche a far fermentare alcune piante succose e inebriarsi di alcolici.
Quel che va osservato, nota Stern, è che però all’enorme crescita demografica (da 5 a 400 milioni di abitanti nel pianeta) su scala sociale corrisponde una forte diminuzione del benessere individuale: per coltivare le piante e allevare gli animali si perde il doppio di tempo che raccoglierne i frutti o cacciare la selvaggina. Si fatica da matti e, segnale curioso, si diventa più bassi (di ben 10 centimetri in media). In generale, si perde un sacco di tempo libero e aumentano le paure – basta una carestia – di fare la fame, morendoci pure. Come se non bastasse, si diffonde la carie, legata agli zuccheri presenti nei cereali e nella frutta: fastidio prima inesistente, e a suo modo letale. In una grotta marocchina, per esempio, sono stati trovati resti umani accanto a ghiande: il 94% di quegli uomini soffriva di carie dentaria.
La domanda è d’obbligo: ne valeva la pena? Perché l’uomo si è intestardito a coltivare e allevare piuttosto che a raccogliere e cacciare? Non si stava meglio quando si stava peggio? Come accettare il fatto che la maggiore felicità per il maggior numero provochi la sfiga perenne per il singolo? Come dice Stern, i benefici – sulla salute, sulle comodità quotidiane, sulla soddisfazione media – alla fine prevalsero. Ma nel frattempo? Perché accollarsi tanti problemi? Mica i nostri neolitici in erba potevano prevedere cosa sarebbe accaduto nei millenni successivi alle loro esistenze hic et nunc. E le risposte sono legione, tutte parziali: cattiveria, superbia, desiderio di dominio, caparbia dialettica dell’illuminismo… E anche qui più che mai, le catene di cause ed effetti si confondono con le presupposizioni reciproche: l’agricoltura porta alla sedentarizzazione o è vero il contrario? La sedentarizzazione è provocata dalla religione o no? Viene prima il tempio o il villaggio? Che sia stato un problema di variazioni climatiche, di adattamento alle risorse disponibili?
Sono questioni che riguardano l’interpretazione globale – dunque politica – della storia. La ricerca va avanti, la riflessione filosofica altrettanto. Nel frattempo potremo limitarci a osservare che, per dirla con Morton, l’agrilogistica sta cominciando ad annoiare. Sempre più persone preferiscono lavorare meno e spassarsela meglio, riposare, coltivare piuttosto il dolce far niente. Come i paleolitici. La critica alla società capitalistica passa anche da una strategica pigrizia.