Souvenir di fine estate
Tempo di vacanze. Tempo di mare, di montagna, di fresche città nordiche, di ameni paesaggi.
Tempo di rientri. Tempo di piante resilienti sopravvissute all’arsura estiva, di valigie da riporre, di routine da riprendere.
Tempo di ricordi. Tempo di riguardare raccolte di selfie, di raccontare esperienze straordinarie a volti visibilmente annoiati, di attaccare calamite sul frigo e posizionare in vetrina ceramiche dipinte a mano faticosamente fatte entrare nel bagaglio e miracolosamente giunte illese tra le mura domestiche. Oggetti messi lì ad arricchire una privatissima collezione di cimeli e a ricordare, a noi e agli altri, personalissime storie di viaggi.
“Feticci del ricordo”, come li definisce Giesz (in un testo contenuto in Riga 41. Kitsch, a cura di Marco Belpoliti e Gianfranco Marrone, 2020, Quodlibet), i souvenir sono l’ovvio della vacanza e proprio per questo rappresentano uno straordinario punto di avvio di riflessioni sul turismo e sui suoi paradossi, ma anche, per loro tramite, sul nostro modo di stare al mondo e di concepire le relazioni con l’altro.
Ne ripercorre la storia Rolf Potts, saggista e travel writer, in Souvenir. Una storia culturale, testo del 2018, recentemente tradotto e pubblicato in Italia da il Saggiatore (158 pp.). Dalla scorrevole lettura si apprende come la pratica di riportare con sé qualcosa da terre straniere sia plurimillenaria e si sia consolidata in epoca cristiana con i pellegrinaggi, quando si diffusero proto-souvenir religiosi, legati a reliquie, oli, ma anche a stoffe che, per semplice contatto con oggetti di culto, divenivano sacre esse stesse. Nei secoli a seguire, è la volta di porzioni di mondo naturale: ossa di animali, conchiglie e pietre, riportate in casa, divennero una delle basi nelle esposizioni delle Wunderkammern del XVI-XVII secolo. L’operazione era duplice: non si trattava soltanto di mettere in mostra l’esotico, ma di esibire, contemporaneamente e forse soprattutto, lo status, il prestigio e la cultura del collezionista. Per questo intraprendenti mercanti fecero fortuna vendendo oggetti stravaganti provenienti da terre lontane a facoltosi collezionisti, che poterono così continuare a meravigliare i propri ospiti senza correre rischi derivanti da viaggi all’epoca ancora piuttosto impervi. I souvenir sopravvissero durante i Grand Tour, con gli illuminati viaggiatori che facevano rientro in compagnia di oggetti di varia natura da esibire o regalare. E proprio collezioni di souvenir divennero la base espositiva di alcuni grandi musei, accompagnando così il passaggio dal collezionismo privato all’istituzione museale moderna e al correlato ideale di mettere a disposizione del grande pubblico opere e oggetti fino a quel momento esibiti di fronte alle élite. Va da sé che in questo passaggio l’oggetto si sia trasformato: non più ricordo personale dal valore affettivo, ma “tipo” da ammirare e studiare, del tutto slegato da un’esperienza di viaggio.
Se fino all’800 il souvenir era costituito da un ritrovamento personale o dall’acquisto di un manufatto locale, alla fine del secolo e ancor più nel successivo, esso si identifica con un prodotto industriale destinato a un mercato turistico sempre più massificato. Lo si raccatta in uno specifico genere di negozio, solitamente caratterizzato da una superficie espositiva limitata ma densamente affollata, con espositori che strabordano su strada, nei pressi delle principali attrattive turistiche, e in cui quindi ci si imbatte un po’ per caso. Con merce disparata che, spiattellata sotto al naso, economica, resistente e facilmente trasportabile, si presta a un acquisto destinato a ricordare a noi stessi la nostra esperienza o a testimoniare ad amici e parenti del nostro esser stati in qualche parte del mondo.
Vituperati dal giornalismo, bollati come oggetti di cattivo gusto e rappresentanti dispregiativi di un certo modo di far turismo, i souvenir divengono ben presto emblema del kitsch. Anzi, proprio dalla scorretta pronuncia di un certo tipo di souvenir – lo sketch, un grossolano disegno di paesaggi – deriverebbe, secondo alcuni, il termine kitsch (si veda ancora il citato Kitsch).
L’inizio di questa nuova era del souvenir può essere fatto coincidere con la Fiera mondiale colombiana del 1893 a Chicago, che, riprendendo quanto accaduto pochi anni addietro all’Esposizione di Parigi, confermò la moda del cucchiaino commemorativo. Sempre a Parigi era stata d’altro canto sdoganata la cartolina fotografica, che in poco tempo dilagò in tutto il mondo, imponendosi come un must del viaggio. Con tanto di timbro, lì ad autenticare la presenza del turista, essa si fa stereotipo, tanto che la “foto da cartolina” diviene l’ideale modello da cui farsi ispirare per gli scatti amatoriali in vacanza. Istantanee intente a catturare soggetti, oggetti, paesaggi, atmosfere che sintetizzino al meglio la “vera” essenza del luogo visitato e che, a ben guardare, abbiamo ancor oggi quotidianamente a portata di mano scrollando i social: struggenti tramonti sul mare, intriganti sagome umane colte in controluce, inediti scorci di monumenti, dettagli di volti di bambini malnutriti, immensi panorami di paesaggi incontaminati si affastellano in ordine sparso storia dopo storia rendendoci partecipi dell’esotismo altrui.
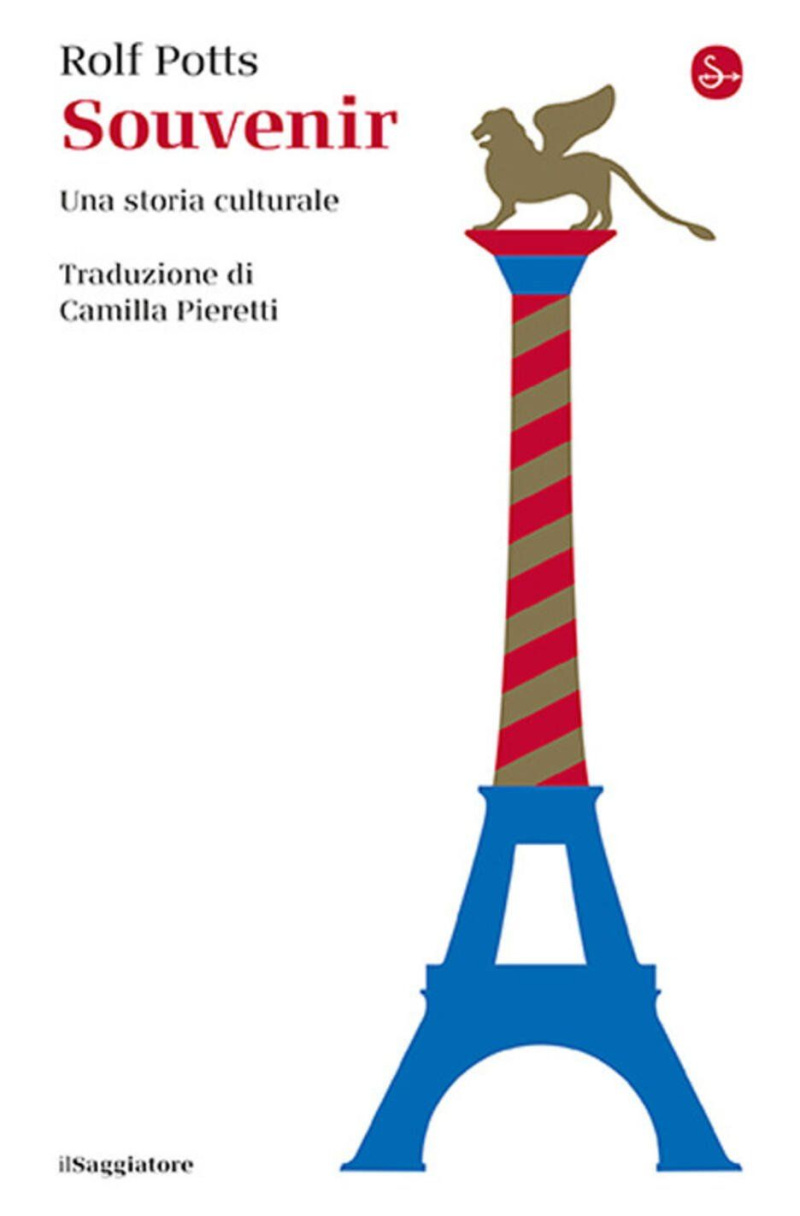
Il souvenir seleziona tratti e figure e li istituisce come turisticamente pertinenti: ribadendo cosa è rappresentativo di una cultura, di fatto contribuisce alla definizione dei tratti identitari di un luogo. E lo fa per ripetizione, passando, come spesso avviene, dal tipico alla caricatura. La Torre Eiffel diventa così portachiavi, penna, apribottiglie e tanto altro, suscitando un “rinnovato stupore” – così lo chiamava Barthes – dato dal salto di scala, dalla possibilità di tenere tra le mani o sulla scrivania il monumento miniaturizzato. Una sorta di “rivincita cognitiva sul ‘sublime’” kantiano, la definisce Tiziana Migliore in un saggio dedicato ai souvenir (pubblicato in Usi e piaceri del turismo, a cura di Isabella Pezzini e Luigi Virgolin, edito da Aracne nel 2020). Che la iper-riproduzione seriale, camaleontica e vertiginosa dell’opera ne faccia venir meno l’“aura” e, con essa, il suo valore sacrale, non sembra essere rilevante in confronto all’importanza derivante dall’aver toccato una tappa che vale il viaggio e dall’averne acquistato una traccia materiale.
Si entra così a pieno titolo nella controversa questione legata all’autenticità, cui Potts dedica un capitolo, ma che in realtà lambisce un po’ tutto il libro. Se da un lato il souvenir stereotipizza la meta visitata, dall’altro contribuisce a una sua trasformazione, spesso nella direzione indicata dal turista stesso. In quella che viene indicata come “autenticità simulata”, sperdute comunità modernizzate si ritrovano a mettere da parte jeans, t-shirt e smartphone per indossare vestiti di pelle animale e maschere tribali, e lo fanno proprio per confermare le aspettative dei visitatori di passaggio. Ma ci si rende facilmente conto che, guardando la questione scevri da pregiudizi, sia impossibile distinguere tra una autenticità “autentica” e una “ingannevole” e quanto in fondo il souvenir consenta di vedere limpidamente ciò che di consueto accade nell’incontro tra culture, dove la traduzione, la contaminazione e l’adattamento reciproco sono la norma. Niente di diverso dall’operazione Dolce&Gabbana, che, cavalcando l’idea di sicilianità, ha di fatto contribuito a reinventarla. In questa direzione, e in difesa di un oggetto tanto denigrato, va detto che il souvenir ha talvolta contribuito alla salvaguardia del patrimonio culturale delle popolazioni: rispondendo alla richiesta di perpetrare il tipico ne ha di fatto scongiurato la scomparsa, quando non ha preservato in termini prettamente materiali architetture e paesaggi. Nella prima metà dell’800, ricorda Potts, l’incremento del mercato turistico causò non pochi problemi nella gestione dei siti, sempre più sottoposti ad atti di predazione di un crescente numero di viaggiatori: un piccolo oggetto-ricordo si rivelò a quel punto un degno sostituto di un pezzo di edificio storico.
Dal punto di vista del turista non conta tanto che il magnete della locusta di Barcellona sia stato prodotto in Cina e possa anche essere tranquillamente acquistato online a prescindere da qualsiasi contingenza di viaggio, perché a contare, ben più dell’autenticità dell’oggetto, è l’autentificazione dell’esperienza. Non il vero, ma il verosimile. Già negli anni ‘80 del secolo scorso Culler poneva la questione del paradosso dell’autenticità: un luogo, per essere conosciuto come autentico, ha bisogno di essere marchiato come tale, ma, nel momento stesso in cui ciò avviene, vi è una mediazione, un segno del luogo stesso e, quindi, quel luogo non è più autentico nel senso di inesplorato. Ciò che è turistico fa perdere in autenticità, pur aspirando a essa. Lo sappiamo, il ristorante turistico è da evitare a ogni costo, quanto meno se ci si vuole distinguere come Viaggiatori.
Ed emerge così l’altro lato della medaglia: il souvenir non è solo la rappresentazione di un luogo, ma anche la presentazione del turista. Esso condensa una certa idea di viaggio, di modo che, dice Potts, “non è l’esperienza ad autenticare il souvenir, ma il souvenir ad autenticare l’esperienza” (p. 134). Prova provata degli spostamenti vacanzieri, questo piccolo oggettino non è nulla se non perché investito di un valore (soggettivo): il mio souvenir, guardato da altri come pezzo seriale e insignificante, potrà invece essere in grado di rievocare in me uno specifico momento del viaggio. La sua vista in grado di riproiettarmi in una dimensione spazio-temporale altra (di nuovo caratteristica tipica del kirsch, come sostiene Mecacci nel suo Il kitsch, il Mulino, 2014), all’esotico di ciò che ho visto e al passato del viaggio concluso. Potts paragona non a caso i souvenir alla madeleine di Proust e riporta l’esempio di Thomas Jefferson e John Adams che staccarono una piccola porzione di una sedia appartenuta (probabilmente) a Shakespeare, per portare a casa propria un pezzo di vita di un genio amato.
Siamo tutti a nostro modo collezionisti – proprio come i proprietari degli antichi gabinetti di meraviglie. C’è chi tappezza il frigorifero di calamite con in bellavista il nome delle mete visitate; chi affastella palle di vetro innevate nella vetrina del soggiorno; chi fa colazione un giorno con la tazza Amsterdam, uno con la MOMA, e un altro con la Tahiti; chi nello zaino accumula spillette a ogni viaggio; chi sfodera magliette dei cinque continenti; chi ha un portachiavi I LOVE NY poggiato su un posacenere I LOVE BERLIN; chi ha un taccuino di carta fiorentina, una maschera africana, un tappeto turco e una porcellana di Limoges. E nonostante i reticenti “no, a me questa paccottiglia non piace”, l’acquisto di souvenir è uno tra i rituali di viaggio più comuni. Questi pseudo-oggetti, come li chiamava Baudrillard, punteggiano le nostre case. Raccontando di noi, di chi siamo e cosa amiamo, di quali posti abbiamo visitato, dei nostri gusti. Dimmi che souvenir possiedi e ti dirò chi sei.
In copertina, fotografia di Piero Percoco.







