Speciale
Traduttrici invisibili
Uno dei libri più fortunati e citati nel campo degli studi sulla traduzione degli ultimi trent’anni è The Translator’s Invisibility (1995) del teorico americano Lawrence Venuti, subito e meritoriamente tradotto in italiano da Marina Guglielmi con il titolo L’invisibilità del traduttore (Armando 1996). Venuti mette i testi (di partenza e di arrivo) al centro delle sue analisi e riflessioni e mostra come, in particolare nel mercato editoriale americano, ma non solo, prevalgano le strategie traduttive che tendono a nascondere il fatto che il nuovo testo che si legge in inglese è una traduzione, ma un testo scritto direttamente in inglese. D’altronde, fa parte dei cliché della critica letteraria dire che una traduzione è tanto più riuscita quanto più il testo tradotto che leggiamo sembra essere stato scritto nella lingua di arrivo. È evidente che ogni traduzione è una forma di addomesticamento, cioè un “portare a casa” il testo, farlo parlare con una lingua non sua, facendogli anche assumere le “abitudini” retoriche e stilistiche della cultura di arrivo. Così facendo c’è il rischio – ed è su questo che Venuti insiste in un libro che è di storia dell’idea di traduzione, di linguistica, ma anche di politica e di etica – che l’addomesticamento necessario diventi una operazione di annullamento dell’altro, di nascondimento delle specificità culturali del testo originale, a volte perfino della forza dirompente e innovativa rispetto alle norme consolidate che spesso caratterizzano le opere letterarie. Una struttura sintattica particolarmente articolata (pensiamo, ad esempio, al Decameron di Boccaccio) potrà risultare troppo complessa per le abitudini linguistiche di un americano medio di oggi, abitudini alle quali il mercato editoriale è ovviamente particolarmente sensibile. Così nella traduzione si privilegerà quella presunta esigenza del lettore, inserendo segni di interpunzione inesistenti nell’originale e frantumando la sintassi. Lo stesso vale per le espressioni idiomatiche, i proverbi o il lessico, che potrebbe risultare offensivo o troppo volgare per le norme e le convenzioni dominanti in quel momento: ci sarà un adeguamento al lettore a scapito del portato del testo originale, che diventerà così oggetto di un atto di imperialismo culturale: un’appropriazione violenta e sterile e non un’accoglienza feconda. In questo processo di adeguamento il traduttore dovrebbe diventare invisibile e la versione trasparente, perché si deve dare l’illusione che il nuovo testo non sia un testo tradotto, quindi riscritto e manipolato, ma scritto nella lingua di arrivo.

Anche per questa presunta invisibilità i traduttori sono stati le cenerentole del mondo dell’editoria: il loro nome, ancora oggi in molte pubblicazioni, compare a caratteri minimi nelle pagine interne, raramente in copertina, il loro preziosissimo lavoro è sottopagato, e quasi sempre i tempi concessi dagli editori sono da catena di montaggio di inizi Novecento. Ho usato fin qui “traduttori” come neutro o inclusivo. In verità le più cenerentole delle cenerentole nel mondo editoriale sono le traduttrici. Montale, è noto, chiamava Lucia Morpurgo Rodocanachi, forse con una bonaria ironia ma certo con raggelante realismo, “négresse inconnue”, schiava negra misconosciuta: Rodocanachi, traduttrice ombra, fra gli altri, di Elio Vittorini, era colei che faceva gran parte del lavoro di traduzione in modo anonimo, poi “rifinito” e firmato dallo scrittore maschio più noto e autorevole, che tra l’altro si accaparrava spesso anche la maggior parte dei proventi economici. Ma al di là di questi casi, che non sono certo insoliti, al punto che l’utilizzo di pseudonimi maschili o dell’anonimato è pratica frequente nella storia delle traduzioni fatte da donne, è significativo un dato che riprendo dal recente libro di Silvia Pareschi, Fra le righe. Il piacere di tradurre (Laterza 2024), e sul quale tornerò in chiusura: in Italia chi svolge la professione di traduttore è per l’85% donna. Più che di traduttori verrebbe giustamente da usare, come fa peraltro Pareschi nel suo libro, il femminile sovraesteso di traduttrici.

Questa invisibilità dei traduttori e delle traduttrici, come scrive Michele Sisto in uno dei saggi che compongono il ricco volume La donna invisibile. Traduttrici nell’Italia del primo Novecento (a cura di Anna Baldini e Giulia Marcucci, Quodlibet, 2023) non riguarda solo la loro presenza/assenza nelle strategie traduttive, “non è solo testuale, ma anche sociale. A differenza dell’autore, che nella modernità gode di un capitale simbolico rilevante”, la presenza di chi traduce “è generalmente trascurabile e trascurata non solo nella sfera pubblica, ma anche nel mondo più ristretto di coloro che si occupano di letteratura” (p. 35). Il problema non è tanto di mettere in copertina il nome della traduttrice o del traduttore, ma piuttosto di comprendere e valorizzare il ruolo che hanno avuto e hanno come mediatori e mediatrici culturali forti nel processo di formazione di una cultura letteraria nazionale. E per fare questo, e farlo in modo che sia scientificamente proficuo, diventa indispensabile uno studio delle loro biografie intellettuali, un lavoro di indagine che parta dagli archivi delle case editrici, dagli epistolari, dalle riflessioni sul tradurre, a volte esplicitate a nota dei libri pubblicati o in saggi, oltre che dalle strategie traduttive adottate, dal loro stile. Ed è quanto è stato fatto, nel volume curato da Anna Baldini e Giulia Marcucci, da dodici ricercatori e ricercatrici che in altrettanti capitoli, con il rigore degli studi di storia dell’editoria e l’impianto metodologico della sociologia di Pierre Bourdieu, hanno dato un importante contributo alla ricostruzione delle traiettorie di traduttrici italiane e, più in generale, al campo letterario nel suo complesso dalla fine dell’Ottocento alla seconda guerra mondiale. In questo periodo, scrive Anna Baldini nell’Introduzione al volume, “le donne che traducono sono state protagoniste di due importanti processi di trasformazione storica. Innanzitutto, in questi decenni l’attività traduttiva ha assunto le caratteristiche di una professione, per quanto scarsamente istituzionalizzata; allo stesso tempo, il lavoro intellettuale delle donne ha cominciato a perdere i tratti della episodicità (…) per diventare un fenomeno diffuso” (p. 8). Quanto questo sia vero risulta evidente leggendo le traiettorie di personalità ben note come Lavinia Mazzucchetti, Alessandra Scalero, Ada Prospero, Natalia Ginzburg, Gabriella e Giovanna Bemporad, ma anche forse meno conosciute come Ebba Atterbom, Ada Salvatore, Olga Malavasi Arpshofen, Rosina Pisaneschi, Maria Martone, che non solo hanno tradotto e reso così disponibili per i lettori italiani testi all’epoca recentissimi come le opere di Thomas Mann, Virginia Woolf, Sherwood Anderson o traduzioni integrali di classici come il Tristram Shandy di Sterne, ma hanno sollecitato la loro traduzione, svolgendo quel preziosissimo lavoro di scouting, a volte di direzione di collane, e di critica essenziali per la crescita di una cultura letteraria che non sia sterilmente chiusa e autoreferenziale.
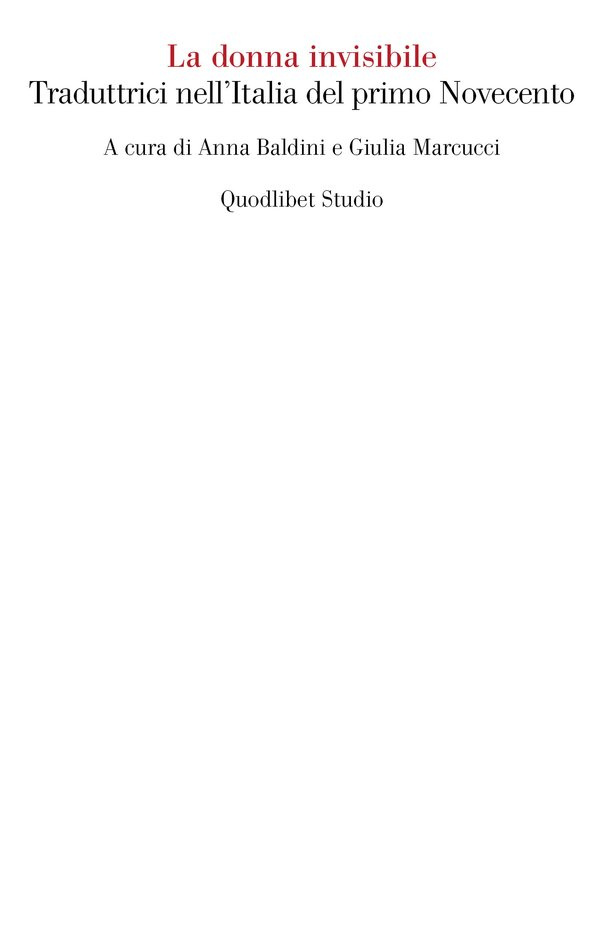
Quanto sia feconda per la ricostruzione del campo letterario e della storia della letteratura italiana una maggiore considerazione del ruolo che hanno giocato le traduttrici, non solo nelle scelte testuali, ma anche più in generale nel rapporto dinamico che hanno permesso di stabilire fra la letteratura in lingua italiana e quelle straniere, è testimoniato anche da un altro ricco e corposo volume collettaneo uscito di recente e che copre un ampio arco temporale che va dal secondo Quattrocento al Novecento: Women and Translation in Italian Tradition, curato da Helena Sanson (Garnier 2022). Solo per dare in modo cursorio un’idea della vastità degli ambiti coperti dal volume, si va dal capitolo firmato da Luca Zipoli su Antonia Pulci (1452-1501, prima donna traduttrice italiana la cui opera è stata pubblica) e sulla sua traduzione/adattamento dell’agiografia teatrale di Santa Domitilla, a quello di Eleonora Carinci sulla versione in volgare dell’orazione dello pseudo-Isocrate A Demonico della poetessa cinquecentesca Chiara Matraini, allo studio di Alessandro Cabiati sulla radicale illuminista Gioseffa Cornoldi Caminer e sulle sue traduzioni di opere a favore dell’emancipazione femminile e dell’uguaglianza nella Venezia di fine Settecento, fino a quello di Andrea Romanzi sulla traiettoria di Fernanda Pivano come influentissima mediatrice culturale fra Americana e Italia nella seconda metà del Novecento.
Questi volumi costituiscono un prezioso contributo a quella che Anthony Pym ha chiamato “l’archeologia della traduzione”, il tentativo cioè di ricostruire come la pratica e quindi la nozione stessa di traduzione si è modificata nel corso della storia. In questa prospettiva va almeno richiamato qui un altro prezioso volume, Donne in traduzione, uscito nel 2018 da Bompiani a cura di Elena di Giovanni e Serenella Zanotti, che raccoglie saggi di studiose e scrittrici di tutto il mondo, come Susan Bassnett, Sherry Simon, Emily Apter, ma anche italiane come Chiara Elefante, Emilia Di Martino, Franca Cavagnoli ecc., che hanno contribuito al dibattito scientifico, linguistico e politico sulla traduzione da una prospettiva di genere.
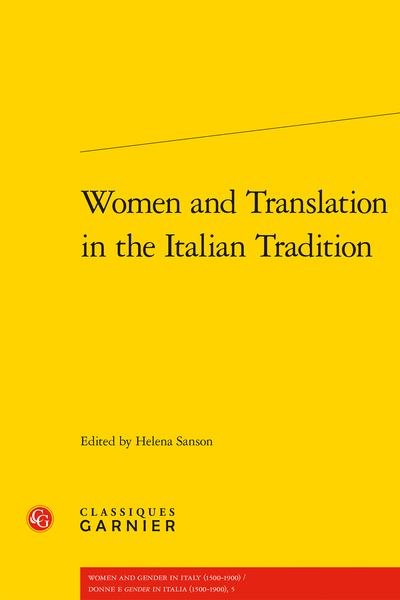
Oggi, fortunatamente, la figura di chi traduce gode di una visibilità certo molto maggiore. Si possono ascoltare nelle fiere del libro, nei festival della letteratura e della traduzione, nelle giornate dedicate alla traduzione, nelle interviste su quotidiani e televisioni, nei social. Anche l’editoria sembra essersi accorta di questa nicchia di mercato. Così negli ultimi anni diverse importanti traduttrici hanno potuto raccontare il proprio lavoro in volumi in cui la narrazione autobiografica del proprio percorso di formazione professionale si affianca spesso a una profonda e argomentata riflessione sull’atto stesso del tradurre. Antoine Berman, insieme a Venuti uno dei nomi sempre citati quando si parla di traduzione, insisteva sulla necessità di sostituire l’espressione teoria della traduzione con quella di riflessione sull’esperienza del tradurre, legando così indissolubilmente l’aspetto teorico alla esperienza viva del fare. Berman la chiama traductologie. Molti dei libri pubblicati in questi anni e scritti da alcune delle traduttrici editoriali più autorevoli in Italia sono chiari esempi di questo connubio essenziale di esperienza e riflessione, che si può ricondurre alla traduzione anglosassone del personal essay: fra gli altri, sapendo di far torto a molte, Franca Cavagnoli, La voce del testo (Feltrinelli 2010), Susanna Basso, Sul tradurre (Bruno Mondadori 2010) o l’agile raccolta curata da Ilide Carmignani e Stefano Arduini, L’arte di esitare (Marcos y Marcos 2019), con scritti di altre traduttrici importanti come Yasmina Melaouah, Renata Colorni, Ena Marchi, Adriana Bottini, Anna Ravano, Delfina Vezzoli, Claudia Zonghetti e le stesse Basso, Cavagnoli e Carmignani.

A questi si aggiunge ora il libro godibilissimo e ricco di interessanti riflessioni Fra le righe. Il piacere di tradurre, di Silvia Pareschi, una fra le più note traduttrici di narrativa angloamericana e britannica, che ha restituito in italiano scrittori e scrittrici come Jonathan Franzen, Don de Lillo, Cormac McCarthy, Zadie Smith, Sylvia Plath. Tradurre obbliga a prestare attenzione ai dettagli, a indugiare fra le righe e ai sensi obliqui della lingua; e proprio partendo dalla descrizione di esperienze di traduzione, quindi con riferimenti a problemi testuali concreti, Pareschi accompagna il lettore a riflettere su temi centrali della professione come il rapporto oggi attualissimo fra traduzione editoriale e l’intelligenza artificiale, il ruolo della traduttrice all’interno della filiera editoriale, la traduzione collaborativa, la questione della traduzione dei dialetti e delle varianti regionali, la ritraduzione dei classici. Pareschi affronta questi temi con competenza, indubbia felicità di scrittura e l’entusiasmo di chi sente il bisogno di raccontare un’esperienza vissuta appieno. Una narrazione autobiografica ricca di incontri fecondi con autori spesso disponibili a collaborare con chi sta cercando di dare loro una nuova voce, come nel caso di Franzen, e con altre importanti traduttrici come Marisa Caramella (editor Einaudi e traduttrice di Erica Jong, Alice Walker, Charles Bukowski…) o Anna Nadotti (voce italiana fra gli altri di Amitav Ghosh e Antonia Susan Byatt) che, come gli artigiani di un tempo, avevano preso a bottega la giovane Silvia Pareschi e avevano insegnato l’arte del tradurre: le avevano insegnato a usare gli attrezzi del mestiere, ma soprattutto l’umiltà, la capacità di ascolto, la pazienza, la tenacia e la necessità di fare esperienza della lingua come cosa viva. Perché, come diceva Anna Nadotti in un seminario dal titolo Il traduttore come giardiniere tenace e frequentato da Pareschi proprio all’inizio del suo percorso di formazione, “Un libro è davvero come una pianta che va annaffiata e protetta e poi lasciata crescere, lo è sia che lo si scriva, sia che lo si traduca” (p. 4).
Anna Baldini e Giulia Marcucci (a cura di) La donna invisibile. Traduttrici nell’Italia del primo Novecento, Quodlibet, Macerata 2023.
Silvia Pareschi, Fra le righe. Il piacere di tradurre, Laterza, Bari 2024.
Helena Sanson (ed.) Women and Translation in Italian Tradition, Garnier, Paris 2022.
In copertina, Sulking, Edgar Degas French ca. 1870.







