Un futuro senza crescita?
Ho iniziato a leggere il libro di Herman Daly, Verso un’altra economia. Scritti per un futuro sostenibile (a cura di Giandomenico Scarpelli, Carocci 2023) dal capitolo 23 (un vecchio vizio, questo di cominciare a metà, o magari alla fine, ma so di non essere il solo). Bene, comunque il capitolo 23 si intitola “Cambiamento climatico ed errori macroeconomici”; un titolo promettente, e in effetti queste pagine mordono, fanno anzi un po’ paura. Perché gli errori macroeconomici non li fanno dei novellini, ma degli economisti di primissimo piano, gente che poi avrebbe preso il Nobel. Sentite per esempio che cosa diceva William Nordhaus nel 1991, a proposito delle politiche da attuare per contrastare il cambiamento climatico: “L’agricoltura, che è la parte dell’economia sensibile ai cambiamenti climatici, rappresenta solo il 3 per cento della produzione nazionale. Ciò significa che non c’è alcuna possibilità che essa abbia un effetto molto grande sull’economia degli Stati Uniti”. Punto. Ora, vero che nel 1991 la scienza del clima non aveva ancora raggiunto le certezze che oggi abbiamo: l’Intergovernmental Panel on Climate Change era stato costituito solo da 3 anni, e il suo primo rapporto uscì nel 1990. Tuttavia, ammesso un certo grado di incertezza sulla dimensione del fenomeno, ciò che indigna giustamente Daly è l’argomentazione messa in campo da Nordhaus per minimizzare il problema: solo il 3 per cento. Vero. Ma la produzione agricola non può essere paragonata a qualsiasi altro “pezzo” della nostra economia, perché senza agricoltura non si mangia. Nel gergo degli economisti, questo si dice così: la domanda di prodotti agricoli è particolarmente anelastica. Il che vuol dire che una consistente riduzione dell’offerta spingerebbe i prezzi alle stelle. A quel punto l’agricoltura non sarebbe più il 3 per cento dell’economia, potrebbe diventare il 30, o magari il 50 per cento! Ne seguirebbe un enorme trasferimento di ricchezza da tutti i settori verso l’agricoltura. Possibile che questi geni dell’economia non ci abbiano pensato? Come si spiega la loro cecità?
Questo è uno dei due punti centrali del libro di Daly: il pensiero. L’altro è, ovviamente, il fatto: cioè come cambiare l’economia del mondo per renderla sostenibile. Ma il punto sul pensiero è forse (almeno per me) ancora più interessante, perché in queste pagine si misura e si disseziona il pernicioso radicamento – nella testa degli economisti, e nella testa dei politici – di questo concetto: la CRESCITA innanzi tutto, la CRESCITA è il sommo bene. E pertanto, tutto ciò che minaccia la crescita è il sommo male. Ma fermiamoci un momento a riflettere: crescita di che cosa? Del famoso PIL, il prodotto interno lordo.
Ora, i lettori più esperti mi scuseranno, ma in due parole lo devo dire, che cosa è il PIL. Il fornaio compra la farina (100 euro) e la legna per il forno (80 euro). Impasta, cuoce e dispone il pane sugli scaffali del negozio. Vende poi il tutto a 300 euro. Ciò significa che ha prodotto un “valore aggiunto” di 300 – 180 = 120 euro. Il suo lavoro e l’uso del forno (che sarebbe il capitale), hanno “aggiunto” 120 euro ai 100 di farina e agli 80 di legna. Bene, quei 120 euro sono un pezzettino del PIL: il PIL è la sommatoria di tutti i valori aggiunti prodotti nel gran corpo dell’economia nel corso di un anno. Questo vale naturalmente anche per chi sta a monte come per chi sta a valle del fornaio. Il mugnaio compra il grano dall’agricoltore e “aggiunge” al valore del grano il suo lavoro (30 euro) e il servizio del mulino (altri 30), per cui compra il grano a 40 e vende la farina a 100: valore aggiunto 60. Veniamo ora al caso, che è cruciale per il nostro ragionamento, di una miniera, per esempio una miniera di magnetite, un minerale da cui si ricava il ferro. La società mineraria usa energia (20 euro) e acqua (altri 10) ai quali “aggiunge” lavoro (50 euro) e macchine, cioè capitale (60). Vende quindi a 140. Uno legittimamente si può chiedere: ma la magnetite è gratis? La risposta degli esperti di contabilità nazionale (e di quasi tutti gli economisti) è sì: la magnetite è un “dono” che ci fa la Terra. Concludendo: la contabilità nazionale, e quindi il PIL, non tiene conto del fatto che, nel momento stesso in cui arricchisce noi di minerali (di tutti i minerali: petrolio, litio ecc.), la Terra si impoverisce di altrettanto: il riciclo mitiga il problema, non lo risolve. Ma non è questo il solo modo in cui la Terra si impoverisce; costantemente e (fino a qualche decennio fa) impercettibilmente. Si impoverisce per il consumo del suolo a vantaggio di città e infrastrutture, per il peggioramento della qualità dell’aria e dell’acqua, per il drastico calo della biodiversità, e per molti altri motivi. Come gli economisti non hanno “modellizzato” l’uso delle risorse naturali che stanno a monte del processo economico, così non hanno modellizzato ciò che succede a valle: scarti gassosi (come l’anidride carbonica), liquidi (come quelli che vanno a finire nelle fogne), solidi (come la plastica), energetici (dispersioni di calore). Detto nei termini della termodinamica, l’economia usa risorse a bassa entropia e rilascia scarti ad alta entropia: un processo che non si può invertire, una barriera fisica contro la quale ogni sogno di “crescita infinita” è destinato ad infrangersi.
Proviamo a immaginare un paragone: Le élite del mondo sono a capo di un aeroplano, che contiene tutta la popolazione della Terra. Hanno ovviamente un cruscotto con i vari strumenti che gli permettono di controllare il volo. Esse seguono con molta attenzione il tachimetro, che segnala la velocità (questa sarebbe la crescita), ma – sorpresa! – non hanno una lancetta che indichi quanto combustibile rimane nel serbatoio (questa sarebbe la capacità della Terra di assorbire gli effetti dell’economia umana). Fino a quando l’impatto dell’umanità sulla Terra era trascurabile, diciamo fino al 1850, questa mancanza poteva anche passare. Ma in seguito molti segnali, segnali gravissimi, sono passati inosservati a causa di questo difetto di strumentazione: dal Great Stink che colpì Londra nel 1858 (l’aria era diventata così mefitica che tutto il Parlamento dovette sloggiare dalla città) fino alla ormai tragica resistenza agli antibiotici: ogni confezione di antibiotici che viene prodotta genera un aumento del PIL, ma non genera da nessuna parte, negli schemi di contabilità nazionale, una riduzione della nostra capacità di combattere le malattie batteriche. Quando uso la parola “inosservati” non voglio dire che la gente non se ne accorge – in effetti se ne accorge benissimo – voglio dire che gli economisti non se ne accorgono: i loro modelli, il loro modo di rappresentare l’economia è rimasto cieco di fronte ai colpi sempre più evidenti che l’attività umana sferra contro la stabilità della Terra e dell’umanità in quanto specie biologica. Onde la crescita come sommo bene.
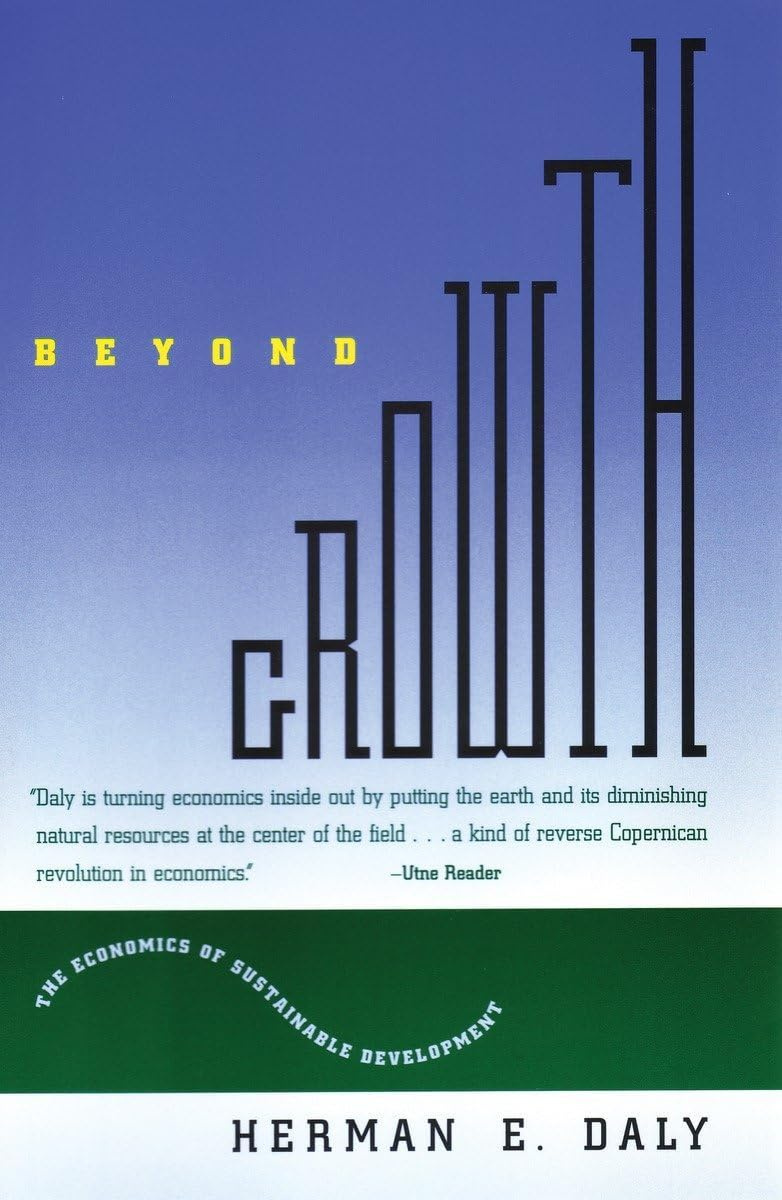
Qui, nell’analizzare il perché della “resilienza” dell’idea di crescita, l’analisi di Daly si fa, a mio giudizio, particolarmente acuta. Nessuno crede che gli economisti abbiano tanta influenza sul mondo da imporre la propria visione a tutte le classi e a tutti gli stati. Il fatto è che la crescita “piace” a entrambe le classi sociali che sono emerse più forti dalla prima rivoluzione industriale: quella dei capitalisti e quella dei lavoratori (trovate queste analisi nel primo capitolo del libro). Esse sicuramente si azzuffano sulla ripartizione del valore aggiunto, ma in ogni modo un valore aggiunto più grande facilita la pace, o almeno la tregua sociale, perché a fine anno ognuno può dire di avere “qualcosa in più”. Certo; ma non si afferra che il “qualcosa in più” di fine anno va confrontato con il “qualcosa in meno” (non contabilizzato) che tocca già noi oggi, e che toccherà con molta maggior forza i nostri figli fra venti o trent’anni. “La crescita – dice Daly a p. 140 – offre la prospettiva della prosperità per tutti con il sacrificio di nessuno”. Ma è una falsa promessa, frutto di una misurazione fallace.
Herman Daly – che ci ha lasciati nel 2022 – è stato un radicale. Ha pagato questo suo radicalismo con un decennio e più di ostracismo, non tanto velato, dal mondo accademico. Soltanto negli ultimi tempi è tornato di moda, sull’onda della crescente consapevolezza riguardo ai pericoli del riscaldamento globale (accordi di Parigi ecc.). E noi dobbiamo a Scarpelli, il curatore del libro, la prima raccolta dei suoi scritti disponibile in italiano. Il suo radicalismo lo ha portato a sostenere due concetti eretici. Primo, la grandezza del PIL (e quindi la crescita) non è, non deve essere un obiettivo, perché il modo migliore di concepire il PIL è che si tratta di un COSTO. Il costo di mantenere in piedi tutta la baracca dell’economia. Provo a ridurre la cosa ai minimi termini. Scaldo casa mia con una caldaia a gas. Consumo 1800 metri cubi di gas e spendo 2000 euro l’anno. L’azienda fornitrice “produce” quei 1800 metri cubi che consegna a me. Una buona parte dei 2000 euro che ricava sono valore aggiunto, e quindi PIL. Il mio scopo non è – ovviamente – aumentare quella spesa: la mia aspirazione non è di passare da 2000 a 3000, vorrei invece, se possibile, passare da 2000 a 1000, mantenendo lo stesso livello di riscaldamento. Questo lo posso ottenere utilizzando una pompa di calore invece di una caldaia a gas, perché la pompa di calore è tre volte più efficiente della caldaia a gas. Ciò implica, nel breve periodo, un aumento del PIL, perché si deve costruire una pompa di calore in più (e rottamare una caldaia), ma nel lungo periodo si avrà una riduzione del PIL, per effetto della riduzione del consumo di gas. Nelle parole di Daly, dobbiamo cercare di ridurre il flusso di risorse (il “throughput”) che attraversa la nostra economia, dal momento in cui prendiamo cose dalla Terra fino al momento in cui restituiamo ad essa scarti inquinanti.
La vicenda di Daly mi ricorda quella di Stefano Fenoaltea, un eccellente economista italiano con il quale ho avuto la fortuna di collaborare. Anche Fenoaltea – da una prospettiva diversa, quella della storia economica – formulò critiche radicali al concetto di PIL, e lo dichiarò del tutto inidoneo a servire da indice dello sviluppo economico di lungo periodo. Nemmeno a lui arrise il successo, e gli storici economici si affaticano ancora a proiettare indietro nel tempo, fino all’anno Mille e oltre, le misure del PIL secondo i criteri attuali. Che sono poi i criteri dettati da alcuni economisti americani dell’immediato dopoguerra: Stefano argomentava in modo inoppugnabile che tante assurdità insite nel calcolo del PIL si spiegano se facciamo caso alla data e al luogo di nascita del concetto.
Lo “stato” che Daly ci propone è il cosiddetto “stato stazionario”. Fermiamo la crescita di popolazione e di capitale, riduciamo il flusso di risorse che attraversa l’economia, miglioriamo la qualità della vita utilizzando il minimo di risorse indispensabile. Una soluzione già proposta, 150 anni fa, da John Stuart Mill, il famoso, e per molti versi inascoltato, economista inglese. Il quale non pensava affatto (e non lo pensa Daly) che si dovesse fermare il progresso: il progresso continua, la scienza, la tecnologia, la cultura e il benessere avanzano, ma non cresce il flusso di risorse che viene utilizzato (e che contribuisce a creare entropia nel sistema Terra).
È questa la soluzione definitiva che metterebbe al sicuro l’umanità? No. Nel lungo periodo, diceva Keynes, saremo tutti morti. Questo è letteralmente vero. Ma più si “cresce” (nel senso negativo che ho spiegato sopra, cioè in termini di uso di risorse e di produzione di scarti) più si avvicina il momento dell’impatto con la finitezza del sistema Terra, cioè con il fatto che la Terra ha una massa, una dimensione finita, e una capacità finita di assorbire le conseguenze della nostra crescita economica. Nelle parole di Daly: dobbiamo “rappresentare il sistema macroeconomico come un sottosistema aperto dell’ecosistema naturale finito” (p. 167). Una crescita zero rappresenta un ragionevole compromesso, che permetterebbe all’umanità di spingere in là – molto in là – il momento del redde rationem.
È questa una soluzione che si può proporre ai paesi che hanno un reddito pro capite che è un quinto o un decimo di quello europeo? No, certamente, Daly non lo crede. Nessuno vuole condannare i poveri alla povertà. Ma dobbiamo metterci d’accordo su un percorso, un percorso che ci porti, nel più breve tempo possibile, a cessare l’incremento del throughput. L’obiettivo è, per noi europei e per gli americani del Nord, a portata di mano. Ci vorrà di più per la Cina e per l’India. Ancora di più per l’Etiopia e per il Niger. Bisogna però che concordiamo sul percorso, e che i paesi ricchi aiutino, nel loro stesso interesse, quelli poveri. È quello che si sta facendo, con fatica e con pazienza, con successi e sconfitte, nelle negoziazioni relative agli accordi di Parigi sul clima, l’ultima delle quali si è tenuta nel gennaio di quest’anno a Dubai.
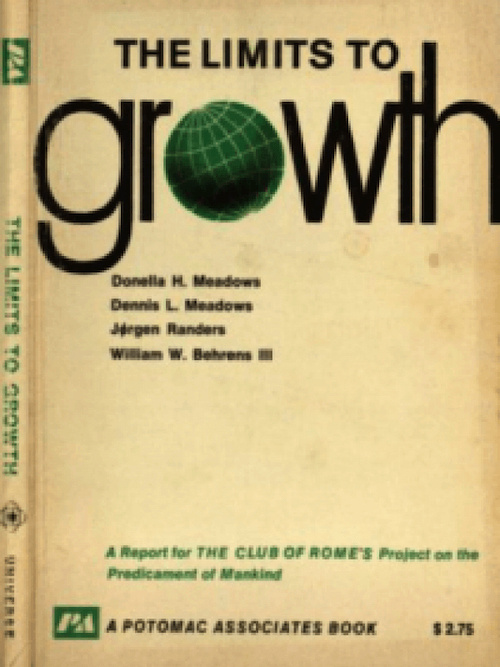
Ciò detto, voglio aggiungere un ragionamento mio, che non ho trovato nel libro di Daly, ma che si incastra bene nel suo schema. La crescita del PIL potrebbe anche continuare, ma a patto che il throughput si arresti. Questo è possibile, perché vi sono componenti del PIL, come per esempio i prodotti dell’arte (musica, pittura, letteratura…) e molti prodotti della scienza, che hanno un impatto minimo sull’uso di risorse. Si potrebbe allora a ragione parlare di sviluppo, piuttosto che di crescita (questo suggerimento lessicale è di Daly). Andrebbe trovato però al più presto un indicatore sintetico del throughput, cioè un numero che riassuma la quantità di risorse che “passa attraverso” l’economia e che di tanto riduce la capacità della Terra di sostenerci. Questo indicatore dovrebbe essere il frutto del lavoro congiunto di ingegneri, biologi, climatologi, fisici, economisti e statistici. A quel punto, l’obiettivo diventerebbe RIDURRE il valore del nuovo indicatore. Si potrebbe contestualmente definire un “PIL buono” (che non impatta sulle risorse) e un “PIL cattivo”, allo stesso modo in cui, in medicina, si parla di “colesterolo buono” e di “colesterolo cattivo”.
Giandomenico Scarpelli, il curatore, oltre a scegliere con intelligenza i contributi che sono raccolti nel libro, ci fornisce una introduzione sapiente e impegnativa. Una introduzione che ci guida attraverso la genesi delle idee di Daly (interessante l’esperienza in America Latina, l’impatto con la povertà), le sue alterne vicende accademiche (avvincente l’incontro-scontro con l’altro luminare dell’economia ecologica, Nicholas Georgescu-Roegen, un signore dal carattere francamente insopportabile), e traccia una storia ragionata dell’incontro fra economia ed ecologia, dal famoso rapporto scritto nel 1972 dal MIT per il Club di Roma (The Limits to Growth) fino ad oggi. Il curatore, infine, soppesa la stessa logica interna del pensiero di Daly. Se volessi approfondire rischierei di entrare in argomenti troppo tecnici. Basti al lettore sapere che il termine “stato stazionario” si può declinare in parecchi modi diversi. E che Scarpelli è molto attento a distinguerli, e non risparmia al suo amato Herman Daly qualche scappellotto. Per saperne di più, leggetevi il libro.







