Nuove alleanze / Butler e Stengers: la sfida di Gaia
Gaia è un problema. Di più: è una sfida, come l’ha definita Bruno Latour in un libro del 2015, pubblicato in Italia l’anno scorso, intitolato significativamente La sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico (Meltemi). Meglio ancora: Gaia è una provocazione. Provoca il pensiero, abbatte le divisioni disciplinari, scuote la filosofia. Perché le questioni che essa pone sono inscindibilmente ontologiche, epistemologiche e politiche: un intreccio in cui tutti i confini sfumano; non solo quelli tra i saperi ma anche quelli tra umano e non umano, organico e inorganico, natura e cultura.
Con questa sfida si sono recentemente cimentate due filosofe, Isabelle Stengers e Judith Butler, che hanno sempre percorso vie di ricerca autonome e, anche sul rapporto uomo/ambiente, adottano approcci distinti. Eppure, leggendo le loro ultime pubblicazioni, le parole dell’una sembrano trovare un’eco singolare nelle pagine dell’altra. Una parola, in particolare, risuona nei pensieri di entrambe: «alleanza».
La nozione ricorre nel titolo di un’importante opera di Judith Butler, L’alleanza dei corpi (Nottetempo 2019), che riflette sulle forme di resistenza alla precarizzazione, nonché nel suo ultimo libro edito in Italia, Due letture del giovane Marx (Mimesis 2021) a cura di Didier Contadini. Ma ricorre anche nel titolo del volume che, esattamente cinquant’anni fa, diede la fama a Isabelle Stengers, il celebre La nuova alleanza, scritto col premio Nobel Ilya Prigogine. E ricorre ancora in un più recente libro della stessa autrice, risalente al 2008 e pubblicato quest’anno in italiano col titolo Nel tempo delle catastrofi. Resistere alla barbarie a venire (Rosenberg & Sellier) a cura di Nicola Manghi, che firma un’utilissima introduzione e una preziosa intervista finale all’autrice. Quella parola, insomma, era già presente nell’armamentario concettuale di entrambe le filosofe ma nei loro ultimi scritti brilla in modo singolare, sulla spinta di quella provocazione che ha nome Gaia. Come se questa ponesse un nodo di problemi abbordabile soltanto attraverso la costruzione di nuove alleanze; magari, perché no, anche tra autrici apparentemente lontane come Butler e Stengers.
Ma partiamo dall’inizio: chi è Gaia?
Il nome proviene dagli studi del chimico James Lovelock e della biologa Lynn Margulis, che negli anni Sessanta formulano un’ipotesi sull’omeostasi della biosfera e la battezzano così, traendo ispirazione dalla mitologia greca. Pur mantenendo l’appellativo, diverso è l’uso che ne fa Isabelle Stengers nel Tempo delle catastrofi. La Gaia che emerge da queste pagine non è quella sorta di pianeta-organismo, capace di autoregolarsi, che le interpretazioni new age hanno finito col sovrapporre all’originaria intuizione di Lovelock e Margulis. E non è nemmeno la versione scientifically correct di quella stessa intuizione elaborata dall’Earth System Sciences, l’approccio interdisciplinare con cui dagli anni Ottanta si studia il nostro pianeta nei termini della teoria dei sistemi.
La Gaia di Stengers è piuttosto il nome di un crocevia di forze cieche: un caosmos che abbiamo imparato a conoscere in tempi di crisi climatica e che, per quanto lo si riconosca, ha sempre la natura di un evento inaspettato. Pur suscettibile e implacabile, Gaia non si vendica né ci punisce perché non è intenzionale. Non è riducibile né a un inerte e passivo oggetto di studio (come vorrebbero gli orientamenti antropocentrici che collocano l’agency interamente dalla parte dell’umano) né a una compiuta e definita totalità organica (come vorrebbero gli orientamenti organicistici che subordinano le parti al tutto sulla base di una funzionalità predecisa e presupposta). Gaia è semmai un’irruzione che mette alla prova i nostri quadri teorici e costringe a pensare in modo diverso. Per esempio, a pensare la Terra come un che di animato senza farne un animale. A pensarla come qualcosa di più di un mero oggetto o insieme di oggetti, senza ritrarla romanticamente come un soggetto. A pensarla come qualcosa che è impossibile dominare verticalmente dall’alto ma con cui si può imparare a convivere muovendosi per concatenamenti orizzontali; ovvero, sperimentando nuove strategie sul campo, giocando di squadra localmente, negoziando di volta in volta confini e pertinenze. Costruendo nuove alleanze, appunto.
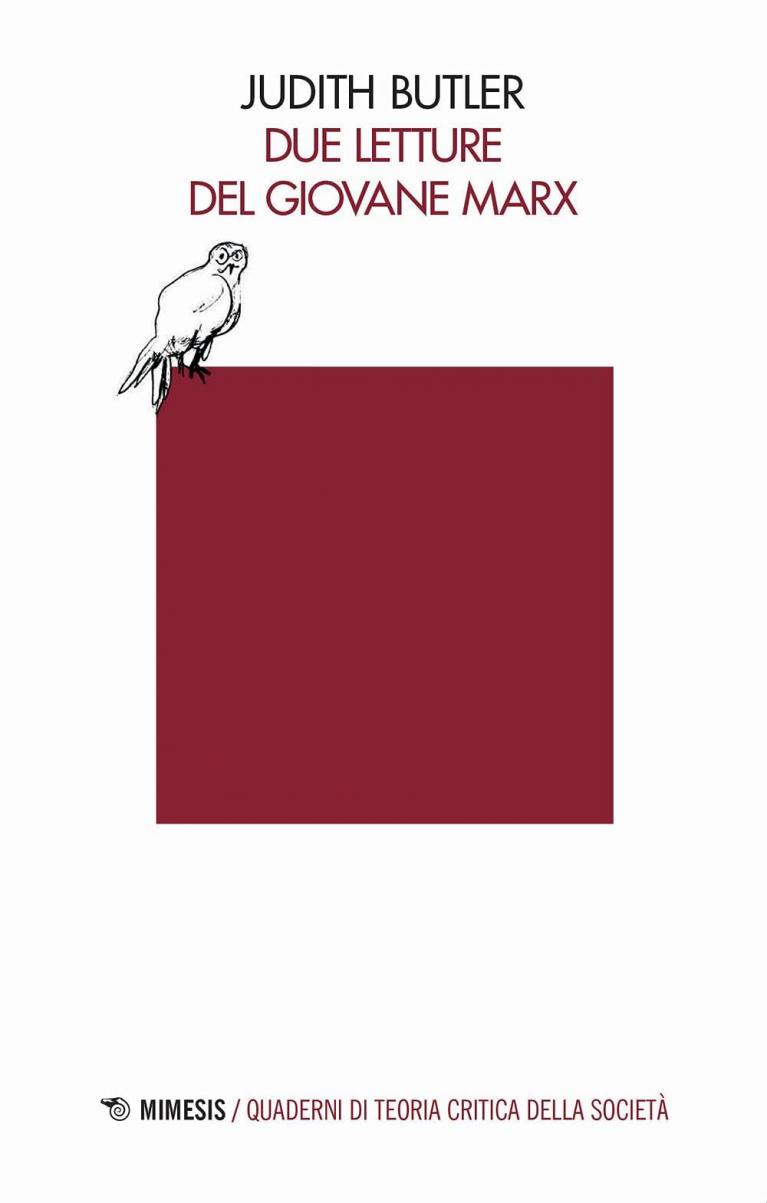
Con le medesime questioni ambientali si confronta Judith Butler in Due letture del giovane Marx, seppur in maniera indiretta, pensando attraverso gli scritti marxiani. Nel primo dei due saggi che compongono il volume, tratto da una conferenza parigina di tre anni fa, l’autrice offre una lettura dei Manoscritti economico-filosofici del 1844 di Marx volta a dare molto più spazio alla natura di quanto non ne accordino le interpretazioni tradizionali. L’obiettivo è smarcare il filosofo di Treviri da ogni forma di antropocentrismo e rinverdirne (in tutti i sensi) gli strumenti concettuali per metterli al servizio dell’ecologia. Ne emerge un Marx prospettivista, per il quale organico e inorganico sono termini correlativi, l’uno l’ombra dell’altro: è solo dal punto di vista dell’organismo umano che la natura inorganica appare tale, ossia – nell’ottica marxiana – inanimata. Più precisamente, è il lavoro umano che, trasformando la natura, la rende una cosa inerte. Ma attraverso questo lavoro, suggeriscono i Manoscritti, l’individuo diventa consapevole della propria dipendenza dai processi viventi: tale attività umana, infatti, è a sua volta resa possibile da una natura animata, da un contesto di forze materiali senza cui l’uomo neppure esisterebbe.
Le «potenze dell’animazione», come le chiama Butler, preesistono dunque al lavoro antropico, lo supportano e ne costituiscono la trama. Sono ovunque e diffuse: l’inerte è solo il resto situato che ogni attività locale, umana o non umana, lascia dietro di sé. Alla fine della sua lunga disamina, l’autrice può concludere che «quel che troviamo in Marx, in definitiva, non è la rappresentazione di una natura dominata dagli umani, ma piuttosto quella di creature umane dipendenti dalla natura». E di questa dipendenza facciamo esperienza ogni volta che ci mettiamo al lavoro, a partire dalle condizioni particolari e contingenti in cui operiamo.
Vi è qui una prima risonanza con Stengers, ossia l’idea che per approcciare la sfida di Gaia si debba partire non dalla teoria, o da grandi proclami, ma dal lavoro sul campo, da pratiche sempre determinate e circostanziate. Se infatti è nella prassi – come vuole Butler – che ci scopriamo dipendenti dai processi viventi, questa dipendenza non va però intesa come mera passività, bensì come interrelazionalità: ogni cosa è legata a ogni altra cosa in concatenamenti locali che producono equilibri precari. Riconoscersi come parte di questi concatenamenti è il primo passo per piegarne la direzione, trovare nuove sinergie, creare o trasformare legami. Qui la seconda risonanza con Stengers: si diventa soggetti davvero efficaci nell’azione – sembra suggerire Butler – solo dopo essersi spogliati da ogni presunzione arcontica, da ogni sogno di manovrare i processi naturali in modo pianificato e unidirezionale. Se immaginiamo Gaia come una grande Natura ferita, sorta di Madre terra malata la cui cura richiede una Soluzione con la «s» maiuscola, non possiamo che sentirci impotenti e restare paralizzati. Se invece intendiamo Gaia come un evento, che si dà qui e ora in processi determinati e in connessioni circostanziate, allora un piccolo gesto può fare la differenza.
Nel libro Bergson (Feltrinelli 2021) Federico Leoni, traendo spunto dal filosofo francese, delinea una «microetica dei concatenamenti» che troverebbe concordi le due autrici. Nella concezione bergsoniana la natura è continua, tutto comunica con tutto. Ma questa comunicazione, osserva Leoni, procede per grumi, per agglomerazioni. L’attività della natura organica – direbbe Butler lettrice di Marx – sedimenta minuscoli depositi inorganici che localmente fanno catena, le potenze dell’animazione lasciano dietro di sé piccoli coaguli di resti inanimati, che a loro volta diventano materia di altri processi animati. Tali concrezioni interlacciate, coi loro microequilibri, non costituiscono mai un tutto (la Natura) ma neppure sono riducibili a una mera somma di parti autonome e indipendenti l’una dall’altra. È tra le pieghe di queste nicchie, e agglomerati di nicchie, che bisogna lavorare di «alleanza», sperimentando nuove inflessioni, riarticolando malfunzionamenti, disassemblando e riassemblando. Ci si addestra così a una microetica, scrive Leoni, «incentrata non sugli esseri ma sui circuiti in cui gli esseri si producono e si concatenano, non sulle cose ma sui loro dintorni e sulle loro periferie, non sugli oggetti ma sulle linee del loro divenire e sugli incroci di queste linee».
Optare per una microetica orientata ai processi, in grado di interagire con loro e apprendere da questa stessa interazione, comporta anche rimodellare la posizione dell’intellettuale e l’uso del pensiero critico. Quale ruolo spetti a quest’ultimo nel rapportarsi a Gaia è un nodo sul quale i due libri di Butler e Stengers sembrano divergere. Come Bruno Latour in un altro volume dedicato alla questione ecologica (Essere di questa terra, Rosenberg & Sellier 2019), anche Isabelle Stengers nel Tempo delle catastrofi guarda con sospetto l’intellettuale che dall’alto denuncia i mali del mondo, a partire da quelli climatici, e demolisce con la clava supposte verità esaurendo il proprio compito nell’esercizio della critica. Apparentemente opposto è il grande elogio della critica che invece Butler tesse nella seconda delle sue Due letture del giovane Marx. In realtà le due posizioni nascondono una più profonda consonanza.
Da una parte, Stengers scrive che «non si tratta di contestare l’utilità della critica né la sua necessità, quanto piuttosto la sua identificazione con un rimedio, vale a dire anche la sua trasformazione in un fine in sé». Ben venga, invece, il pensiero critico laddove è al servizio della prassi, come nell’invito dell’autrice a «fare attenzione» e a farsi «utilizzatori», invece che meri utenti, non lasciando soltanto agli esperti la formulazione delle domande e dei problemi.
D’altra parte la critica che Butler difende non è una mera distruzione di oggetti (supposti naturali) o di verità (supposte universali), ma, come lei stessa chiarisce citando Benjamin, una «forma radicale di interazione con gli oggetti». Non il gusto della denuncia fine a se stessa, ma un diverso modo di interagire: sciogliere per riannodare diversamente. Il pensiero critico è fecondo, sembrano dunque dire le due filosofe, laddove è inteso come creazione di concatenamenti. Due diverse voci, un intento comune: tessere nuove alleanze.







