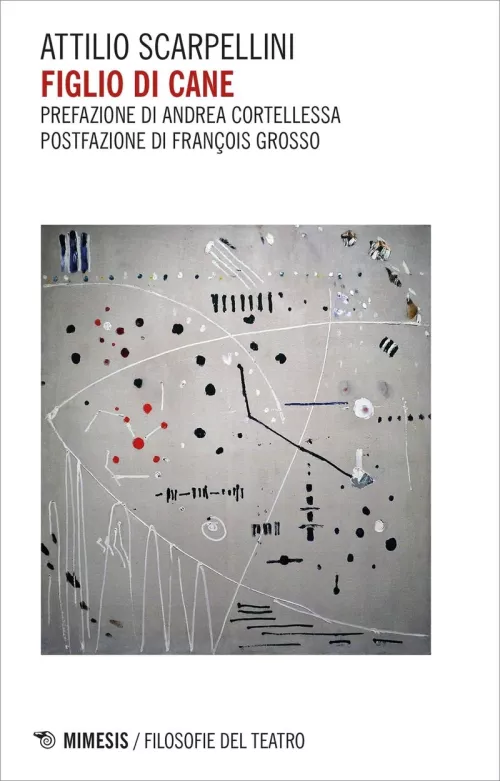Come cose. Come un cane
Vi potete perdere, se entrate a Venezia, zona San Stae, in quello che sembra uno dei tanti “Compro oro” o “Liquidazione totale” che invadono le nostre città. La vendita di tutto, il fallimento, l’esposizione dei detriti dei nostri consumi. Scoprite di essere dentro la Fondazione Prada, completamente invasa da oggetti, resti di oggetti, libri contabili, quadri vecchi, video di controllo, vecchi videogiochi, vecchi cicli e motocicli, bottoni, gioielli, cappotti, vestiti, bambole, brocche, sacchi di materiale edile, armi, mobilia, resti putrescenti di qualche party, scarpe, scaffali, tute, pezze eccetera eccetera, come un vecchio Monte di Pietà che conservi, accumuli, cataloghi per generi e specie la nostra cosizzazione, il nostro essere resi oggetti, esserci resi oggetti, il nostro reificarci, il nostro accumularci. La bellissima mostra, Monte di pietà, appunto, curata dal provocatore Christoph Büchel, non ha manifesto, né locandina, né qualcosa che la spieghi. Si offre, semplicemente, al nostro percorrerla e ci invade di cose, anche come un discorso sull’arte che sempre di più si trasforma in pura valorizzazione, riducendo alla fine l’osservatore stesso a fattore (a cosa) di un sistema eminentemente finanziario. Un manifesto, stropicciato come molte delle cose che si infittiscono in numerosi ambienti, su vari piani, su un Apecar polveroso grida: “Chiediamo un’immediata e indefinita moratoria alla Biennale d’Arte di Venezia… Vogliamo un permanente alt a questo festival di avidità e sfruttamento…”.

Ridursi a cosa. O ad animale. Mimesis, la casa editrice con sede tra Milano e Udine specializzata in libri ricercati, con collane tra il cinema e il teatro (e la filosofia e la critica sociale), in questi mesi ha pubblicato due testi che parlano di soggezione, di emarginazione, di “fuga dalla realtà”. Sono due memorie teatrali dalla seconda metà del Novecento, firmate l’una da un regista di cinema famoso, Elio Petri, l’inedito Giacobbe o Elaborazione di un’ossessione; l’altra, Figlio di cane, è un pièce di Attilio Scarpellini, voce antelucana di Radio 3, conduttore della prima rubrica di quell’emittente, Qui comincia, filosofo e critico teatrale.
Giacobbe non parla del personaggio biblico, ma rielabora uno dei capolavori di Robert Walser, quel Jakob von Gunten che fu pubblicato in Italia da Adelphi nel 1970. La pièce di Petri, scritta probabilmente a metà degli anni settanta, nello stesso periodo in cui Pasolini metteva in pellicola le umiliazioni di Salò o le 120 giornate di Sodoma come discorso sul rinascente fascismo. Traduce in dramma una storia di masochismo. Jakob, per arrivare a “essere zero”, si affida alla scuola di servitù di Benjamin Benjamenta e attraverso vessazioni che lo privano di ogni personalità si addestra a diventare un perfetto servitore. Uno “zero”, appunto, un portato del “masochismo del soggetto dentro il sociale”, come scrive in una delle introduzioni Alfredo Rossi, che colloca l’inedito, non precisamente datato, tra Salò appunto (1975) e Toto modo, firmato per il cinema dallo stesso Petri (1976). La scelta del nome Jakob, Giacobbe, non è casuale: Giacobbe nel Genesi, spiega nell’altra introduzione Roberto Chiesi, lotta di notte contro l’angelo e lo vince, affermando la libertà con cui Dio dispone dei suoi doni: “Nel romanzo di Walser, il nome assume quindi un senso di derisione perché Jakob non lotta mai ma si dispone a diventare un servo”. Servo attraverso varie umiliazioni corporee, fino a una riduzione a cosa, che avrà un finale diverso dalla romantica fuga verso l’Oriente del romanzo
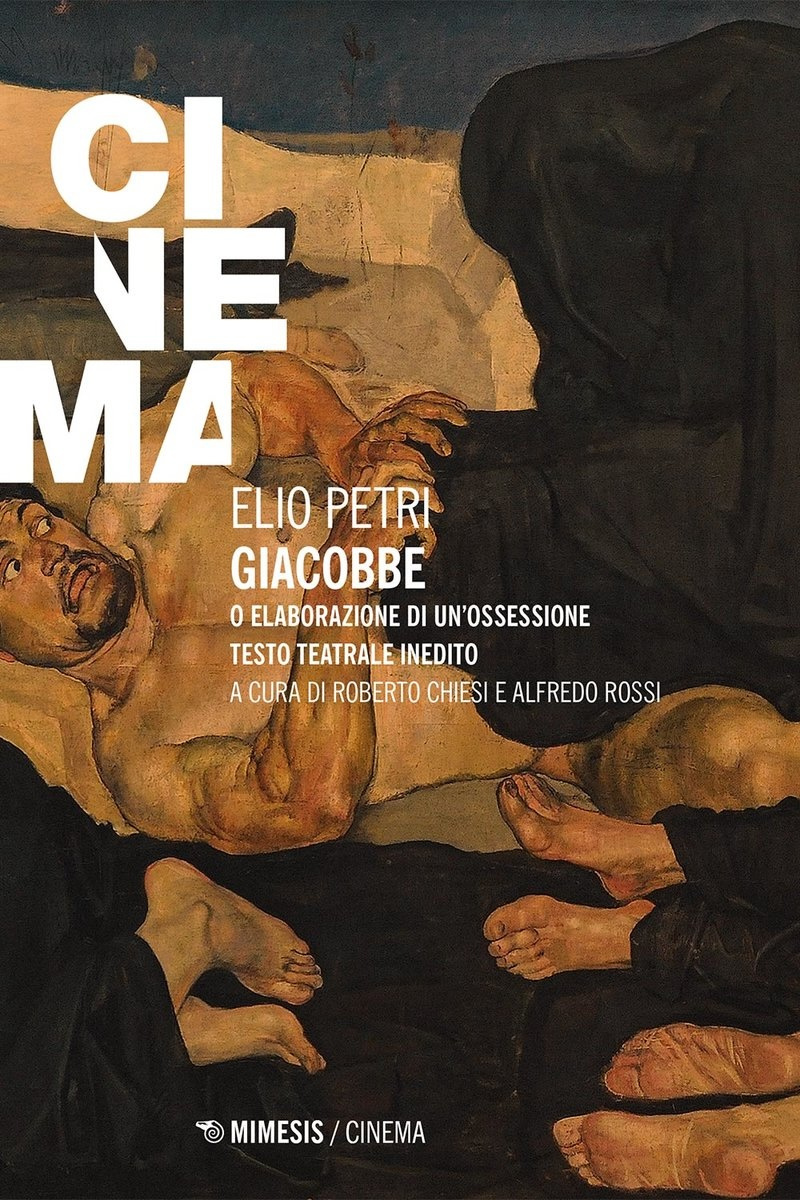
Ancora più radicale è il testo teatrale di Scarpellini, illuminato, a differenza di quello non finito di Petri, dall’aura di una bella, intensissima scrittura, che Andrea Cortellessa nella sua prefazione avvicina al mondo tagliente di Samuel Beckett. È un viaggio nella memoria, con tutti gli sbandamenti che il ricordo può avere, come dichiara l’autore: “Ad alcuni dei nostri ricordi, come ad alcuni dei nostri sogni, mancano le parole: nel film muto della memoria le immagini ci perseguitano con la loro perturbante insistenza, le parole ci sfuggono per nascondersi chissà dove”. Poi, da qualche magazzino segreto dove sono state abbandonate, certe memorie riemergono. In questo caso a rinfocolare un episodio di fine anni settanta è stata la lettura di un racconto di Vladimir Slepian, personaggio imprendibile, ebreo nato a Praga, vissuto in Russia ed emigrato in Francia, pittore e clochard, autore di un unico racconto, Figlio di cane appunto, pubblicato dalle Editions de Minuit sulla loro rivista “Minuit”, oggetto di interesse e di recensione da parte di Deleuze e Guattari in Mille piani.
In quel raccontino Scarpellini ha trovato le parole per ricordare l’apparizione di quell’uomo che irruppe al tavolo di un caffè parigino dove lui con alcune amiche e un amico stava bevendo e conversando, a Saint-Germain-des-Prés. Sembrava un barbone con il naso a becco d’uccello, male in arnese, forse pronto a truffare o a derubare i giovani studenti...
La data è significativa: era il 18 febbraio del 1979. Su Parigi nevicava. Gli amici stavano parlando del pericolo dello scoppio della Terza guerra mondiale, perché l’esercito cinese aveva oltrepassato il confine del Vietnam e si temeva un intervento della Russia. Slepian, che Scarpellini chiama Viktor Sclepian, immaginando che fosse un armeno, un levantino, si presenta e si offre di essere il suo cane, di portargli il giornale ogni mattina. Certo, bisogna trasformare le mani in zampe, rinchiuderle in qualcosa di simile a scarpe o comunque con coperture, e poi chissà come farà a radersi, a non sembrare selvatico, dovrebbe usare la lingua per tenere il rasoio, come la madre faceva per infilare l’ago, ma, certo, lei usava anche le mani… Allora lui, il cane, può semplicemente portarglielo, il giornale, e, evitando di radersi, mentre il giovane si fa la barba leggerglielo, da bravo animale fedele.
De-lirio, ovvero un discorso che rompe le regole del consueto ragionamento, dell’ordine compatibile del linguaggio. E un’invasione nelle chiacchiere degli studenti che ne catalizza l’attenzione, distogliendoli da ciò su cui stavano discutendo.
Commenta Scarpellini: “Quel che temo non si riesca a capire e a spiegare fino in fondo è l’estrema facilità, la romanzesca facilità con cui in quegli anni si poteva attaccare discorso con gli sconosciuti, per strada, sugli autobus, nei foyer dei teatri, sui treni, nei caffè, nelle manifestazioni di piazza, ovunque stesse ancora risuonando, prima di spegnersi nell’incomprensione più totale, il grido che dieci anni prima era stato impresso sui muri: parlate con chi vi sta accanto! Tutti avevano preso la parola, non si faceva altro che parlare, ma non tanto per comunicare qualcosa, piuttosto, per comunicare con qualcuno, il qualcosa restava misterioso, sfuggente, mentre il fitto ronzio che si sprigionava dai corpi inclinati uno verso l’altro al tavolo di un bar…”. Era “un roveto ardente di parole”.

Un roveto ardente di parole sotto la neve. La pièce teatrale vede in scena inizialmente un solo personaggio, seduto su una panchina d’inverno, AS (come Attilio Scarpellini, tra i cinquanta e i sessant’anni, ma anche un giovane di fine anni settanta). Inizia a nevicare e arriva VS, con il suo delirio. Sembra di essere in Beckett, nota Cortellessa, ma anche in Minetti di Thomas Bernhard, potremmo aggiungere, anche per quell’uso della persona reale, Minetti, AS, VS, trasformati in personaggi teatrali e quindi esposti alle oscillazioni del tempo e della memoria, resi in qualche modo emblematiche persone-personaggi.
Un cane vorrebbe essere VS, e, a un certo punto, dice la frase chiave (parla in linee che assomigliano a versi): “Mi metterei a dormire… / Qui in mezzo alla strada, sul marciapiede / Come fanno alcuni miei confratelli / … … (incomincia a sbadigliare rumorosamente) / … che sono insigni filosofi … / Appartenenti alla scuola dei cinici…”.
I cinici, che Cortellessa ci ricorda erano quei filosofi che volevano smascherare le convenzioni, le finzioni, le superfetazioni, le non verità della società ‘normale’: molto diversi dal senso che si dà oggi alla parola “cinico”, che sta per arrivista, senza principi, furbo, profittatore eccetera.
Un’ultima immagine di VS: “dal suo corpo emanava un odore che credo di poter descrivere come l’odore di chi dorme nei propri vestiti, e dico credo perché è l’odore degli uomini a cui oggi non permetteremmo mai di avvicinarsi a noi, un odore che sento oggi e non sentivo allora, quando nel mio naso c’era solo il respiro bianco della neve. Il ricordo si torce in un continuo adattamento a sé, cambia in noi, come il sogno quando cerchiamo di raccontarlo. Ogni racconto è un tradimento, ma anche il suo ultimo documento conosciuto”.

Poi ci sarà la questione del furto, di cinquecento franchi, forse non avvenuto. E lo sparire di VS, che arriva a un’esplosione fisica nel suo verbigerare, a un getto di sangue di parole artaudiano, a chiedere di non colpirlo, lui povero cane!: “… a un certo punto mi aveva detto: noi due ci assomigliamo, non trova? Lo diceva con l’aria di leggermi nel pensiero e di pensare che anche io l’avevo pensato”. Ma in cosa si potevano assomigliare lo studente borghese e l’artista marginale? In un desiderio, in quel creare insieme un continente di parole in cerca di libertà, contro il rischio della cosizzazione incombente, e dell’esplosione della guerra, nel creare, una terra di scambio, di ogni tipo di visione, anche le più assurde. Ma: “Gli avrei voluto rispondere, sì, l’ho pensato anche io, che in qualcosa ci assomigliamo. Ma tu sei un pazzo e i pazzi mi fanno paura, forse perché ho io stesso paura di impazzire”. Sé stesso in uno specchio (deformante), sé stesso come Altro, nota Cortellessa.
“Gilles Deluze e Felix Guattari hanno presentato Figlio di cane nel capitolo di Mille piani intitolato “Divenire intenso, divenire animale, divenire impercettibile”, ancora scrive AS. E riporta la notizia, probabilmente falsa, che Vladimir Slepian (non più VS) è morto di fame il 7 luglio del 1998 in una delle stradine attorno a Saint-Germain-des-Prés.
E la terza guerra mondiale? Non è scoppiata: i cinesi tornarono sui loro passi e l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti non reagirono: “La fine del mondo venne rimandata e, di rimando in rimando, è giunta notoriamente fino ai nostri giorni”.
Libri citati:
Elio Petri, Giacobbe o Elaborazione di un’ossessione, a cura di Roberto Chiesi e Alfredo Rossi, Mimesis, Milano-Udine 2024
Attilio Scarpellini, Figlio di cane, prefazione di Andrea Cortellessa, postfazione di François Grosso, Mimesis, Milano-Udine, 2024