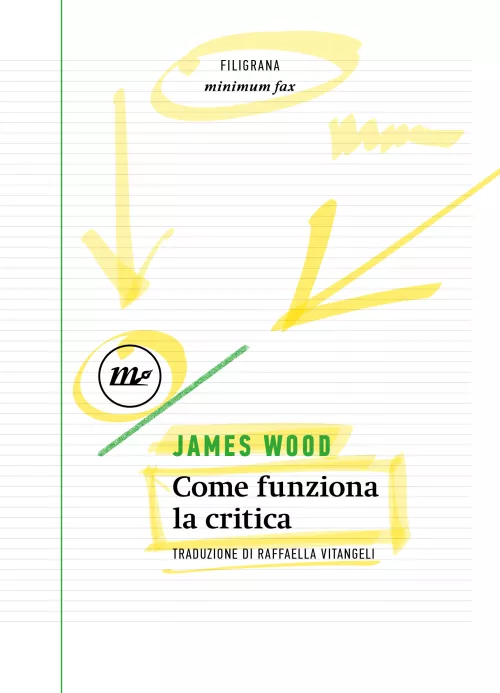Disfunzioni della critica
Non c’è argomento più trito, in campo letterario, della crisi della critica: a superarlo è forse solo la morte del romanzo. E tuttavia si continua a scrivere romanzi, a leggerli, a pubblicarli; e la critica non solo continua tenacemente a esistere, ma conosce anche inopinate fortune migrando da un campo all’altro dell’universo mediatico, come dimostra la crescente popolarità di booktuber, booktoker e bookstagrammer. Ma non mancano elementi per ritenere che nell’editoria italiana la fiducia nel valore di una critica più tradizionale non sia venuta meno. Ad esempio, la proposta da parte di Minimum fax di una raccolta di saggi di James Wood, influente firma del «New Yorker» e anche romanziere in proprio. Il titolo del volume originale (2019) suona Serious Noticing; per la versione italiana, dovuta a Raffaella Vitangeli, è stata scelta una dicitura più didascalica, Come funziona la critica, che riecheggia il titolo di un’altra raccolta di saggi, Come funzionano i romanzi, pure ripresa da Minimum fax nel 2021 dopo una precedente uscita negli Oscar Mondadori.
Fra gli autori di cui Wood parla si annoverano classici del romanzo moderno (Tolstoj, Čechov, Virginia Woolf, Joseph Roth), americani contemporanei (Paul Auster, Cormac McCarthy, Marylinne Robinson), tedeschi noti al pubblico italiano (W.G. Sebald, Jenny Erpenbeck), e anche due autori italiani di cui si è occupato a più riprese, Primo Levi e Elena Ferrante; l’eslege capitolo conclusivo (L’ora di ricreazione, corrispettivo non ineccepibile di Fun Stuff) è un ispirato omaggio a Keith Moon, il batterista degli Who.
Il saggio iniziale, che qui funge da Introduzione, è intitolato What Is At Stake When We Write Literary Criticism? Qual è la posta in gioco quando scriviamo critica letteraria? Lo spunto è un ricordo risalente agli anni di università, quando Stephen Heath, suo professore a Cambridge (benché viva da parecchi anni nel Connecticut Wood è inglese, figlio di un pastore evangelico di Durham), con il naso su un foglio, chiedeva: «Qual è la posta in gioco in questo passaggio?». La posta in gioco: suggestiva metafora. Richiama l’idea di una scommessa, di un azzardo: ciò che si può vincere, ciò che si può perdere. E poiché «azzardo» deriva dalla parola araba che significa «dado» (donde «il gioco de la zara», dell’attacco di Purg. VI), l’immagine complessiva evoca due gesti distinti e complementari: uno lento e preparatorio, il «porre» della puntata, la definizione della posta, l’altro repentino e risolutivo, il lancio dei dadi. Anche nell’atto della lettura si possono incrociare due velocità: ci sono aspetti dell’opera che si acquisiscono gradualmente, che si assimilano man mano, e altri che emergono d’un tratto, lampeggiando improvvisi. La riuscita o il fallimento di un romanzo o d’una pagina possono essere effetto di un lungo processo quanto di un’apparizione subitanea.
Ma questa è una nostra divagazione. Il punto su cui Wood insiste è la distinzione fra due idee di «posta» (Stakes 1, Stakes 2). In un caso il successo s’identifica con la compiutezza e la coerenza, nell’altro con l’incoerenza e l’incompiutezza. Per la verità l’opposizione, enunciata in apertura, non è poi sviluppata con l’ampiezza che ci si potrebbe augurare; ma non c’è dubbio che si tratti di un discrimine di grande rilievo, che interpella chiunque si cimenti nell’analisi di un testo. Per parte mia, mi sentirei di spezzare una lancia a favore dell’incoerenza e dell’incompiutezza: a condizione però che siano qualità che l’autore subisce, più che ricercarle. Le opere – per usare una frase fatta – fecondamente contraddittorie non sono quelle che nascono sotto il segno della contraddizione, ma quelle in cui l’autore si sforza di far quadrare i conti e non ci riesce, o non ci riesce del tutto, a volte rendendosene conto, a volte no. L’irregolarità, l’asimmetria, gli scompensi acquistano insomma valore in quanto esito di una resistenza della materia narrata all’impegno dell’artista. È qui che si innesca la possibilità di interpretazioni divergenti, che rendono dinamica e vitale la ricezione dell’opera.
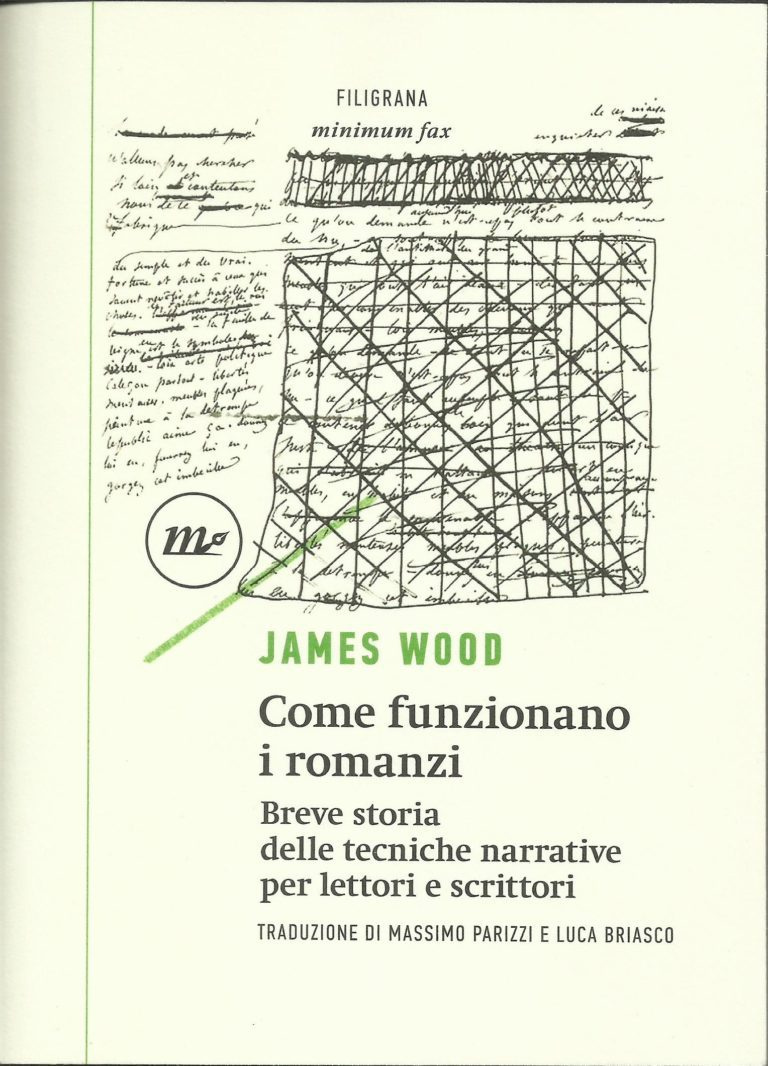
Un altro punto sul quale Wood indugia è l’idea di critica come «avventurosa condivisione», con tutto quanto di precario e spericolato, di instabile e fortunoso può significare l’aggettivo. «Quando scrivo di un romanzo o di un autore sto essenzialmente offrendo la mia testimonianza. Sto descrivendo un’esperienza e cercando di stimolare nel lettore un’esperienza di quell’esperienza». La conseguenza è duplice. Se ha ragione Henry James nel definire il compito della critica «eroicamente vicario», è però anche vero che i mezzi che il critico usa non sono qualitativamente diversi da quelli che usa lo scrittore, in particolare (ma non solo) per quanto concerne l’impiego delle metafore. Argomentando, Wood cita brani di scrittori che rivestono occasionalmente i panni del critico, quali S.T. Coleridge o Virginia Woolf; ma il discorso vuol esser valido in generale. Lo dimostra lo stesso Wood: ad esempio, quando attribuisce a Primo Levi una memoria «avida e deittica», o quando, a proposito di Tolstoj, parla di un realismo «trasformato in una sorta di substrato neutro, come l’aria»; o ancora, quando scrive che «i romanzieri dovrebbero essere grati a Flaubert come i poeti dovrebbero essere grati alla primavera: con lui tutto ricomincia di nuovo».
Un ultimo aspetto delle riflessioni di Wood che mi sento di sottoscrivere con convinzione è l’importanza attribuita ai riassunti delle trame, alle parafrasi e alle citazioni («citazioni e ri-descrizioni sono l’elemento fondante di una recensione»). Non bisogna temere di eccedere nel riprendere le parole dell’autore o nel riformulare le sue invenzioni: «mostrare, mostrare e mostrare ancora» raccomanda la prefazione alla seconda edizione di Come funzionano i romanzi (apparso nel 2008, riedito dieci anni dopo). Il nocciolo dell’esercizio della critica, in ultima analisi, consiste in un gesto ostensivo, in un invito a leggere o rileggere un autore, un’opera, una pagina. E il pensiero ritorna, inevitabilmente, alla testimonianza di Adorno circa il mai realizzato volume di Walter Benjamin sui passages parigini, che – si legge in una nota dell’introduzione di Renato Solmi a Angelus novus – sarebbe dovuto consistere essenzialmente di citazioni.
Il saggio più importante della raccolta è probabilmente Realismo isterico. Con questa espressione Wood intende designare «il grande, ambizioso romanzo contemporaneo», caratterizzato da dimensioni ingenti, sovrabbondanza di storie, azione frenetica, personaggi maniacali, ossessione per la vitalità. In questa categoria rientrano a suo avviso opere famose di Don DeLillo, David Foster Wallace, Thomas Pynchon, Zadie Smith, dove (sia pure in modi differenti) il sovraccarico sulle convenzioni del realismo produce, paradossalmente, l’effetto di eludere la realtà. Quella del realismo è per Wood una categoria centrale: tutti i capolavori della storia del romanzo possono essere considerati realistici, anche se ciascuno lo è in maniera diversa, perché infiniti sono i modi in cui un romanzo può essere, al tempo stesso, intimamente naturale e altamente artificiale. Al «realismo isterico» si contrappone per Wood il «realismo profondo», che prevede la compresenza di verosimiglianza e artificio.
Uno dei tratti distintivi dello stile critico di Wood è il frequente ricorso alle figure dell’antitesi e dell’ossimoro: basti ad esempio la definizione di Gilead di Marilynne Robinson (2004) come di «uno dei romanzi più anticonvenzionali e più convenzionalmente popolari degli ultimi tempi». Per inciso, con la Robinson – tradotta in italiano da Einaudi – Wood ha in comune la matrice religiosa, tant’è che il primo dei due romanzi che ha finora pubblicato reca il titolo The Book Against God (2003). Non stupisce che la dimensione autobiografica abbia un ruolo importante sia nella sua opera creativa, sia nella sua attività critica. «L’arte è la cosa più vicina alla vita», scrive, citando George Eliot, nella prefazione 2018 a Come funzionano i romanzi. Vicina, ma non identica: la prossimità implica per definizione un intervallo, una distanza. «E questa distanza apparentemente minima è in realtà un canyon, la grande distanza dell’artificio». Che Wood sia animato da una sorta di sensibilità interstiziale è confermato dall’apparente divagazione conclusiva sul batterista degli Who, quel Keith Moon che «era la batteria non perché fosse tecnicamente il migliore, ma perché la sua gioiosa frenesia centimana e tentacolare lo faceva sembrare posseduto dall’estroso spirito delle percussioni». Il titolo Fun Stuff («l’ora di ricreazione») si riferisce a quei passaggi tra la fine di una frase e l’attacco del ritornello successivo in cui i batteristi sono soliti inserire riempitivi (un rullo veloce, un rullo e una terzina, qualcosa di fantasioso con rullante e charleston). I batteristi sofisticati si concedono intervalli più frequenti, in cui esibire la propria bravura. Ma Keith Moon stravolgeva completamente questo schema: per lui non c’erano intervalli da riempire, perché è tutto intervallo, è sempre «l’ora di ricreazione». It is all fun stuff.