Ernst Bloch: polifonia della Storia
È leggenda dura a morire, e per questo motivo quantomeno degna di esser raccontata, che dinanzi alla oramai sopraggiunta decisione del Concilio di Trento (1545 – 1563) di abolire la polifonia nelle composizioni liturgiche, Giovanni Pierluigi da Palestrina – a tutti poi noto semplicemente con il nome del proprio luogo natìo – decise di comporre la sua messa più celebre ed importante, la Missa Papae Marcelli, per “salvare la musica polifonica”.
Questa “salvezza”, naturalmente, non avvenne in questi termini e non ebbe in Palestrina, eventualmente, l’unico rappresentante. È pur vero, tuttavia, che nei racconti tramandati una qualche dimensione fantastica aderisce al ben saldo terreno della storia, restituendoci un quadro più articolato ed arioso delle vicende narrate; quella in esame non fa eccezione. Quand’anche il Concilio di Trento poté ipotizzare un ritorno liturgico alla monodia del canto gregoriano, la storia della musica occidentale con Palestrina intraprese una via senz’altro divergente da questo smunto desideratum. Ciò che più ci preme sottolineare è che Palestrina riuscì a tenere insieme come nessun altro la contemporanea volontà dell’alto clero romano di semplificare le forme polifoniche della composizione – al fine di rendere maggiormente comprensibile ai fedeli il testo cantato – e la straordinaria esigenza di ricchezza armonica e melodica che via via si sarebbe sempre più affermata in seguito. In altri compositori coevi la complessità di tale compito non assurge a dialettica, in lui questo sottile e precario equilibrio diviene aureo.
Questo medesimo equilibrio è davvero la cifra stilistica di Palestrina: il sapiente contrappunto nelle sue composizioni più note non è mai esasperato, mai portato all’eccesso; le diverse voci, su linee melodiche diverse, sembrano unirsi in una equilibrata linearità, pur non rinunciando ad intrecciarsi come verso l’ascensione dei più ad un uno, dei molti a Dio.
Voci diverse che si tengono insieme, tempi che si intrecciano pur restando plurali.
È proprio partendo da questa suggestione musicologica e tenendo sempre a mente il rapporto inscindibile che il filosofo tedesco Ernst Bloch intrattenne con tale arte – rapporto manifestato per altro da numerose monografie che hanno esplorato tale connessione – che si può provare a leggere un suo importante testo, tratto da una conferenza del 1955 che egli tenne all’Accademia delle scienze della DDR e che da poco è stato ripubblicato meritoriamente con nuova traduzione italiana col titolo Differenziazioni sul concetto di progresso (traduzione e curatela di Vittorio Morfino, introduzione di Mauro Farnesi Camellone, PGreco, Milano, 2023).
In esso, Bloch vuole anzitutto fare i conti con un concetto, quello di “progresso”, che oramai ha perduto qualsiasi reale accezione emancipatoria, divenendo vessillo ideologico di una concezione della storia che legge la successione degli eventi come necessariamente progressiva (e qui è esplicita la critica alla socialdemocrazia tedesca, simile a quella svolta nelle Tesi di Benjamin), ma anche, strumento ideologico e “adattivo” in mano alle più bieche forze della reazione.
Ecco, Bloch vuole salvare il concetto di progresso, ma andando in tutt’altra direzione. Il problema epocale è, allora, provare a pensare davvero ad una filosofia della storia che non getti il bambino con l’acqua sporca, che riesca cioè davvero a continuare a pensare il progresso e tuttavia pensare di renderlo realmente strumento nelle mani degli oppressi.
Per far ciò – e Bloch è acutissimo nell’evidenziare tale questione – serve che la filosofia della storia si doti di nuovi e radicalmente differenti concetti di spazio e di tempo, e questa costruzione diviene la vera e propria pars costruens del saggio.
Partiamo dallo spazio: esso non deve più essere al servizio di una filosofia della storia “ciclica” che ha diviso l’intero globo in “civiltà” ognuna scissa e non comunicante con l’altra (il riferimento polemico esplicito più importante è, naturalmente, Oswald Spengler); lo spazio, scrive Bloch, deve davvero “accogliere il vasto materiale storico della terra” (pag. 46). In altri termini, si tratta di immaginare quella che Bloch stesso definisce in queste densissime pagine quale topografia polifonica, ovvero uno spazio che, in termini non eurocentrici, accolga in sé l’intera dinamica dell’accadere umano, e con esso le culture da sempre marginalizzate e/o trattate in relazione al solo sapere europeo.
Ma ad uno spazio storico finalmente allargato non può corrispondere il tempo omogeneo e vuoto della fisica classica; il multiversum blochiano non può davvero sorgere senza un ripensamento radicale del concetto stesso di tempo. Ed è qui che, a nostro avviso, si concentra l’aspetto più acuto e affascinante delle Differenziazioni.
Il tempo storico, scrive Bloch, deve ricavare dalle più moderne ricerche della fisica – sono citati nel testo sia Riemann che Einstein – l’idea che non esista un punto di riferimento attorno al quale interpretare le varie vicende umane; è necessario, ovvero, iniziare a pensare intersecazioni plurime in cui il tempo stesso, quale unico “contenitore” della storia umana (ma in fondo, solo e sempre europea), sia concetto parziale ed erroneo. Il tempo deve divenire elastico, poroso, curvo, pluridimensionale, specifico per ogni luogo. Esso deve “relativizzarsi”, potremmo dire, per inglobare altri tempi tenuti fuori storicamente dallo sguardo unilaterale della cultura europea; la relatività del tempo diviene, quindi, il principale strumento per dare nuova linfa alla filosofia della storia marxista, che non possiede più un vettore unico ed un soggetto di classe eletto – il proletariato – ma un multiversum in cui si producono soggettività plurali per emancipazioni plurime e differenziate.
Questi vari tempi storici – oggettivi prima ancora che soggettivi (il punto di riferimento non è cioè il “tempo interiore” di Bergson, e Bloch lo sottolinea più volte) – devono tutti tenersi insieme in un unico intreccio, ma senza la preminenza di uno sull’altro; come infatti sostiene Farnesi Camellone nel saggio introduttivo al testo, Bloch rispetto ad Eredità di questo tempo (1935) non vuole riportare l’anacronismo all’interno di una politica ultra-contemporanea del proletariato, non vuole cioè utilizzare questi differenti tempi storici al fine di renderli affini e definitivamente arruolati al più importante tempo storico della rivoluzione, perché tutti questi posseggono in loro stessi una propria legittimità. Bisogna definitivamente abbandonare, lo scrive in modo limpido Morfino nel suo Sul non contemporaneo. Marx, Bloch, Althusser (in: Tempora multa. Il governo del tempo, Mimesis, Milano, 2013), “l’idea di un tempo fondamentale misura degli altri, a favore di un multiversum temporale” (pag. 150).
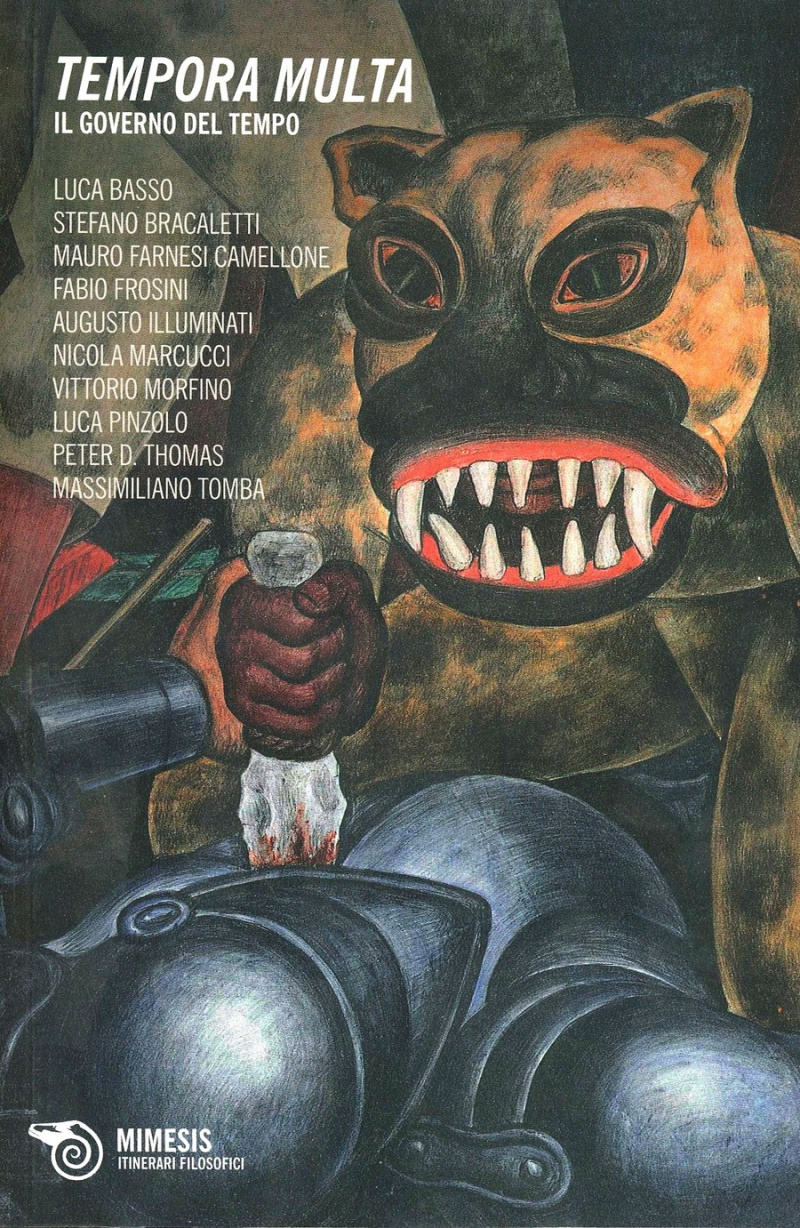
Qui i tempi si intrecciano, come detto, senza che nessuno di essi garantisca il modello principale e definitivo del decorso storico, come voci indipendenti che proprio dalla propria indipendenza possono generare una polifonia.
E qui, all’altezza di queste formulazioni, emerge la questione che fin dall’inizio abbiamo cercato surrettiziamente di sollevare, e di cui Bloch era ben consapevole: il problema, ovvero, di tenere insieme queste molteplici voci nello spazio/tempo, il problema dell’Uno. Come possono infatti legarsi queste pluralità spaziali e temporali in un medesimo disegno emancipatorio? Se esistono, come abbiamo visto, differenti progressi, quale la direzione di questi?
Questa meta, che è l’unico punto del tempo che può esser davvero posto, Bloch la denomina humanum, e, in rigorosa conseguenza di ciò che ha esposto, questo concetto non può avere già un contenuto definito e manifesto; esso può al massimo essere anticipabile, immaginabile, ma non si può davvero descrivere, perché vorrebbe dire averlo già raggiunto. Ed è qui che questa peculiare polifonia della storia deve raggiungere un accordo, nel quale le più disparate voci devono cantare come al suono di una. La verticale delle note basse e l’orizzontale di quelle alte si scoprono da sempre intrecciate, in un contenuto unico. Le diverse voci, apparentemente slegate, hanno generato un tutto armonico.
Tuttavia questo concetto unitario di “umanità”, con il quale si chiude l’intero saggio, rischia, proprio nella sua generalità, di divenire paradossalmente strumento inservibile, meta indefinitamente procrastinabile. Se non bisogna necessariamente condividere la massima di Proudhon – “chi parla di umanità vuol trarvi in inganno” – è tuttavia evidente quanto questo concetto sia lasciato ad un’apertura così tanto ariosa e lucente da rischiare di perdersi nell’oscurità delle molteplici e frammentarie esperienze storiche. Il rischio – ma solo di rischio si può parlare data la natura concisa del testo – è che l’ humanum quale fine della polifonia della storia riduca l’esperimento blochiano ad un ritorno ad una monodia della storia, al canto a solo dell’intera umanità quale “regno della libertà” inautenticamente raggiunto, nonostante per Bloch l’Uno si possa realizzare compiutamente solo e soltanto, come sottolinea ancora Farnesi Camellone nell’Introduzione, “sul terreno di un ordine rivoluzionato rispetto alla formazione sociale capitalistica” (pag. 22).
Vediamo col filosofo tedesco, potremmo dire avvicinandoci alla conclusione, come una sorta di porta socchiusa, destinata ad aprirsi, della quale intravediamo soltanto la luce che entra dal fuori. La vera meta dell’Uno che contiene i molti – e non la falsa ed esiziale unità delle varie culture tutte sussunte sotto lo stendardo del capitale – è davvero allora utopia, come ci ricorda un testo del giovane Benjamin (Paul Scheerbart: Lesabéndio): “di ciò che è più grande – dell’adempimento dell’utopia – non si può parlare – ma solo testimoniare”. Bloch ha allora davvero preso sul serio queste parole. E con lui, la sua polifonia della storia.
Orbene, quella leggenda da cui siamo partiti forse assumerà ora finalmente un senso compiuto: quella polifonia composta di Palestrina, nella quale l’equilibrio tiene insieme il contrappunto delle varie voci, si avvicina all’unità così come la filosofia della storia di Bloch tenta di tenere insieme il molteplice nell’Uno quale fine ultimo dell’umanità. Un uno in cui le differenze non sono spazzate via, ma levate, una musica in cui le varie voci sembrano una e una sola, mentre si ascende a Dio.
A Bloch era ben nota, d’altronde – da profondo conoscitore della musica occidentale – la figura di Palestrina. Nel suo Spirito dell’utopia (nella seconda edizione del 1923) egli, nella lunga e densa sezione denominata Filosofia della musica, cita proprio Palestrina quale esempio fulgido dell’unione sapiente – raggiunta storicamente prima di lui – tra stile melodico italiano e contrappunto fiammingo. È assai interessante che Bloch, parlando di Palestrina, sottolinei maggiormente proprio questa tendenza all’unità presente nella musica del compositore cinquecentesco; Bloch ci consiglia, cioè, di “ascoltare l’accordo”, nel quale emerge la “natura raffaellita” di Palestrina: equilibrio compositivo, lontano dai virtuosismi e forse, restando nella metafora figurativa, dalle corrosive raffigurazioni di un Viviano Codazzi e di un’intera epoca successiva.
Vogliamo davvero allora accogliere l’intuizione del filosofo tedesco, e prenderla sul serio fino in fondo proprio nel provare a giocarci: se Palestrina è un raffaellita, Bloch – e con lui la sua affascinante ed articolata filosofia della storia – è un palestriniano. L’unità come meta, solo a partire dalle differenze. Provando a salvare, stavolta, quel sacro che è in noi e che rischia sempre più di andar perduto.







