Pratiche teatrali per la cura della persona / Gabriele Vacis. Educare alla relazione
La scoperta dell’identità – ha scritto Édouard Glissant nel suo libro dal bel titolo Poetica della relazione – non può essere solo scoperta delle proprie radici, se si intendono le radici come uniche, come «ceppo che assume tutto su di sé e uccide quanto lo circonda» (Macerata, Quodlibet, 2007, p. 23), ma è anche scoperta della relazione. Nel mettere in discussione il luogo comune secondo il quale è l’immagine della radice a definire meglio di ogni altra il concetto di identità, Glissant vi oppone, con Deleuze e Guattari, quella del rizoma, «radice demoltiplicata che si estende in reticoli nella terra e nell’aria, senza che intervenga alcun irrimediabile ceppo predatore. […] Il pensiero rizomatico sarebbe all’origine di quella che io chiamo una poetica della relazione, secondo la quale ogni identità si estende in un rapporto con l’Altro» (p. 23). Strettamente connesso all’idea del rizoma, che non è mai esclusione ma inclusione e alleanza, è l’altro concetto portante del pensiero di Glissant, quello di «nomadismo circolare», contrapposto al «nomadismo a freccia». Se quest’ultimo è il «nomadismo invasore» di chi si sposta da un luogo a un altro per occuparlo e impossessarsene sterminando i suoi occupanti, il «nomadismo circolare» ha invece natura esplorativa, è il richiamo alla relazione con l’alterità, non si impone ma si confronta con l’altro nel segno della libertà, della curiosità, del rispetto, della costruzione comune e condivisa di un’identità (pp. 23-32).
Proprio questo tipo di poetica e di pratica della relazione sembra essere la cifra peculiare della drammaturgia e della pedagogia teatrale del regista, drammaturgo, scrittore, autore televisivo e cinematografico Gabriele Vacis, ma sembra essere anche la marca distintiva di uno dei suoi più recenti e importanti progetti, l’Istituto di pratiche teatrali per la cura della persona, da lui fondato insieme a Roberto Tarasco e Barbara Bonriposi, e realizzato dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, grazie al sostegno della Regione Piemonte e della Compagnia di San Paolo.
 Cuore di tenebra al teatro Carignano di Torino.
Cuore di tenebra al teatro Carignano di Torino.
L’Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona, nato dalle esperienze di Vacis, Tarasco, Antonia Spaliviero e dal vasto gruppo di collaboratori e di specialisti che li hanno supportati in questi anni, cerca di comprendere, far comprendere e mettere in atto l’articolazione della pratica teatrale non più̀ solo come momento di creazione di forme artistiche, ma come luogo di integrazione sociale e interculturale, luogo di inclusione di ogni forma di disabilità e diversità. Sono molteplici le attività svolte dall’Istituto, considerato anche dal Ministero per i beni e le attività̀ culturali quale progetto pilota a livello nazionale: i seminari e il lavoro congiunto con medici, psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, studiosi e ricercatori, con operatori dei servizi sociali e sanitari; i numerosissimi laboratori nelle scuole culminanti in momenti performativi, come è avvenuto lo scorso anno con la messa in scena di “Cuore/Tenebra” dal 22 maggio al 18 giugno 2018 al Teatro Carignano di Torino, che ha coinvolto sei scuole superiori di Torino, Novara e Settimo Torinese; gli incontri continui con i migranti, registrati in forma di video-colloqui confluiti nei progetti “Colloqui d’Amore” e “Pensieri migranti” in cui non si parla di immigrati, ma si parla con gli immigrati, intercettandone l’urgenza di raccontarsi e di essere compresi prima ancora che essere giudicati, ascoltandone le singole storie di paura e di sogni, di dolore e di speranze, assai distanti dalle opinioni sul fenomeno immigrazione o dalla sua astratta percezione. “Siamo partiti per conoscere un fenomeno – mi racconta Vacis – e abbiamo finito, in più di mille colloqui finora, per conoscere delle persone”. Pur nella loro differente articolazione, le molte attività dell’Istituto convergono però tutte verso un unico intento: l’educazione alla consapevolezza di sé e dell’altro, l’educazione all’ascolto non eroso dall’abitudine, non mediato dall’opinione pregiudicante, l’educazione alla relazione, senza la quale nessuna cura, in nessun luogo, può neanche avere inizio. Le pratiche del teatro che, scrive Vacis, “si prendono cura della persona da sempre, possono supportare la socialità, la medicina, l’educazione, perché non sono solo gli attori ad aver bisogno di una conoscenza profonda di sé stessi e degli altri per stare in scena, ma tutte le persone ne hanno bisogno per stare al mondo”.
È un po’ quello che il regista intende con il termine grotowskiano awareness, parola-chiave e colonna portante dell’intera sua esperienza artistica e pedagogica, che non corrisponde soltanto alla consapevolezza, come vorrebbe una prima traduzione del termine dall’inglese, ma implica qualcosa di più, cioè la capacità di essere presenti a sé stessi e alle cose. Nel pensiero di Vacis la awareness è ciò che tiene insieme la consapevolezza silenziosa, la presenza e la vigilanza, pensando però alla vigilanza non come controllo inquisitorio o censorio, ma come intensa consapevolezza dell’esserci, come disposizione a prestare cura a quello che accade e a chi si ascolta (G. Vacis, Awareness. Dieci giorni con Jerzy Grotowski, Roma, Bulzoni, 2014, p. 238). Annota Montaigne, in uno dei molti sollecitanti passaggi dei suoi Saggi, che “è una perfezione assoluta, e quasi divina, saper godere lealmente del proprio essere. Noi cerchiamo altre condizioni perché non comprendiamo l’uso delle nostre, e usciamo fuori di noi perché non sappiamo che cosa c’è dentro. Così abbiamo un bel montare sui trampoli, ma anche sui trampoli bisogna camminare con le nostre gambe” (vol. II, a cura di F. Garavini Milano, Adelphi, pp. 1496-97). E strumento elettivo di Vacis per questa educazione a comprendere che cosa c’è dentro per meglio porsi in relazione con il fuori, è l’esercizio della Schiera, pratica teatrale e pedagogica dell’ascolto e dell’azione, ossia del corpo che si mette in ascolto degli altri corpi per creare azioni comuni. Così la descrive:
È tutta una questione di ascolto. […]. Gli attori si accostano l’uno all’altro formando una schiera. Quindi camminano per un numero indicato di passi variabile a seconda delle dimensioni del luogo in cui si lavora, per esempio otto passi. All’ottavo passo ci si volta e si continua a camminare per otto passi nella direzione opposta, quindi ancora in direzione opposta e così via. L’obiettivo è trovare un’unità di presenza tra le persone che camminano, escludendo ogni affettazione, ogni movimento non strettamente necessario a camminare naturalmente. Questo esercizio è il punto di partenza e il punto di arrivo di un allenamento che vuole formare un attore consapevole, autore della propria presenza in scena. Tutto questo non ha niente a che fare con i personaggi, la psicologia, la messinscena, e nello stesso tempo può essere una tecnica utile per ogni idea di teatro. Ma prima di tutto la Schiera è energia, è tempo, è ritmo e ascolto, gioia, fiducia, amore […]. A forza di camminare avanti e indietro cercando di ascoltare gli altri e di comprendere lo spazio, piano piano si sviluppano azioni. Possono essere danze, canti o vere e proprie scene. C’è un momento in cui tutto sembra accadere da solo (Scuola per attori a Gerusalemme. Lettera, in «Teatro e Storia», 30, 2009, pp. 214-15).
 Cuore di tenebra al teatro Carignano di Torino.
Cuore di tenebra al teatro Carignano di Torino.
L’esercizio della Schiera, nato come pratica squisitamente teatrale e tutta interna al percorso drammaturgico di Vacis – dai suoi germi presenti già in uno dei primi spettacoli del 1985, Elementi di struttura del sentimento, fino al recente Amleto a Gerusalemme del 2016 – a un certo punto è uscito dal teatro per andare ad abitare altri luoghi, compresi quelli del disagio, perché tutte le persone, e non solo gli attori, hanno bisogno, per stare al mondo, di entrare in relazione intima con ciò che sta intorno. Fuori dagli spazi canonici del teatro e svincolata dall’essere al servizio esclusivo dell’azione drammatica, la pratica della Schiera è divenuta parte fondativa anche del lavoro laboratoriale che l’Istituto di Pratiche teatrali per la cura della persona ha intrapreso con scuole e associazioni di varia natura, comprese quelle che si prendono cura di disabili psichici e fisici, rivelando con ancora maggiore forza la sua natura di esperienza: esperienza di consapevolezza, di presenza e compresenza, di ascolto, di condivisione e di comprensione non pregiudicata, non priva di un certo grado di imprevedibilità, com’è, del resto, nella natura stessa di ogni esperienza autentica. “Ma c’è un altro possibile uso della Schiera”, spiega Vacis, “semplicemente presentarsi di fronte al pubblico, senza sapere che cosa si farà, e lanciarsi. È molto pericoloso. Ma quando accade ti sembra che tutto il resto non valga più la pena” («Teatro e Storia», 30, 2009, p. 217).
 Generali dell’attività dell’Istituto.
Generali dell’attività dell’Istituto.
È accaduto, per esempio, lo scorso 6 aprile 2019 presso la Sala degli Specchi del Teatro Valli di Reggio Emilia, dove ho assistito all’esito performativo, a cura di Vacis e Roberto Tarasco, del laboratorio condotto a partire dal febbraio 2018 dai fondatori dell’Istituto con l’Associazione “ZeroFavole Onlus” di Reggio Emilia, che del teatro ha fatto in questi anni uno dei punti chiave nel processo formativo di integrazione ed inclusione di persone con disabilità, o persone messe ai margini della società. Per più di un’ora i ragazzi dell’Istituto di Torino e i componenti di “ZeroFavole”, di diversa età e alcuni dei quali con gravi disabilità, hanno praticato la Schiera guidati dalla figura sommessa, gregaria di Vacis, muovendosi all’unisono, attraversando e condividendo con noi, non spettatori ma testimoni di un rito, ogni frammento emozionale della loro presenza, del regolare movimento dei loro corpi, sempre uguale eppure sempre diverso perché diversa è la storia che ogni singolo sguardo o passo o movenza racconta, ogni istante della loro esperienza. “Fare esperienza di qualcosa – scrive Heidegger – significa: lungo il cammino, per strada, raggiungere qualcosa. Fare esperienza di qualcosa significa: che quel qualche cosa al quale giungiamo, mentre siamo in cammino per raggiungerlo, proprio esso ci sopraggiunge, ci colpisce, ci pretende in quanto ci trasforma secondo se stesso” (In cammino verso il linguaggio, Milano, Mursia, 1990, p. 141). L’esperienza, nel senso di Heidegger, sopraggiunge, ci attraversa e, attraversandoci, ci cambia, come quando ci si innamora o ci si ammala, e per questo è imprevedibile, come talvolta imprevedibile è la Schiera nell’assecondare, durante l’esercizio, il desiderio di un corpo di rallentare, di fermarsi, oppure di ridere, gioire sfrenatamente e iniziare a correre, riempiendosi di vento e riempiendo di vento, in quella corsa, anche chi assiste da molto vicino. In quel momento quei ragazzi e quelle ragazze sono di vento, un’espressione – “sei di vento” – con cui, racconta Vacis, sua nonna era solita rimproverarlo bonariamente da bambino e che, capisco solo ora vedendo muoversi la schiera, non vuol dire soltanto “non stare fermi, essere irrequieti”, ma vuol dire muoversi creando continua sorpresa, muoversi in un modo che è imprevedibile per chi ti osserva, come imprevedibilmente gira il vento e come imprevedibili, per noi terrestri, sono le volte degli stormi, a cui Vacis assimila le movenze della Schiera. Un passo denso di Primo Levi, tratto dalla raccolta L’altrui mestiere, descrive perfettamente la danza degli stormi e, con essa, quella della Schiera di Vacis:
Come non ammirare […] l’adattabilità degli stormi? […] Visti da lontano, questi voli sembrano nuvole di fumo: ma poi, a un tratto, si esibiscono in evoluzioni stupefacenti, la nuvola diventa un lungo nastro, poi un cono, poi una sfera; infine si ridistende e, come una enorme freccia punta sicura verso il ricovero notturno. Chi comanda l’esercito? E come trasmette i suoi comandi? (P. Levi, Opere, II, a cura di M. Belpoliti, Torino, Einaudi, 1997, p. 807).
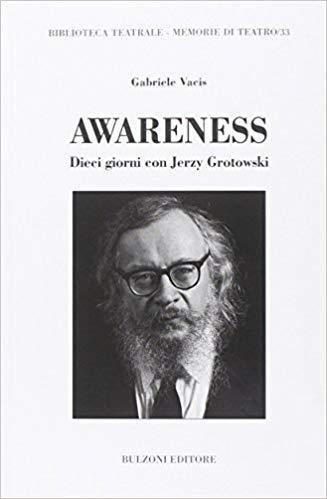
Al termine della performance dello scorso 6 aprile 2019 presso la Sala degli Specchi del Teatro Valli di Reggio Emilia, l’intera Schiera ha spalancato le braccia accennando al volo dello stormo, per poi finire in un unico abbraccio, tutti stretti l’uno attorno all’altro, come petali di un fiore che si richiuda, o come un enorme nido pieno di uccelli rientrati per la notte. Ma, appena prima, un’altra potente visione ci ha visitati: quella del corpo di uno dei ragazzi sospeso nell’aria, in un continuo rotolare che le spalle e le braccia degli altri hanno assecondato senza lasciarlo cadere, un corpo sorretto dall’abbraccio accogliente di tutti. Torno a casa, e corre in soccorso ancora Montaigne per continuare a pensare al lavoro di Vacis, al coraggio della sua poetica e pratica della awareness, al coraggio del lavoro dell’Istituto di pratiche teatrali per la cura della persona: “Per lasciarsi cadere a capofitto, e da tale altezza, bisogna cader fra le braccia d’un affetto solido, robusto e fortunato; essi sono rari, se pur ve ne sono” (Montaigne, Saggi, vol. II, cit., p. 1396).







