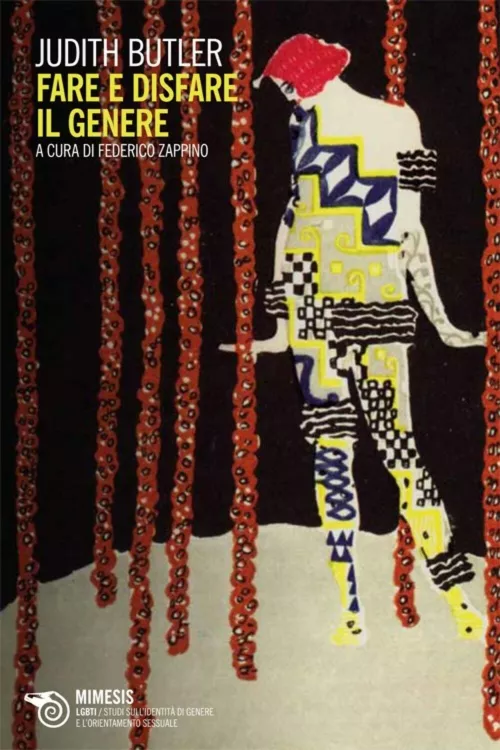Undoing gender
La recente pubblicazione della ritraduzione di Undoing Gender (2004) di Judith Butler per Mimesis (2014), dal titolo Fare e disfare il genere (che ritraduce un precedente La disfatta del genere, Meltemi 2006), a cura di Federico Zappino, mi sembra costituisca un ottimo punto di partenza per parlare di traduzione in relazione al queer – e magari proporci spunti di riflessione pratici sul “da farsi” in materia.
Lo scritto che segue trae ispirazione da un’intervista con Federico Zappino, risalente al settembre del 2014, quando era ancora impegnato nella revisione delle bozze dell’opera. L’idea di parlare di questa ri-traduzione mi viene offerta, però, anche dall’uso sempre più insistente del termine “gender” in narrazioni circolanti in Italia (ma anche in Francia) sulla cosiddetta “ideologia del gender”: si tratta di idee di matrice cattolica che vorrebbero mettere in guardia dall’invasione e dalla colonizzazione delle istituzioni (in primis quelle educative) da parte di questa ideologia “de-genere”. La parola “gender”, nel binomio “ideologia del gender”, è un prestito inglese, come a dire che non è possibile tradurla in italiano perché rappresenta un’idea altra, straniera, imposta da fuori e non autoctona – come ha di recente illustrato Sara Garbagnoli. È dunque sulla scia di questa intraducibilità e di ciò che è dato o meno importare, ridire o rifare in Italia che Fare e disfare il genere si colloca.
Non si tratta della prima ritraduzione di Butler. Nel 2013, ad esempio, lo stesso Zappino ne ha ritradotto La vita psichica del potere, sempre per Mimesis; Olivia Guaraldo ha ritradotto invece Vite precarie, per Postmedia Books; mentre Laterza ha pubblicato la riedizione di Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (1990), libro fondamentale di Butler, col titolo Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità, già pubblicato con altro titolo e altra traduzione da Sansoni nel 2004, Scambi di genere. Identità, sesso e desiderio. E anche in questo caso Sergia Adamo, la traduttrice, ha lavorato sul titolo, ri-traducendo “trouble” con il concetto di “questione”, nel senso di “interrogativo”, in un modo che rende forse meglio il concetto rispetto al precedente “scambi” (anche se non pienamente, a mio avviso, come peraltro ha sostenuto anche Zappino di recente, suggerendo che una traduzione più fedele del concetto di “trouble” si avrebbe con quello – ancorché poco accademico – di “casino”).
E dunque, se le traduzioni dei libri di Butler, aumentate esponenzialmente negli ultimi anni, testimoniano del crescente interesse in Italia, da parte dell’editoria ma non solo, per gli studi riguardanti la sessualità e il genere, le ritraduzioni, in particolare, gettano luce sul fatto che ci sia bisogno di ri-dire in modi nuovi ciò che era già stato detto, di riparlarne. Ma ri-dire cosa?
Come affermato in alcune delle recensioni apparse di Fare e disfare il genere, «identità di genere, eteronormatività, corporeità, parentela, unioni tra persone dello stesso sesso – e ancora trasformazione sociale, riconoscimento, interdipendenza, desiderio e autodeterminazione, sono tutti i fili che vanno a comporre la riflessione più matura e vibrante di Judith Butler», rispetto agli esordi di Gender Trouble. Nello specifico di Undoing Gender, si è voluto ritradurre il precedente titolo La disfatta del genere, con un nuovo titolo che desse ragione a ciò a cui il libro si riferiva. Non tanto La disfatta del genere, che richiamava l’idea della “sconfitta in battaglia”, dell’“uccisione”, della “morte” del genere, e che sarebbe stata la traduzione ideale di un ipotetico “to defeat”, quanto piuttosto un “fare e disfare il genere”. Il nuovo titolo, concordato dal curatore con la stessa Judith Butler, a cui non era piaciuto il precedente (come d’altronde non era piaciuto ad altr*), traduce più attentamente questo movimento di disfacimento e rifacimento che il verbo “un-doing” suggerisce. Come mi disse Zappino, nel titolo “la disfatta del genere” il filo conduttore richiamava l’idea di una “fine”, mentre ciò su cui egli vuole insistere e rendere più esplicito nella ritraduzione è invece il concetto della “rinegoziazione”, del “movimento”, del “farsi e disfarsi” – della “illimitata apertura”.
Innanzitutto perché, ha suggerito di recente il traduttore, in questo suo libro Butler tenta di disfare non tanto le sue teorie passate, ma ciò che queste avevano prodotto a livello discorsivo, e innanzitutto l’idea che il genere fosse solo performance e performatività, o che il corpo, nella sua materialità, non preesistesse ai processi di soggettivazione e di assoggettamento. Ecco dunque che il primo intento del testo consiste nel disfare e “disfarsi” di quelle illusioni prodotte negli anni intorno alla teoria butleriana del gender. Il secondo intento del libro verte però principalmente su «ciò che potrebbe significare disfare quelle concezioni dominanti che dettano norme restrittive in materia di genere e sessualità, ma anche sull’esperienza insieme distruttiva e costruttiva del venire disfatti». Butler si riferisce qui all’aspetto che Zappino definisce «negativo e insieme positivo» del concetto di undoing. La parte negativa attiene alla maggiore vulnerabilità dei soggetti queer, i quali subiscono una disfatta dal loro non-conformarsi alle norme di genere e alle forme della sessualità dominanti. La parte positiva, tuttavia, attiene alle possibilità che potrebbero derivare da questo disfarsi. Il genere, sostiene infatti Butler, non si fa mai in solitudine, ma sempre con l’altr* e per l’altr*, e le condizioni che lo determinano stanno fin dall’inizio al di fuori di noi e dunque noi non lo possediamo mai pienamente, non ne siamo le/gli autor*. Questo essere-nel-mondo come essere-fuori-di-sé è l’idea butleriana del «soggetto ex-statico». «Siamo disfatti gli uni dagli altri, e se non lo siamo significa che ci stiamo perdendo qualcosa», scrive Butler, perché è proprio in questo disfacimento che può emergere una «promessa critica», una possibilità di trasformazione e di ricreazione dei parametri di intelligibilità delle soggettività e delle relazioni che eccedono i paradigmi consolidati – e dunque della loro vivibilità.
Pensare il genere come qualcosa che non facciamo in solitudine ma come un agire di concerto apre interessanti spunti in relazione al concetto di traduzione. Innazitutto, perchè ci porta a pensare alla traduzione come a un costante flusso circolare di andate e ritorni; in secondo luogo, perché fa leva sul concetto di «relazionalità dialogica».

Sarah Deragon, The Identity Project, 2014 - on going
Si dice ormai da tempo che la traduzione, più che il movimento di un originale da una cultura a un’altra, non sia – appunto – che un suo disfacimento e rifacimento. Gli studi sulla traduzione degli ultimi vent’anni (si pensi a Basnnett e Bush, a Tymoczko o a Baker) hanno in questo senso insistito sul fatto che la traduzione non costituisca semplicemente la brutta copia di un originale, e nemmeno la mera ricodificazione di un discorso in un altro codice. Essa, piuttosto, è un «atto creativo» e al contempo «trasformativo»: un atto, cioè, in grado di giocare un ruolo non secondario nei processi di trasformazione sociale.
Se applichiamo dunque la teorizzazione del genere di Butler alla pratica di traduzione, potremmo dire che questa è la copia di un originale che non esiste, ma che viene constantemente costruito dalla traduzione stessa. Ovviamente opero questo paragone sul piano discorsivo, sul piano cioè della costruzione dell’idea che ci facciamo di traduzione, senza rinnegare l’esistenza materiale di testi su cui le traduzioni si basano o ispirano. Ciò che il mio paragone sottintende, però, è che dovrebbe cessare di esistere un concetto a tutto tondo di «autorialità» in materia di traduzione: ossia, la traduzione è un continuo farsi e disfarsi del linguaggio, e dato che il linguaggio non appartiene mai solo ai suoi autori ma è al contempo ciò che li sovratermina, ne risulta che l’originale e la traduzione, insieme, sono un agire con l’altro e per l’altro. Questo risulta ancora più cogente dal momento che la traduzione non esula mai da una relazione, più o meno fittizia, con un altro (testo, immagine ecc.).
Questo discorso chiama in causa i concetti di «performatività» e «affettività». Se la traduzione, come il genere, è il risultato di una costante citazione di un originale, allora è in questa reiterazione, in questo incessante farsi e disfarsi, in questa “illimitata apertura”, che risiede la sua performatività. Senza la traduzione l’originale non esisterebbe, poiché esso prende vita solo in seno a questo processo che si suppone derivativo. Se tuttavia intendiamo – con Derrida – che anche l’originale sia a sua volta il prodotto di altri pensieri e discorsi, allora non ci resta che vedere originalità e autorialità proprio in seno alla stessa traduzione. Traduzione che, a questo punto, assurge a luogo di nuove partenze, non di arrivo.
La traduzione crea nuove autorialità. I libri tradotti vengono presentati e performati a eventi dai traduttori e dalle soggettività che con loro si pongono in relazione. Come mi ha ricordato Zappino a proposito della traduzione che lui propose e curò del libro di Eve Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the Closet (tr. it., Stanze private, Carocci 2011, prefazione di Silvia Antosa), caposaldo del queer, la traduzione ha creato lui stesso come «colui che ha tradotto Sedgwick» e lo ha invitato a impersonare/fare la voce di/performare Sedgwick alle varie presentazioni del libro, come sta facendo per Butler in questi mesi alle tante presentazioni in giro per l’Italia di Fare e disfare il genere. La traduzione ha ceduto dunque al traduttore parte dell’autorialità sottratta all’originale, a cui però, come dicevamo, non è mai appartenuta interamente. Non solo dunque l’atto della traduzione ne rende manifesta la performatività, ma diventa essa stessa una performance in relazione alla già citata nozione di creazione. I traduttori sono attori sociali e la traduzione, nell’occupare lo spazio ambiguo del disfacimento/rifacimento, ha la capacità di creare e trasformare la realtà sociale.
In questa direzione, non è insensato pensare che la traduzione del libro di Sedgwick, nel 2011, abbia stimolato un riaccendersi del dibattito (e dell’attivismo) queer in Italia, dal momento che alla pubblicazione è seguito, solo per fare qualche esempio, un importante convegno a Padova sugli studi queer in Italia (2011), o la creazione del centro di ricerca Politesse. Politiche e teorie della sessualità, da parte di Lorenzo Bernini, all’università di Verona, o l’organizzazione di un evento come la Primavera Queer all’università di Chieti, un recente ciclo di incontri al Cassero di Bologna (Qui Quo Queer), o un ciclo di seminari organizzato dal collettivo Kespazio! all’interno della Casa Internazionale delle Donne di Roma (Queer It Yourself, 2011-2013), nonché una sempre crescente declinazione in chiave queer delle forme di occupazione e di resistenza alle politiche di precarizzazione del vivibile, tra cui il collettivo Fuxia Block di Padova (che ha dato vita alla Queersultoria), o il laboratorio QueerLab ecc., per non parlare delle altre pubblicazioni, ritraduzioni e traduzioni di testi queer, in primis quelli di Butler.
Le traduzioni hanno dunque favorito la creazione di nuove reti sociali e hanno incoraggiato e prodotto altro pensiero sul queer. Mi preme a questo punto sottolineare che queste rete sociali sono soprattutto reti affettive, come ci ricorda Liana Borghi, che da tempo lavora sull’affetto, e ne ha fatto anche il tema di alcune scuole estive, insieme a Clotilde Barbarulli, centrate sugli studi queer e tenutesi negli ultimi anni a villa Fiorelli, a Prato. E l’affetto – come ci ricordano Gregg e Seigworth (2010), ma non solo – nasce nello stare tra-, nella capacità di agire e farsi agire. L’affetto consegna il corpo a un mondo di incontri: l’affetto è performativo perché mette il corpo in movimento, lo mette in una situazione di continuo divenire. Gli affetti sono perciò in grado di mettere insieme i corpi, di farli entrare in contatto con altri corpi. Come dice Borghi, parafrasando Sara Ahmed, le emozioni si muovono tra corpi e segni e fanno delle cose, allineando individui a comunità, o spazi corporei a spazi sociali, attraverso l’intensità dell’attaccamento.
Pensare agli affetti può illuminare le motivazioni che spingono le/gli attivist* a tradurre senza ricevere alcuna remunerazione, o quasi, come avviene normalmente nella traduzione in ambito attivista. L’affettività mette insieme corpi che entrano in contatto e ne escono trasformati. L’affettività è la forza propulsiva che spinge a tradurre questi corpi insieme, a consegnarli gli uni agli altri. È perche si è entrati affettivamente in contatto, è l’agire-insieme che porta all’idea di tradurre un testo, un’idea. Ad esempio, in merito al gruppo di lavoro di traduzione che ha portato alla pubblicazione di un’antologia di testi sul queer come Canone inverso, nel 2012 (curata da Elisa Arfini e Cristian Lo Iacono), per la collana “àltera” dell’editore ETS, Liana Borghi, coordinatrice della collana, ha sostenuto come sia stato il gruppo di lavoro “allargato” ad aver contribuito alla scelta e alla traduzione dei testi, innanzitutto per amicizia, passione, solidarietà, interesse specifico. Ecco dunque che l’affettività, l’incontro tra corpi, produce le traduzioni nel momento in cui produce movimento tra corpi e corpi in movimento – in un circolo affettivo.
Un’affermazione che esemplifica molto bene questo concetto è quella che trovo nel blog del collettivo Ideadestroyingmuros, che intende la traduzione come azione politica:
«nell’attraversare i nostri desideri, i nostri corpi, le nostre lingue e il sesso, si scoprono significati nuovi e si rivela la potenza che abbiamo di trasformarli […]. Sperimentando e insinuandoci in territori e linguaggi diversi, attraverso la traduzione, riscattiamo la vita.»
L’idea della citazionalità e della performatività butleriana mi pare utile a comprendere cosa avvenga nella traduzione in ambito queer in Italia, perché vede la traduzione, in quanto incontro tra testi e corpi, come un continuo farsi attraverso l’altro, uno spazio performativo di decostruzione e ricostruzione in cui i soggetti (e i testi) che vi partecipano sono entrambi esposti al disfacimento e al rifacimento. Questo implica che non si possa più parlare di passaggi senza trasformazioni, né di un movimento direzionale da un testo di partenza a un testo di arrivo, ma di vari movimenti e di vari punti di partenza. Vorrei però ora fare un ulteriore passaggio che chiama in causa l’aspetto più situazionale e materiale della traduzione.
 William Kentridge, Nine birds flying, 2011
William Kentridge, Nine birds flying, 2011
La cultura di arrivo, abbiamo visto, gioca un ruolo importantissimo nel dettare quali siano gli interessi e i messaggi che si vogliono divulgare attraverso la traduzione. Nel caso di Fare e disfare il genere, più che un’imposizione esterna, la ritraduzione assurge a pretesto domestico per parlare di bisogni insiti in un certo luogo e rivelare per esempio ciò che il testo tradotto non dice e che invece potrebbe dire. Sono dunque soprattutto i bisogni che nascono in seno alla target culture a dar vita alla traduzione e a dare avvio a lavori traduttivi – come d’altronde affermano anche varie teorie traduttive degli ultimi anni, a partire dal funzionalismo, passando per la svolta culturale degli anni Novanta, fino ad arrivare alla più recente svolta sociologica. La traduzione è fatta di moti interni in risposta a segnali esterni che interpellano.
Nella recensione di Olivia Fiorilli, in tal senso, si legge come Fare e disfare il genere, se oppurtunamente tradito, sia in grado di parlare «non solo ai movimenti queer e transfemministi, ma anche a tutti i movimenti sociali che combattono le politiche predatorie del neoliberismo». Questo tradimento, d’altro canto, è proprio l’obiettivo della postfazione di Zappino, Il genere, luogo precario, che introduce nella ritraduzione un testo che sfrutta alcuni concetti butleriani per illuminare la condizione umana nel regime di precarietà indotta dal neoliberismo, di cui però il libro non parla: questi tradimenti, queste letture in Italia in questo esatto momento storico, a distanza di dieci anni dalla prima pubblicazione in inglese, non fanno dunque che ribadire che il testo, per poterci parlare, deve essere disfatto. Il testo in questione, a giudicare dalle tante recensioni apparse, viene dunque letto e recepito in Italia nel suo valore politico, come una chiamata a una presa di posizione per il ripensamento del welfare e della giustizia sociale, a partire proprio da quella vulnerabilità e da quella precarietà sulle quali ha insistito Butler nelle sue riflessioni sul genere e sulla sessualità, che ci caratterizzano nel nostro essere esposti agli altri – e che sono anche la forza attraverso cui la trasformazione sociale è possibile.
Questi tradimenti ci esortano allora a prendere parola anche sulla precarizzazione del lavoro di traduzione. Ammesso che ogni traduzione implichi un’interpretazione e dunque una manipolazione di un testo di partenza come solo mezzo per poter parlare alla cultura ricevente, e che dunque tradurre equivale a tradire, sappiamo anche bene come la parola “tradimento” sia stata associata nei secoli (fin dal 1700) alle traduzioni nella famosa frase: les belles infideles (“le belle e infedeli”). Se le traduzioni eran belle dovevano per forza essere infedeli. La metafora invocata dalla frase richiama alla genderizzazione e la sessualizzazione in termini eteronormativi e patriarcali della traduzione: la traduzione come attività femminile potenzialmente fedele o infedele rispetto a un ipotetico marito (all’originale). Come ci dicono alcune teoriche femministe della traduzione, tra cui Lori Chamberlain, questo ci conferma che la traduzione fosse considerata un’attività secondaria, derivativa e riproduttiva rispetto all’autorialità e creatività associate al testo originale e declinate al maschile.
Tutto ciò mi porta a pensare che l’idea di femminilizzazione del lavoro (precario), di cui parla Cristina Morini in un recente articolo, si possa associare facilmente all’idea di traduzione, soprattutto quella freelance, attività atavicamente sottopagata o gratuita, non riconosciuta come tale e resa spesso invisibile, precaria, infestata dalla logica persecutoria del riconoscimento obbligato e messa a valore solo in termini di flessibilità (nei confronti di impossibili scadenze), caratteristica vista come espressione naturale e spontanea della femminilità. Ma sottrarsi a questa promessa di riconoscimento, come scrive Olivia Fiorilli, è possibile solo se si creano collettivamente spazi e comunità che «consentano materialmente e simbolicamente di essere “socialmente possibili” contro le norme che allocano in modo differenziale riconoscimento e “valore”».
La questione dell’affettività menzionata in precendenza esorta dunque a ripensare la traduzione anche nell’ottica di una disidentificazione dall’ordine neoliberale. Quello che già succede nella traduzione in ambito attivista ci parla del fatto che la traduzione costituisce una forza necessariamente propulsiva per la rigenerazione e produzione di nuovi discorsi e dialoghi sul queer e di nuove affettività e alleanze che possano a loro volta dar vita a nuovi discorsi. È appunto attraverso il suo essere luogo precario di interdipendenza e luogo di incessanti ri-formulazioni performative e affettive che la traduzione, specialmente quella che è frutto del lavoro di soggetti queer e precari, può produttivamente disfarci e rifarci, e soprattutto può e deve rifarsi delle sue perdite, contestando le categorie che la assoggettano e ridandosi valore, simbolico e materiale. D’altronde, è lo stesso Federico Zappino – nella chiusa, toccante, della sua postfazione – a ricordarci che
«[…] noi siamo già luoghi di crisi e di resistenza, luoghi in cui i corpi recano le tracce di infiniti e plurali ripiegamenti melanconici, che si tratta di mettere in comune – e di infiniti e plurali rilanci ex-statici, tutti da organizzare.»