Giuseppe Mussardo e Gaspare Polizzi / L’infinita scienza di Leopardi
e quando miro in cielo arder le stelle; / dico fra me pensando: / a che tante facelle?/ Che fa l’aria infinita, e quel profondo / infinito seren? che vuol dir questa / solitudine immensa?
Nei versi del Canto del pastore errante dell’Asia (1830) lo sguardo rivolto al cielo si apre all’interrogazione sulla condizione umana, allo stupore pascaliano sull’esistenza dispersa nell’immensità dell’universo. “Mirare” il cielo non è per Giacomo Leopardi solo accento lirico, è anche il lascito di una solida formazione scientifica, dove l’astronomia, “la più sublime, la più nobile tra le Fisiche scienze”, occupò un posto di primo piano, come attesta l’impressionante erudizione della Storia della Astronomia. Dalla sua origine fino all’anno MDCCCXI, composta a quindici anni, nel 1813. Quando parla del cielo, il poeta degli spazi infiniti e dei dialoghi con la luna sa bene di cosa sta parlando, ha spiegato Gaspare Polizzi nei suoi scritti, da Leopardi e le “ragioni della verità” (Carocci, 2003) fino a Io sono quella che tu fuggi. Leopardi e la natura (Edizioni di storia e letteratura, 2015). Ora Polizzi, in collaborazione con Giuseppe Mussardo, docente di Fisica teorica presso la Sissa di Trieste, propone L’infinita scienza di Leopardi (Scienza express, Trieste) dove l’indagine sulla formazione in campo chimico, astronomico, fisico del poeta di Recanati si apre ad “approfondimenti” che danno concreta esemplificazione di come la storia delle scienze si innesti nel tessuto unitario della cultura. Così il percorso che conduce alla meccanica galileiana e newtoniana si sviluppa attraverso i dibattiti connessi alle comete, alle maree, all’esistenza del vuoto, alle implicazioni dell’atomismo; il cammino che conduce al Sistema periodico di Mendeleiev prende le mosse dai primi incerti passi della confusa sperimentazione alchimistica a cui pone termine il rigore metodologico di Lavoisier. Ne deriva un’opera che insegue quei “passaggi a Nord-Ovest”, per dirla con Michel Serres (un autore che Polizzi ha contribuito a far conoscere in Italia), che mettono in comunicazione le scienze naturali e la cultura umanistica, dando espressione a quell’ideale di “terzo istruito” a cui il filosofo francese ha affidato il suo progetto pedagogico.
Leopardi rimane l’unico filosofo originale del nostro Ottocento, ben al di là del tradizionale confronto, caro a De Sanctis, con Schopenhauer in merito a quel pessimismo in cui il poeta non si riconosceva. Con Leopardi riemerge, prima di Nietzsche, il senso tragico dell’esistenza e l’immagine pagana della natura come ciclo ricorrente di generazione e distruzione degli enti, ricordava Salvatore Natoli nel Dialogo su Leopardi (B. Mondadori, 1998), scritto con Antonio Prete a cui si deve Il pensiero poetante che ha aperto nel 1980 una nuova stagione della critica leopardiana. Ma Leopardi, “orfano di Dio”, resta sul crinale fra la speranza ultraterrena e la consapevole assunzione della finitezza umana; non accogliendo in toto l’innocenza crudele del divenire, Leopardi insegue un colpevole del male e la natura matrigna prende il posto del Dio cristiano. Leopardi è pensatore epocale, scriveva Emanuele Severino in Il nulla e la poesia (Rizzoli, 2005), per aver svelato l’anima nichilistica dell’Occidente, la fede nel divenire; ma il suo è un “nichilismo attivo” – in cui il pensiero di Nietzsche potrà trovare ampie rispondenze – che affida alla poesia il compito di dare al nulla l’essere nel canto.
La rilevanza della formazione scientifica consente di interpretare Leopardi anche come “filosofo naturale”, attento alle implicazioni che lo sviluppo delle scienze deposita nello spazio fra l’interrogazione filosofica e le immagini del pensare poetico. Italo Calvino aveva indicato nei poeti lunari, nella linea che da Dante giunge a Leopardi, passando per Ariosto e Galileo, l’alveo dimenticato della tradizione italiana, dominata da una “vocazione cosmologica”; era questa la tradizione di cui si sentiva partecipe, quella che pensa la letteratura come “una filosofia naturale” in cui comunicano le forze della natura e le forme della cultura. Nel disincanto del poeta adulto lo sguardo leopardiano sul mondo non dimentica la curiosità meravigliata con cui da ragazzo predisponeva gli esperimenti nel piccolo laboratorio fatto costruire dal padre Monaldo. Accanto a strumenti pneumatici per eseguire esperienze di meccanica o sul vuoto, come un tubo di Newton e due piccoli emisferi di Magdeburgo, il laboratorio disponeva di una macchina centrifuga, di un dinamometro di Regnier, di provette, solventi, magneti e della famosa bottiglia di Leida, ovvero un potente condensatore elettrico. In poche parole, ad essere coltivate erano tutte le scienze sperimentali che si stavano affermando nel primo Ottocento, l’idrodinamica, la chimica, l’elettrologia. Certo, il Leopardi maturo non guarda più alla scienza come fonte di verità, ma come semplice costruzione di credenze, per quanto convincenti. Quel che da essa si apprende non sono “le pretese leggi della natura”, piuttosto l’atteggiamento critico e scettico che cancella precedenti illusioni: “il progresso dello spirito umano consiste […] nel conoscere sempre più di non conoscere”. Anche Newton, il “genio più sublime che sia giammai comparso sulla Terra”, modello dei “grandi filosofi” e “scopritore delle grandi verità”, ha costruito un sistema del mondo che non coglie la verità intima della natura.
Nell’Operetta morale dedicata a Copernico (1827), il Sole, stanco di girare intorno alla Terra, chiede all’astronomo distruttore della superbia antropocentrica una teoria che convinca l’umanità della sua immobilità. La dottrina eliocentrica resta per Leopardi una convenzione, il che è probabile conseguenza della dura condanna di Galilei e del copernicanesimo da parte del padre, ancor più intransigente della Chiesa ufficiale che terrà il Dialogo sopra i due massimi sistemi all’Indice fino al 1818. In Leopardi non si accenna al “realismo” di Galileo né alla sua visione matematica della natura; e la scarsa padronanza della matematica, evidente nell’assenza di calcoli della Storia dell’astronomia, è forse il limite più evidente della sua cultura scientifica. Leopardi apprezza l’approccio sperimentale di Galileo, che è per lui soprattutto modello di stile e di pensiero, portavoce di uno “scetticismo ragionato” di matrice empiristica con qualche venatura materialistica, come Polizzi aveva già mostrato in Galileo in Leopardi (Le lettere, 2007). Il poeta dell’Infinito esalta il valore letterario dell’opera di Galileo, l’autore più citato nella Crestomazia della prosa – l’antologia di letteratura italiana curata nel 1827 per l’editore Stella. Nello Zibaldone, allo scienziato pisano si riconosce la capacità di rendere con la vividezza delle immagini l’articolazione dei pensieri, grazie a una scrittura di “efficacia e scolpitezza evidente” (1818), giudizio che si ritroverà in analoghe considerazioni di Calvino e Gadda.
Più volte nello Zibaldone il diffondersi del pensiero razionalistico e delle modalità tecnico-scientifiche di osservazione del reale è accusato di cancellare la fantasia e rendere l’uomo “insensibile alla natura”. La Terra diventa così “inabitata piaggia”, deserto invaso dal nulla: “… i progressi della ragione e lo spegnimento delle illusioni producono la barbarie” (Zibaldone), un passo in cui già risuona la consapevolezza che “la terra interamente illuminata splende all’insegna di trionfale sventura”, secondo la formula della dialettica dell’Illuminismo di Horkheimer e Adorno. La filosofia moderna ha fatto propria la procedura “analitica” e astratta della matematica, modello perfetto di scientificità che si affida però a simboli e regole convenzionali, e la cui elevata coerenza allontana dalla realtà naturale: “La stretta precisione entra nella ragione e deriva da lei, non entrava nel piano della natura, e non si trovava nell’effetto”. L’esattezza “è buona per le parti, ma non per il tutto”: alla matematica sfugge dunque la visione d’insieme che sappia cogliere la varietà della natura, quella che trova espressione nell’“appresso a poco” (1821). L’occhio matematico pretende di misurare ciò che non sopporta di essere misurato, si pone così in opposizione rispetto all’impulso umano al piacere che tende all’infinito.
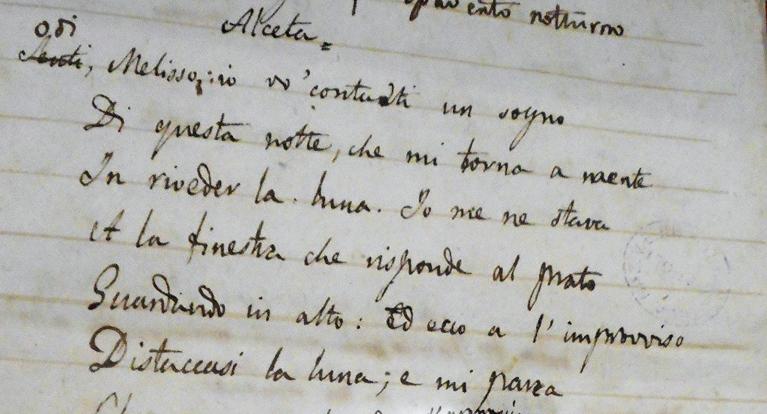
Nei versi dell’Infinito (1819) trovano ancora risonanza le implicazioni molteplici che la nozione aveva ricevuto in ambito scientifico, a partire dalla sua natura paradossale, esposta da Galilei in pagine del Dialogo note a Leopardi: la sequenza dei numeri quadrati, solo un sotto-insieme dei numeri naturali, si può porre in corrispondenza biunivoca con l’insieme a cui appartiene, il che falsifica l’assioma euclideo per cui il tutto è maggiore della parte. Ma oltre alla dimensione logico-matematica, su cui Mussardo e Polizzi propongono approfondimenti che dai paradossi di Zenone, attraverso le indagini sul transfinito di Cantor, conducono ai frattali di Mandelbrot, la questione dell’infinito coinvolge la fisica e la chimica. Nella vecchia ratio studiorum gesuitica su cui si era formato Monaldo la chimica non trovava posto; il padre di Giacomo cercò di colmare la lacuna accumulando nella sua famosa Biblioteca le novità più rilevanti, a partire dalla prima edizione italiana del Trattato elementare di Chimica (1791) di Antoine-Laurent Lavoisier di cui il giovane Leopardi apprezza, nella Dissertazione sopra i fluidi elastici, la nuova nomenclatura che cancella la vaghezza dell’antica terminologia qualitativa, intrisa di fantasie alchimistiche. Lo Zibaldone potrà così contrapporre ai “termini” univoci delle scienze, che “determinano e definiscono la cosa da tutte le parti”, le “parole” vaghe proprie della poesia; e se le prime si caratterizzano per “la nudità o secchezza” che conferisce aridità al discorso, le seconde danno ad esso “efficacia ed evidenza”.
Il manifesto della nuova “filosofia chimica” divenne il De rerum natura lucreziano, libro “proibito” per il quale il Conte Monaldo chiese licenza all’autorità ecclesiastica per consentirne la lettura ai figli. Dell’atomismo Leopardi accoglie la concezione “pagana” di eternità della materia, che si ritrova nel Frammento apocrifo di Stratone di Lampsaco, l’operetta del 1825 che condensa la “filosofia naturale” leopardiana. “Se la semplicità è principio necessario d’immortalità, neanche la materia può perire”, quali che siano queste particelle ultime, gli “elementi […] de’ chimici, o altri più remoti e primitivi” (Zibaldone). Esclusa dal piano dell’universo non è solo l’esistenza di un intelletto infinito creatore, ma anche l’ipotesi fisica di un infinito “attuale”, cioè realtà concretamente data in natura. Solo “per mezzo de’ voli astratti dell’umana immaginazione” è possibile in linea di principio affermare che la materia è divisibile in “infinito numero di parti infinitamente picciole”, tema già affrontato in una delle Dissertazioni filosofiche (dieci delle quali di argomento scientifico), quella Sopra l’estensione, scritta nel 1811, dove il giovane poeta richiama le dispute ancor vive sull’esistenza del vuoto. Per quanto infinitesime siano le parti in cui si può dividere la materia, non si potrà mai raggiungere il nulla, che costituisce il “vero” infinito, ricordano vari passi dello Zibaldone. Nella realtà fisica soltanto il niente è senza limiti: quando noi vagheggiamo l’infinito contempliamo dunque “un’idea, un sogno, non una realtà”, o meglio il nulla, visto che “l’infinito venga in sostanza a esser lo stesso che il nulla”.
Ma c’è una seconda linea del pensare leopardiano sull’infinito, quella di ordine morale-antropologica, attinta dalla Filosofia Morale di Francesco Maria Zanotti: il desiderio di felicità non conosce limiti, chi è felice crede di poter sempre più incrementare la propria condizione, ma questo richiederebbe un’anima immortale e una vita ultraterrena, conclusioni che il Leopardi maturo non è più disposto ad accettare. È di qui che prende avvio la riflessione sul carattere vago e piacevole della percezione dell’indefinito: essendo il desiderio del piacere materialmente infinito in estensione, la pena di vederne i limiti è tanto più forte quanto più questi sono scorti “da presso”. Tutti i beni appaiono bellissimi da lontano: la predilezione per “una veduta ristretta e confinata in certi modi” genera dunque piacere perché “in luogo della vista, lavora l’immaginazione e il fantastico sottentra al reale”. Così lo Zibaldone ribadisce nelle notazioni del ’25 che “l’infinito è un parto della nostra immaginazione”; e questo vale per l’infinità spaziale dell’universo, “illusione naturale della fantasia”, come vale per l’eternità del tempo. “Chi vi ha poi detto che esser infinito sia una perfezione?”.
Ma la facoltà immaginativa, come quella di conoscere e di amare, è capace soltanto dell’indefinito, da cui riceve la piacevole impressione dell’infinità; di qui la dolcezza che l’anima prova quando spazia nel vago di cui non è in grado di avvertire i confini. La costitutiva impossibilità di avere esperienza dell’infinito si risolve nell’illusione ottica con cui la poesia dà rappresentazione dell’indefinito, attraverso il gioco delle ombre, i raggi della Luna, lo spettacolo di un paesaggio che si mantiene aperto allo sguardo. Ma il poeta del vago, ricordava l’Italo Calvino delle Lezioni americane, può essere solo il poeta della precisione; l’esattezza non è capacità esclusiva del matematico, appartiene anche al poeta nella scelta meticolosa delle parole in grado di rendere il carattere flou del sentire, nella costruzione delle immagini che destano idee indefinite. “In realtà il problema che Leopardi affronta è speculativo e metafisico, un problema che domina la storia della filosofia da Parmenide a Descartes a Kant: il rapporto tra l’idea d’infinito, come spazio assoluto e tempo assoluto, e la nostra cognizione empirica dello spazio e del tempo. Leopardi parte dunque dal rigore astratto d’un’idea matematica di spazio e di tempo e la confronta con l’indefinito, vago fluttuare delle sensazioni”.
La scelta di Leopardi non è quella romantica dell’abbandono della razionalità e della fuga nell’immaginario. Il tempo presente è impoetico perché anestetizza gli affetti, invita ad utilizzare le cose, secondo i dettami della ragione calcolante, e “l’analisi delle cose è la morte della bellezza”. Certo, la filosofia moderna “non fa ordinariamente altro che disingannare e atterrare … in luogo degli errori che sterpa, non pianta nessuna verità positiva” (Zibaldone); ma, se persiste un irrimediabile contrasto tra l’aridità del vero e la felicità delle illusioni, “ancor che tristo ha suoi diletti il vero”, ricorda un verso dell’epistola “Al conte Carlo Pepoli” del 1826. La lezione dell’Illuminismo non può essere abbandonata, va semmai accolta con prudenza: “la ragione è un lume; la natura vuol essere illuminata dalla ragione, non incendiata”. Solo il linguaggio “naturale” delle immagini, non quello “snaturato” dei concetti, ritrova la consonanza con la natura: le immagini letterarie ritrovano la verità, aletheia, della natura nel suo moto di “palesamento” e “nascondimento”. Ma non viene meno la speranza in una filosofia in cui trovino posto anche il sentimento e l’immaginazione, le facoltà che restano “in armonia col poetico ch’è della natura; la ragione non lo è”. La nostra rigenerazione dipende da una “ultrafilosofia, che conoscendo l’intiero e l’intimo delle cose, ci ravvicini alla natura”.







