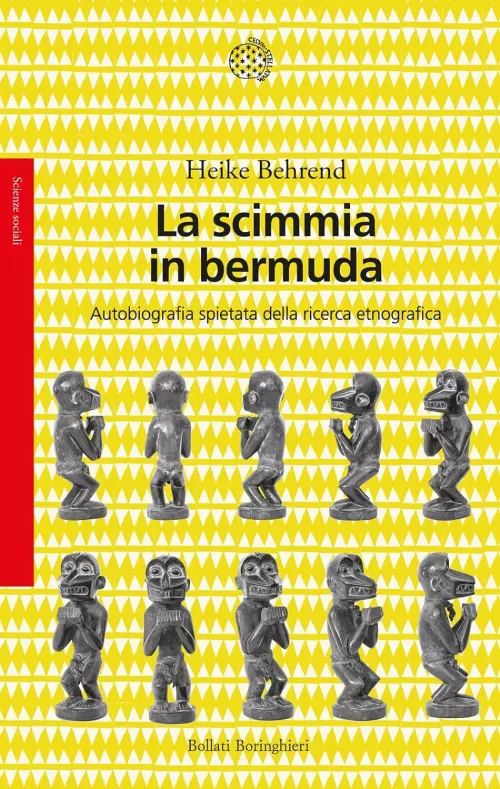Etnografia come inciampo
La ricerca etnografica è un laboratorio di ipotesi sul mondo, il mondo altrui, il proprio, ed è anche un laboratorio dove ci si interroga sui modi e sui valori della ricerca. I laboratori in realtà sono molti, tanti quanti sono gli etnografi e, nella vita del singolo etnografo, tanti quanti sono i casi che studia. È naturale, dunque, che il laboratorio conosca anche il fallimento, ma fallimento e successo sono categorie ambigue, proiettive, a volte bugiarde. Viviamo nella tranquillizzante idea che la scienza sia un percorso accidentato, destinato però – sempre e comunque – al raggiungimento di un risultato. Eppure, più spesso di quanto non si pensi, il risultato è un ridicolo nulla di fatto e allora, con un fugace senso di vergogna, si fa come quel tipo che, inciampando goffamente, si rialza e si riaggiusta la cravatta come se nulla fosse accaduto. Magari qualcuno l’ha visto, magari qualcuno ha riso sotto i baffi, ma la cravatta del Sapere è dritta e scintillante come prima.
Quando uno scienziato è abbastanza sicuro di sé, quando ha navigato molto e ha conosciuto molti naufragi, è possibile che venga visitato dal dono dell’autoironia. In questo caso, a volte non senza un certo narcisismo, si concederà il lusso di dire che ha fallito, racconterà un aneddoto buffo, i colleghi rideranno, e il fallimento verrà archiviato con un piccolo rituale apotropaico. Sono molto rari, invece, quei professionisti della ricerca che incorporano l’inciampo nel metodo, non nel senso evolutivo e progressista del “Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better”, ma nel senso del “Try anyway. Fail anyway. No better”. Perché solo a volte l’errore è una fionda verso il miglioramento e invece, molto spesso, è solo un sano e – per alcuni – vivificante ritorno del caso nell’arroganza autonarrativa della ricerca. È per questa ragione che La scimmia in bermuda di Heike Behrend (Menschwerdung eines Affen. Eine Autobiografie der ethnografischen Forschung, 2020, traduzione italiana a cura di Claudia Acher Marinelli, Bollati Boringhieri 2023) è un libro di irraggiungibile felicità autonarrativa ed epistemologica: tra le sue quasi duecento pagine troverete storie di vita e spunti di anarchia metodologica – à la Feyerabend – per un récit africano che è già un classico dell’antropologia antiaccademica.

Iniziamo dal sottotitolo: Autobiografia spietata della ricerca etnografica. Come nel titolo in italiano, che sembra orecchiare La scimmia nuda di Morris ma che restando più aderenti all’originale suonerebbe più come Le scimmie incarnate, umanate, fatte uomo, il sottotitolo inserisce un segnale, “spietata”, che nell’originale manca. Al lettore italiano viene quindi consegnato un libro che vuole forse suggerire una tensione “eretica”, antidisciplinare, anche se questo non deve distrarre da una finezza concettuale: non siamo in presenza qui dell’autobiografia di un’antropologa, ma della scienza antropologica per sé, di una disciplina che parla di sé per bocca del suo attore e che, pur adottandone la prospettiva personale, la vita contingente, parla comunque di qualcosa che ossessiona la tribù degli antropologi tutta intera: il problema del “campo”. La questione è annosa, dibattuta e complessa, perché oggi comporta il rischio di usare un termine vecchio per dire cose nuove, e perché il “terreno” è sempre più un “campo di probabilità”, un’entità scontornata, gassosa, qualcosa di quantistico più che di geografico-sociale. Intendiamoci, Heike Behrend è un’etnografa di terreno nel senso più tradizionale del termine, va in Africa orientale, ci resta, ci ritorna, il suo approccio è classico, quello che però decide di restituire con questo libro di etnografie impreviste è una riflessione sul metodo – e i suoi inciampi – che muove appunto da “storie ingarbugliate nient’affatto eroiche, equivoci culturali, conflitti ed errori”, “arrabbiature, casi fortuiti, esperienze infelici, punti ciechi” (p. 9).
Quello che accade alla ricerca quando si inceppa non è, come si potrebbe pensare e come a volte accade, un deragliare nel mood emozionale, rapsodico, nell’irrazionalismo metodologico, ma è una moltiplicazione del prisma analitico, una spinta spesso sgradevole che obbliga a mettersi nei panni dell’altro, un prospettivismo etnografico che aiuta a cambiare specola, addirittura corpo, e incarnarsi – di qui il titolo del libro – in qualcun altro. L’idea viene da più lontano, dall’etnografia della reciprocità e dall’etnografia “inversa” praticata nei suoi film da Jean Rouch, etnologo outsider che l’autrice conosce a Parigi nella metà degli anni Settanta del Novecento. Già allora la giovane anarco-comunista Behrend incorpora nel metodo lo shift prospettico dell’oggetto etnografato che diventa soggetto etnografante, del “nativo” che legge l’etnologo occidentale e coloniale come nativo e costruisce su di lui la propria etnografia, ma quello che l’autrice deve ancora capire – e che capirà sul terreno – è che lo shift, lo sguardo inverso, funziona come un lento e articolato processo di edificazione e ridefinizione identitaria del soggetto osservante. È il caso, ad esempio, dei suoi soggiorni africani a Bartabwa, nelle colline Tugen, in Kenya, dove solo dopo alcuni anni di ricerca sul campo scopre che i locali la chiamano segretamente “scimmia”.

Esplorando il campo semantico della scimmia, Behrend comprende che a Bartabwa gli stranieri sono di due tipi, i bunik, i forestieri prossimi, quelli con cui si fa la guerra ma anche ci si sposa, e i toyek, completi estranei che vivono nella boscaglia come scimmie. I toyek possono comunque acculturarsi ed evolversi, e così diventare umani perdendo – come Enkidu – la loro selvatichezza. “In quanto Scimmia, ero stata assegnata alla categoria dei primitivi e degli estranei assoluti. Non ero umana, bensì animale. Mi avevano piazzato ai margini di una cosmologia a me sconosciuta. Eppure mi veniva offerta la chance di lasciarmi alle spalle la mia natura scimmiesca” (p. 30). Dopo un lungo apprendistato Behrend è promossa a “cosa”, termine che indica una persona che non agisce ancora da adulto responsabile. Anche così, però, gli anziani si rifiutano di parlarle, a causa della sua incompetenza linguistica e dell’ignoranza delle più elementari regole di cortesia. Con perseveranza, però, l’etnologa arriva a farsi accettare e il sapere dei Tugen le viene dischiuso in maniera simmetrica alla sua “evoluzione” ontologico-culturale. Addentrandosi un po’ alla volta nel loro mondo, comprende e registra la trasformazione che sta subendo ai loro occhi, da scimmia a persona, da mostro cannibale a essere umano, da selvaggio a civilizzato, da “prigioniera di una complessa reciprocità di prospettive e immagini di alterità che si riflettevano all’infinito” (p. 38) a membro effettivo della loro cultura.
Questa storia di lento successo, tuttavia, ha un prezzo: “Credo di non essere mai stata tanto derisa in tutta la mia vita come sulle colline Tugen” (p. 46); “[ho dovuto] assumere il ruolo di una persona ridicola, di una buffona. Ogni mia azione poteva scatenare autentici scoppi di ilarità. […] Con quelle risate gli anziani si proteggevano da me e mi mostravano che continuavo a essere un’intrusa e un’estranea” (p. 47); “Le risate degli anziani, tuttavia, mi dischiusero anche uno spazio di libertà sociale che si concede solo ai buffoni. Ciò mi permetteva di passare da una categoria all’altra (persone sociali, generi) e di importunare i suoi rappresentanti con domande che loro non si sarebbero mai poste, almeno non in quel modo” (p. 47). L’etnografo come antieroe, dunque, e come bersaglio di rivalsa per l’abuso coloniale: quando viene chiamata “scimmia”, i Tugen riflettono contro Behrend un’immagine razzista che avevano dovuto subire nei decenni di dominazione bianca. Un’ennesima reciprocità che parla della dinamica di riflesso contenuta nella dialettica tra Sé e Altro, tra le alterità che ci vengono imputate e quelle che imputiamo all’altro, tra l’Altro del Sé e l’Altro dell’Altro. Un gioco di specchi sempre meno integri, chiari e definiti a causa degli intrecci globali, una “cascata di alterità scisse che si rispecchiano a vicenda” (p. 62).
Proprio in questo senso leggere La scimmia in bermuda è un esercizio di prospettivismo educante: il lettore seguirà storie divertenti piene di equivoci, gli equivoci sveleranno paradigmi inattesi, i paradigmi illustreranno nodi e snodi epistemologici, ma intanto, pagina dopo pagina, verrà invitato e accompagnato dall’etnografo a farsi etnografo dell’etnografo, come in una commedia degli errori. Perché l’errore non è solo una pietra su cui si inciampa, è un gioco di specchi in cui rinegoziare la propria identità di ricercatore, di lettore, di Sapiens.