Drammaturgie / Il “teatro nel teatro” di Eliade: un’ipotesi ermeneutica
I lettori italiani e attenti di Mircea Eliade sanno che il teatro rappresenta un interlocutore importante nella sua riflessione storico-filosofica. Il suo mastodontico corpus letterario e scientifico comprende, infatti, numerosi testi che riflettono sul lavoro degli attori e sulla funzione “soteriologica” che dovrebbe assolvere la rappresentazione drammatica. Si potrebbe ricordare, a tal proposito, almeno Diciannove rose, ossia l’ultimo romanzo di Eliade, da lui pubblicato in rumeno nel 1980, che costituisce senz’altro il documento più esplicito della sua concezione teatrale. Nel capitolo 11 del libro, il romanziere Anghel Pandele e l’attore Ieronim Thanase definiscono lo spettacolo come una «tecnica di redenzione», che procura a chi ne partecipa il raggiungimento di una misteriosa «libertà assoluta», ovvero l’evasione da un tempo e da uno spazio storico che diventa ogni giorno sempre più oppressivo, avvilente, claustrofobico.
Meno noto – almeno finora – è che Eliade non fu solo un teorizzatore del teatro e della sua essenza soteriologica. Fu anche un drammaturgo, che pubblicò nel corso della sua esistenza quattro testi teatrali (Ifigenia, Uomini e pietre, Avventura spirituale, La colonna infinita) e un frammento drammatico (1241).
Queste opere sono state raccolte e limpidamente tradotte da Horia Corneliu Cicortaş nel 2016, presso la casa editrice Bietti di Milano (Tutto il teatro. 1939-1970). Esse sono accompagnate da una densa introduzione critica, dove, da un lato, il curatore ricostruisce, con grande rigore filologico, la genesi di ciascuna drammaturgia e la sua relazione con altri testi del corpus eliadiano. Dall’altro, egli documenta la mancata realizzazione di due ulteriori drammaturgie: La commedia della morte, che Eliade immaginò nella sua mente senza mai trasporla su carta, e il libretto per opera lirica La peste di Caragea. Potremmo perciò dire, riprendendo la distinzione che troviamo nel racconto Pierre Menard, autore del “Chisciotte” delle Finzioni di Borges, che il volume di Cicortaş raccoglie l’opera “visibile” e l’opera “invisibile” dell’autore rumeno.
 Cioran, Ionesco ed Eliade a Place Fürstenberg Paris.
Cioran, Ionesco ed Eliade a Place Fürstenberg Paris.
Un lettore già esperto di Eliade ritroverà in queste drammaturgie un condensato delle idee argomentate nei suoi scritti scientifici, in particolare nel Trattato di storia delle religioni: il camuffamento del sacro nel profano (ovvero, la realtà come “ierofania”) e l’attività umana come ripetizione di un archetipo che abolisce il tempo storico, facendo entrare in un altro ritmo temporale. In questo senso, il volume Tutto il teatro a cura di Cicortaş offre un’utile summa del pensiero eliadiano. Ma se il valore delle drammaturgie di Eliade si limitasse al loro essere un compendio, esse risulterebbero in un certo senso superflue, o meglio interessanti documenti storici di un filone marginale dell’attività creativa di Eliade. Non vi sarebbe, insomma, la necessità di leggere e rappresentare i testi teatrali eliadiani, se non per divulgare Eliade ai non-specialistici attraverso Eliade stesso.
Fortunatamente, vi è almeno un aspetto profondamente originale che queste opere manifestano. Le drammaturgie eladiane indagano la natura del processo teatrale e creativo, visto come un viaggio di recupero di un sacro degradatosi in forme sterili e inefficaci, nonché descrivono i sacrifici e i dolori che il creatore deve inevitabilmente incontrare, sopportare o superare lungo il suo percorso di crescita spirituale. E dato che tale aspetto originale è esaminato meno dettagliatamente nelle sue opere scientifiche / narrative, ne consegue che i testi teatrali di Eliade offrono alcune integrazioni utili alla definizione del sacro che troviamo nel Trattato di storia delle religioni e alla prospettiva del teatro quale tecnica di salvezza descritta in Diciannove rose.
Se infatti si cerca di leggere la raccolta dei testi teatrali a cura di Cicortaş come un insieme unitario, si nota un elemento interessante e comune. Ciascuna drammaturgia di Eliade ha come protagonista un artista che sta realizzando o intende realizzare, in modo più o meno consapevole, un’opera “performativa”. Sebbene i protagonisti non coincidano sempre con un uomo o una donna di teatro, vedremo che il loro lavoro tende di continuo in questa direzione. Valorizzando tale elemento, si può riconoscere che Eliade scrive drammaturgie che non cercano di evocare esclusivamente il teatro, bensì un “teatro nel teatro”: in altri termini, un teatro che rappresenta il suo stesso fare, facendo emergere al contempo i suoi poteri e i suoi problemi.
La sola eccezione lampante a questa mia ipotesi ermeneutica è costituita dal frammento drammatico 1241, che rappresenta un episodio della storia della Romania (l’invasione dei primi stati romeni da parte dei Tartari) e in cui nessun personaggio si pone come un creatore. L’incompiutezza evidente del testo è sufficiente, tuttavia, a ridimensionare questa difficoltà. Non sappiamo come la vicenda di 1241 si sarebbe potuta sviluppare, pertanto non possiamo escludere che anche qui il protagonista (forse Marina, la figlia del principe?) si sarebbe posto come un creatore che dà alla sua attività una direzione performativa. Le quattro drammaturgie compiute offrono, invece, sufficienti sostegni per suffragare la mia proposta, come proverò di seguito ad argomentare, studiando sommariamente il loro contenuto.
 Crazy Jane di Richard Dadd.
Crazy Jane di Richard Dadd.
Il dramma Ifigenia è il testo in cui emerge meno esplicitamente la dimensione performativa. Protagonista dell’opera è l’omonima figlia di Agamennone e Clitemnestra, dunque una giovane vergine e non un’artista di teatro. E tuttavia, il sacrificio che Ifigenia decide di compiere per consentire la partenza dei Greci verso Troia è di fatto assimilato da Eliade a un atto performativo, partecipando al quale la comunità si salva dalla miseria materiale e spirituale in cui aveva finora vissuto. Il gesto della fanciulla impedisce, ad esempio, le nozze di Achille, a cui era stato predetto che sarebbe morto in tarda età ma dimenticato da tutti, se avesse formato una famiglia in Grecia, mentre sarebbe deceduto giovane e tuttavia ricordato in eterno per le sue gesta eroiche, se fosse andato in guerra. La dissoluzione di Ifigenia comporta, dunque, un paradossale atto di creazione teatrale e un raggiungimento dell’immortalità. Come afferma lei stessa, il suo sacrificio o – in termini positivi – il suo rito nuziale con la morte dà inizio, infatti, a «un altro mondo», che altrimenti sarebbe risultato ignoto e inaccessibile, dove Achille trova la gloria in battaglia e con essa la vita nel ricordo delle generazioni future.
A ulteriore riprova della dimensione performativa e creativa del gesto di Ifigenia è che la drammaturgia di Eliade prevede che il suicidio della fanciulla venga recitata dagli attori sul palcoscenico. Questo semplice ma eloquente fatto comporta la chiara presa di distanza dal repertorio tragico classico, in cui il sacrificio della fanciulla o avviene fuori scena, come nell’Ifigenia in Aulide di Euripide, o viene sventato prima che abbia luogo, che è quel che accade nell’Ifigenia di Racine. Il rito nuziale di Ifigenia con la morte è pertanto teatrale perché è, appunto, un rito portato sulla scena. Il gesto rituale è in fondo spesso descritto da Eliade come una delle fonti del teatro. In termini espliciti, ciò è asserito, ad esempio, nel cap. 1 del Trattato di storia delle religioni, o in alcuni appunti scritti nel marzo 1959 del suo Giornale (ed. italiana 1977), in cui lo scrittore discute la teoria di William Ridgeway della nascita della tragedia dal culto dei morti (The Origin of Tragedy, 1910).
In Uomini e pietre, che mostra il poeta Alexandru e lo scienziato Petruş nell’atto di esplorare una grotta rimasta inoccupata dai tempi della preistoria, la dimensione teatrale risulta invece esplicita. Alexandru è un artista di teatro, come si evince sia dal finale dell’atto primo, in cui si scopre che il personaggio è autore di un’opera teatrale, sia dalla qualità della sua immaginazione, che è essenzialmente drammatica. Quando si trova a immaginare la vita degli esseri che avevano abitato la grotta, infatti, egli si figura sempre dei piccoli quadri scenici, ad esempio quello di una fanciulla che è portata in sposa a un orso. Il punto di svolta decisivo di questa drammaturgia è il momento in cui Alexandru si rende conto di non poter riuscire a rappresentare la paura originaria che provarono i primitivi che abitarono questa caverna. Tale esperienza – unita alla scoperta di una nuova specie di parassita, i troglobi, che gli mostrano a quale picco di degradazione si può ridurre la vita organica – fa sì che il giovane abbracci di colpo il nichilismo, dunque respinga la bellezza e la sacralità delle cose che prima riusciva a percepire («Non è meglio negare, calpestare, dissacrare?»).
Un incidente avvenuto durante la discesa porterà Alexandru, tuttavia, a provare un intenso dolore fisico che lo induce a rinvangare il mondo «irrealmente bello» fuori dalla grotta e a riscuotersi dalla crisi dei valori, arrivando peraltro a un’agnizione “mistica”. Le esperienze della vita (inclusa la paura originaria dei primitivi) risultano irrappresentabili non per incapacità dei suoi mezzi poetici, ma perché sono di per sé impossibili da rappresentare. Dalla credenza di un fallimento personale e soggettivo si passa, in modo brusco ma rasserenante, al riconoscimento di un fallimento strutturale e oggettivo, in cui incorre inevitabilmente persino l’arte teatrale che Alexandru tenta invano di coltivare. Con tale scoperta, Uomini e pietre apre le porte a una nuova drammaturgia possibile, in cui il teatro ha lo scopo di esaltare più che di spiegare il mistero bello della vita.

Dipinto della cappella di San Brizio DI Luca Signorelli, forse rappresentante Empedocle
Ben più articolato è senza dubbio il testo Avventura spirituale. Qui, il tema del “teatro nel teatro” è stavolta assai evidente e raggiunge picchi a dir poco labirintici. Avventura spirituale non è, infatti, solo il titolo del dramma di Eliade. Esso è un concentrato di drammi omonimi, che annoverano almeno, in ordine di apparizione: 1) l’opera teatrale che il drammaturgo Manciu dice di aver già scritto nel primo atto; 2) la commedia che Manciu allestisce ai danni di Ştefania tra il primo e il terzo atto, facendola fidanzare con colui che lei crede essere il compositore Barbura, quando in realtà si tratta del suo confidente Baranda, che assistette Barbura fino alla morte; 3) la prima avventura spirituale di Ştefania, che fidanzandosi con il falso Barbura si convince di essere la reincarnazione della sua ex-moglie Christina, morta annegata da diversi anni, e si paragona a un’Euridice riscattata da Orfeo; 4) lo spettacolo che un regista allestisce a partire dall’opera teatrale di Manciu e che questi vede all’inizio dell’atto quarto, ma non riconosce come suo («Allora, o sono io che ho dimenticato il testo, oppure si tratta di un’altra pièce, con lo stesso nome, di un altro autore!»); 5) la seconda avventura spirituale di Ştefania, che dopo aver rotto il fidanzamento con Barbura/Baranda si abbandona a una vita dissoluta, a un’autentica «discesa all’inferno», che le permette di comprendere il vero significato del mito di Orfeo ed Euridice.
In tutta questa confusione labirintica, che Eliade allestisce volutamente per rispecchiare il carattere infernale che può assumere la nostra esistenza, l’aspetto essenziale che emerge è che da una simile esperienza sono i più deboli a entrare in contatto con il sacro. La sola che sembra apprendere qualcosa dagli eventi è in fondo Ştefania: colei che finora era la spettatrice inerme delle macchinazioni di Manciu, il quale invece finisce per non capire più nulla, persino a non riconoscere l’opera da lui stesso creata. In modo simile ad Alexandru di Uomini e pietre, che solo da ferito riesce a comprendere (senza poterlo esprimere) il mistero della vita, o ai sacerdoti deformi descritti nel cap. 1 del Trattato di storia delle religioni di Eliade come portatori di ierofanie, così in Avventura spirituale è una debole vittima a trarre unico giovamento dall’avventura medesima.
Come l’Ifigenia, infine, anche La colonna infinita – titolo desunto dal nome dell’ultima scultura creata da Constantin Brâncuşi a Târgu Jiu – sembra a prima vista aver poca attinenza con la rappresentazione di un artista che dà una direzione performativa alla sua attività creatrice. Eliade si ispira appunto a uno scultore e non a un uomo di teatro, con l’intento di indagare le cause della sterilità creativa in cui l’artista cadde dopo aver terminato il suo capolavoro, in genere spiegato con la delusione che dovette provare per non essere riuscito a realizzare il mausoleo d’Indore in India. La lettura attenta del testo dimostra, però, che il personaggio Brâncuşi è connotato come un artista di ispirazione performativa.
L’azione drammatica si sviluppa, anzitutto, grazie ai discorsi di una giovane attrice, che afferma di aver capito dalle opere dello scultore che questi è il solo a conoscere il «mistero della danza» e di essersi recato da lui per apprenderlo. A detta della donna, le sue sculture sono opere coreografico-performative, in quanto danno alla pietra la possibilità di volteggiare in alto leggera e di sospendere per un momento la forza di gravità che la trattiene a terra. Ciò vale sia per la compiuta Colonna infinita, simbolo del duro lavoro a cui l’artista si sottopone per avvertire che è proprio della condizione umana partire da una fossa fino ad arrivare al cielo e per sottolineare la difficoltà di tale ascesa, sia per il mai realizzato mausoleo d’Indore, che era concepito come un nuovo labirinto di Dedalo in cui un esploratore avrebbe intrapreso una «danza labirintica» e incontrato al suo centro non il Minotauro, bensì il suo Io. In secondo luogo, Brâncuşi stesso riconosce che chi guarda le sue sculture con intelligenza e immaginazione sono presi dall’impulso a «cantare e a ballare per la gioia, poiché non sei più ciò che eri prima», quindi a reagire in senso performativo, cosa che non avverrebbe se le sue sculture non avessero tale qualità.
In terzo luogo, va notato che Eliade suggerisce alla fine del suo dramma che lo scultore abbandonò il mausoleo d’Indore perché si rese dolorosamente conto che dopo la Colonna infinita nulla più poteva essere tentato e l’unica cosa sensata che restava da compiere per comunicare il sacro era fare silenzio, che è di nuovo una concezione di ispirazione teatrale. Come i silenzi a teatro risultano udibili quando si decide di non produrre suoni o parole, così la scultura – secondo il personaggi di Brâncuşi – dice l’ineffabile quando rifiuta di far danzare e cantare la pietra, ovvero decide di non scolpire. Forse il più “statico” e didascalico dei drammi eliadiani, La colonna infinita ha, però, il merito di suggerire l’interessante prospettiva che tutte le arti (scultura inclusa) tendono inconsciamente alla teatralità, vale a dire alla capacità di esprimere l’inesprimibile con la rinuncia deliberata a dire e a fare alcunché.
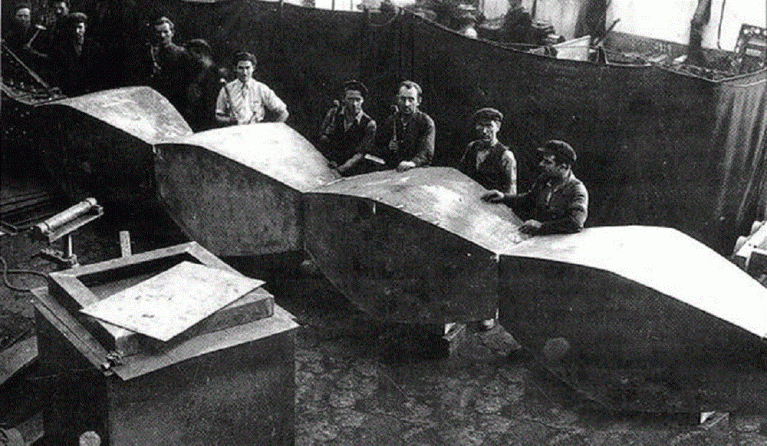 Foto della costruzione de La Colonna infinita di Brancusi.
Foto della costruzione de La Colonna infinita di Brancusi.
Il teatro di Eliade che è stato parzialmente studiato in questo saggio può essere allora descritto, in conclusione, come un teatro che riflette sulla sua stessa natura, individuando in sé una grande virtù e un suo forte limite. La virtù di cui dispone è quella di riuscire ad allestire dei riti sulla scena che aprono le porte per altri mondi e provocano, nei soggetti particolarmente deboli o suscettibili, un’elevazione spirituale, cioè un accesso al sacro. Il teatro è definibile, in questo senso, come un “patire”. Poiché sono coloro che vengono feriti o che addirittura trovano la morte – come Ifigenia, Alexandru, Ştefania, Brâncuşi – a percepire cose che sfuggono agli esseri umani sani e forti. Il limite di cui soffre il teatro consiste, invece, nel suo necessario fallimento a rendere intelligibili queste esperienze spirituali, che eppure riesce a evocare coi suoi personaggi.
Ifigenia allude a un mondo nuovo di cui non sapremo niente, Alexandru avverte una bellezza misteriosa della vita che non riusciamo a cogliere, Ştefania ci dice di aver finalmente capito il significato del mito di Orfeo ed Euridice che a noi sfugge del tutto, Brâncuşi descrive l’elevazione che l’umanità può ricavare dalla danza delle pietre e dal silenzio, ma che noi non riusciamo ad attuare. Nessuno di loro ha successo, insomma, nel dare forma, colore ed espressione alle loro intuizioni superiori, che ci vengono donate senza darci anche gli strumenti per capirle, o per realizzarle. Con la sua capacità di creare forze e visioni intense che restano inutili o inerti nelle nostre mani, il teatro manifesta di essere quello che è forse da sempre: un’arte grandiosa e misera al tempo stesso.
Per una visione più completa di Mircea Eliade e un inquadramento storico - e soprattutto ideologico -più dettagliato della sua figura, si veda l'articolo di Enrico Manera, "Mircea Eliade. Uno sciamano contemporaneo".







