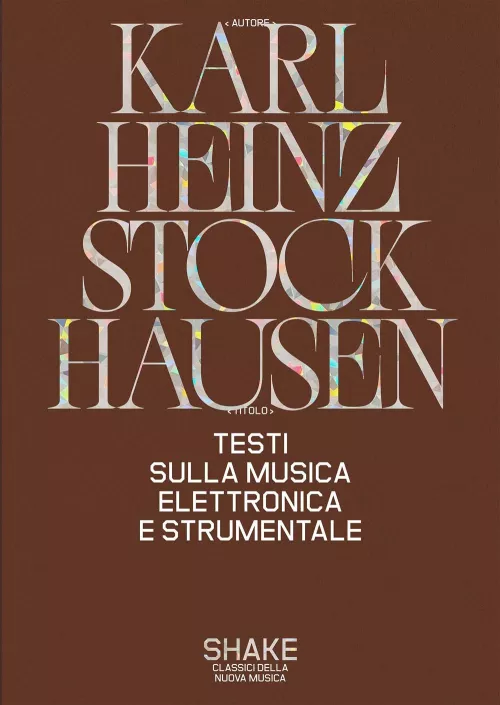Stockhausen e l’invenzione del suono
“La vera utopia è l’equilibrio” (p. 234) – con queste parole si chiude la preziosissima raccolta di saggi di Karl Heinz Stockhausen appena pubblicata da Shake Edizioni (Karl Heinz Stockhausen, Testi sulla musica elettronica e strumentale, Shake Edizioni 2024). In questo denso e impegnativo volume sono raccolti testi composti tra l’inizio degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta. Si tratta di riflessioni sul senso del comporre musica, strumentale ed elettronica, che si concentrano su alcuni concetti teorici intorno a cui ogni fenomeno musicale dovrebbe obbligarci a riflettere. Certo, che la pratica artistica si accompagni alla riflessione teorico-speculativa intorno alle strutture e alle metodologie di volta in volta utilizzate, è una possibilità; ma non è affatto scontato – anche se, almeno a partire dal diciannovesimo secolo, questa commistione sarebbe diventata quanto mai diffusa. Sino ad esplodere con l’avvento delle Avanguardie Artistiche agli inizi del Ventesimo Secolo. Sì, perché tutti i grandi protagonisti dell’arte visiva, dell’arte musicale e dell’arte poetica etc. etc., a cavallo tra l’800 e il 900, si sarebbero interrogati sul senso del proprio ‘fare’. Si pensi solo ad artisti come Kandinsky, Schoenberg, Mondrian, Stravinsky, Marinetti, Duchamp e Valéry. Ma anche a Cage, Fontana, Klein, Varèse e Rothko… una lista che potrebbe evidentemente continuare a lungo. O a chi, nella seconda metà del Ventesimo secolo, doveva rivoluzionare in forma davvero radicale il modo di comporre musica; cioè a Karl Heinz Stockhausen.
Sorprendente è anzitutto che, nei saggi compresi in questa ricchissima raccolta, il nostro rifletta sull’arte dei suoni con rigore quasi “fenomenologico”; e soprattutto che rifletta sul senso dell’esperienza musicale tanto dal punto di vista del compositore quanto da quelli dell’esecutore e dell’ascoltatore. Mostrando di concepire l’esperienza del comporre come una radicale ricerca di ‘equilibrio’; e anzitutto, di equilibrio tra “parte” e “tutto”.

Non può certo stupire che al compositore tedesco sembrasse che ‘qualcosa di effettivamente nuovo’ fosse accaduto nell’universo dei suoni solo a partire dall’ultima scuola di Vienna e soprattutto da Anton von Webern. E che, conseguentemente a questa rivoluzione, fosse radicalmente mutato anche l’orientamento dell’ascolto – sempre più specificamente caratterizzantesi come meditativo, piuttosto che come ascolto a richiesta. E che solo in virtù di questa svolta potesse emergere in modo sempre più chiaro l’elemento individuale della totalità, o del diverso nell’unità – insomma, un elemento dotato degli stessi diritti di qualsiasi altro, ma comunque in grado di dar forma a un ordine complessivo fondato su una radicale assenza di contraddizioni. Dove, cioè, né il tutto potesse sentirsi autorizzato a contraddire la parte limitandosi a risolvere e superare (ossia, silenziare) le sue ‘contraddizioni’, né la parte potesse contraddire il tutto rischiando di far saltare l’equilibrio complessivo.
Insomma, dobbiamo riconoscere che, per Stockhausen, ogni sana organizzazione d’ordine dei suoni implica sì la subordinazione dei suoni a un principio unitario, ma è sempre anche caratterizzata da un’evidente “assenza di contraddizioni tra l’ordine del singolo elemento e quello dell’insieme”.
Interessante, davvero, questo proposito; curioso, questo specifico interesse da parte del compositore tedesco per l’assenza di contraddizioni; quasi in controtendenza con tutta la tradizione idealistica – operante ancora in molte avanguardie del primo Novecento –, impegnata, al contrario, in una incessante esaltazione delle contraddizioni, e soprattutto della loro potenza generativa.
Al punto che, per il nostro, ogni organizzazione del materiale sonoro dovrebbe porsi, come primo obiettivo, quello “di non avere contraddizioni”. Tenendo fermo il dominio dell’Uno in modo tale che tutti i criteri di organizzazione insiti nel brano siano già contenuti nell’elemento unitario, in modo tale da esprimerlo, davvero, “senza contraddizioni”.
Oltremodo sorprendente, comunque, questa ratio in radicale controtendenza rispetto all’ormai diffusissimo culto delle dissonanze, dei contrasti e dunque sempre anche delle contraddizioni; una ratio che avrebbe comunque dovuto fare i conti con almeno quattro delle dimensioni caratterizzanti il suono in quanto tale: la durata, l’altezza, il grado di dinamica e il timbro. Nei cui confronti il compositore non avrebbe mai potuto adagiarsi sul terreno sicuro costituito dalle cosiddette note “già pronte”, risultanti da regole organizzative già date; ma disporsi piuttosto a sperimentare l’originario emergere della musica… che avrebbe potuto nascere solo davanti a lui.

Una cosa, comunque, è certa: il volume di cui vorremmo far emergere alcuni punti di forza alterna studi molto tecnici (rivolti agli addetti ai lavori) – dedicati ad esempio a composizioni di Anton Webern –, a saggi di tipo teorico concettuale su questioni per Stockhausen particolarmente rilevanti; ma contiene anche delle vere e proprie guide all’ascolto di alcune sue composizioni.
Di particolare interesse è però anzitutto il saggio del 1953 dedicato alla nascita della musica elettronica; dove il nostro rileva come i suoni degli strumenti tradizionali fungano ormai da vero e proprio ostacolo per chiunque intenda subordinare le diverse strutture musicali a un comune e razionale principio di proporzione. Fortunatamente, sempre secondo Stockhausen, nella composizione odierna la tecnica seriale aveva spinto a “comporre” e dunque a ‘decidere’ finanche il “timbro” delle singole note. Non solo l’altezza, il ritmo e le relazioni tra le note potevano cioè venire composti; ma addirittura il timbro – che, nel caso degli strumenti tradizionali, è invece sempre ‘già dato’.
In ciò una nuova e straordinaria opportunità viene offerta dalla musica elettronica.
Insomma, si era finalmente tornati “all’elemento che è alla base di tutta la varietà dei suoni, ossia a quella oscillazione pura che si può produrre elettricamente e che viene chiamata sinusoide” (p. 35).
Quello che Stockhausen vedeva emergere era cioè un significato assolutamente inedito del suono individuale; è vero, egli vedeva profilarsi all’orizzonte una interessantissima dialettica tra questo suono e l’idea formale di livello superiore – la sola che avrebbe consentito il raggruppamento dei suoni in vere e proprie figure musicali.
Ad ogni modo, la novità costituita dalla musica elettronica (che esiste dal 1953) faceva seguito all’opera di distruzione realizzata dalla musica dodecafonica e dai suoi ulteriori sviluppi. Che avevano reso del tutto inutilizzabili i materiali sonori offerti dagli strumenti tradizionali.
Per questo la questione della ricerca ‘sonora’ era diventata oltremodo centrale. Il compositore si sentiva sempre più esplicitamente autorizzato a crearsi da sé finanche i suoni; sì che ogni forma di predeterminazione timbrica venisse ben presto e definitivamente abbandonata. Il materiale sonoro e la struttura formale del brano cominciavano a costituirsi, sempre più esplicitamente, come un’unica entità. E tendeva a svanire ogni forma di datità – ché avrebbe costretto l’impulso creativo e compositivo a conformarsi alle possibilità concretamente offerte dagli strumenti e dalle gamme sonore dai medesimi messe ogni volta a disposizione. Il compositore, insomma, si trovava a comporre finanche la materia cui avrebbe dovuto dare una determinata forma.
Il fatto è che la creatio ex nihilo stava cominciando a diventare una realtà a disposizione di tutti; e la potenza del creatore artistico diventava sempre più simile a quella di Colui il quale aveva necessariamente fatto tutto a partire dal nulla.

Per questo Stockhausen doveva finire per convincersi che le nuove tecnologie (utilizzate appunto nel contesto della musica elettronica) stessero per diventare una sorta di “seconda natura”. Di fatto, esse erano già diventate una vera e propria seconda natura – che consentiva ai compositori di “scoprire nuove forme in modo realmente sperimentale”. Radicalmente sperimentale, proprio in quanto, non essendo più possibile fare affidamento sulle possibilità offerte dagli strumenti tradizionali, non ci si poteva più limitare alla sperimentazione delle forme che un certo materiale sonoro rendeva effettivamente realizzabili. Le forme, insomma, non attendevano più il placet del materiale sonoro effettivamente a disposizione; ma potevano finalmente concrescere insieme a una vera e propria invenzione di nuovi e inauditi spettri sonori.
Per questo, tanto il compositore quanto l’ascoltatore, nella incessante e ineludibile ricerca di un reale e ben fondato equilibrio compositivo, avrebbero finito per muoversi, in virtù di una nuova disposizione ‘creatrice’, alla ricerca di un più intelligente e sano equilibrio tra “invenzione” (che è sempre invenzione di forme inesistenti grazie a un metodo deduttivo simile a quello della scienza moderna) e “scoperta” (fondata su una reale attenzione all’inaspettato, all’estraneo che può ogni volta sorprenderci, e che magari esisteva già ma era ancora nascosto) – disposizione o attitudine che ogni felice e riuscita composizione sembrava avere il compito di perseguire, quanto meno a partire dalla consapevolezza che quanto mai difficile sarebbe stato “separare l’invenzione dalla scoperta tanto nella composizione quanto nell’ascolto”.
Ma nel 1961 la posizione teorica di Stockhausen doveva farsi ancora più radicale; perciò avrebbe affermato che “qualsiasi percezione può diventare musica”. Il fatto è che, per lui, “la percezione di un qualsiasi fenomeno, la riflessione su un qualsiasi pensiero incontrato nell’immaginazione di una persona creativa, potevano diventare lo stimolo per realizzare nuove composizioni o elementi compositivi” (p. 209). Anche se solo là dove si fosse riusciti a farli diventare musica, ci si sarebbe potuti ritenere dotati di effettivo ‘talento musicale’. E si sarebbero potute creare delle forme “puntillistiche” in grado di consegnare uguale importanza a tutti gli elementi musicali, a tutti i suoni con le loro diverse proprietà, senza far mai degenerare l’organismo in una struttura uniforme destinata alla mera ripetizione.
Sempre in questa direzione, comunque, il compositore tedesco cominciò anche a fare uso anche delle cosiddette “forme polivalenti”; in virtù delle quali non ci si sarebbe più dovuti limitare ad indicare (agli esecutori) un’unica soluzione possibile, “ma diverse soluzioni, tutte ugualmente valide”. Sì che spettasse solo all’esecutore scegliere quella che gli fosse sembrata più opportuna (facendosi lui stesso in qualche modo compositore); pur facendo attenzione a che nulla risultasse semplicemente ‘arbitrario’. Anche perché ogni singola decisione “avrebbe impresso al corso della forma una direzione irrevocabilmente nuova necessariamente destinata ad incidere sul tutto” (p. 222).
Certo, per il nostro le questioni più importanti rimanevano quelle che “possono contribuire alla percezione, nel modo più accurato possibile, delle forme singole nell’unità di tutte le forme” (pp. 232-233). Anche se sarebbero stati davvero in pochi a rendersi conto che “oggi ci sono scopi spirituali incomparabilmente più importanti di quelli fisici” (p. 233).
Auspicabile diventava, dunque, sempre per Stockhausen, che le scoperte nel campo delle arti potessero unirsi a quelle di tutti gli altri settori della vita, affinché le forze rivoluzionarie e quelle conservatrici dello spirito potessero trovare ancora una volta un felice equilibrio. Che sarebbe stato poi anche equilibrio tra permanenza e mutamento, tra identità e differenza, ma anche tra esigenza innovativa ed esigenza conservativa, tra singolo suono e forma compositiva, tra materiale sonoro e forma sonora. Quali condizioni imprescindibili per il costituirsi di “una nuova prassi di esecuzione e di ascolto, in cui ogni singola opera musicale potesse venire liberamente utilizzata” (p. 193).