La nuova biografia di Paola Tonussi / Emily Brontë: o ragione o frusta
È a una certa idea di disobbedienza che la storia della letteratura deve tra le sue pagine più rivoluzionarie. Raccolti in bauli appunti e bigliettini trovati nella sua ultima stanza belga, fogli nei quali il poeta invocava la catastrofe del colera che spazzasse via lui, la sua opera e l’intero genere umano, i curatori di Baudelaire ne licenziarono le opere postume, dopo che la madre ne ebbe spurgate lettere e scritti ritenuti, per la di lei sensibilità, sconvenienti; Verlaine pubblicò in patria opere di Rimbaud, all’insaputa dell’autore ormai immerso nel mal d’Africa; Max Brod mancò alle volontà testamentarie di Franz Kafka e rese pubblici gli inediti che l’amico gli aveva lasciato in eredità perché li distruggesse (sic).
Il 9 ottobre 1845, poche ore dopo il colpo di pistola che il padre sparava ogni mattina dalla canonica per dare inizio alla giornata, Charlotte Brontë, futura autrice di Jane Eyre, era immersa nella lettura del quaderno segreto di poesie che la sorella Emily aveva incautamente lasciato incustodito sullo scrittoio del salotto. “Non conosco – altra donna – che abbia mai scritto poesia simile – Concentrato di vigore, chiarezza, perfezione – uno strano pathos potente sono le loro caratteristiche” (lettera settembre 1848 (?) di Charlotte Brontë a W.S.Williams). Superata la bufera che Emily scagliò contro la curiosità dispettosa e ammirata della sorella, Charlotte la convinse alla pubblicazione sotto pseudonimo. Mesi dopo, augurandosi che anche in Emily finalmente brillasse “una scintilla di giusta ambizione,” Charlotte, con la determinazione che mancò ai fratelli, si lanciava alla ricerca di un editore per i romanzi scritti di notte “su carta brunita” dalle ragazze, raccolte nel soggiorno “come in un fortino”. Il seguito è noto.
Senza tema di affrontare gli strali di una scrittrice che tutta la vita rifuggì con fermezza mondanità ed esteriorità – arrivando a distruggere anche molti documenti personali tra i quali, probabilmente, il secondo romanzo che stava scrivendo al momento della morte, della cui esistenza controversa in questo libro vengono addotte le prove – con il suo Emily Brontë (Salerno editrice, Roma, 2019, pp. 400, 29€), Paola Tonussi riscatta con narrazione empatica una biografia che, fin dai suoi primordi, fu addomesticata per trasformarsi, come capita ai grandi miti, in un clamoroso falso.
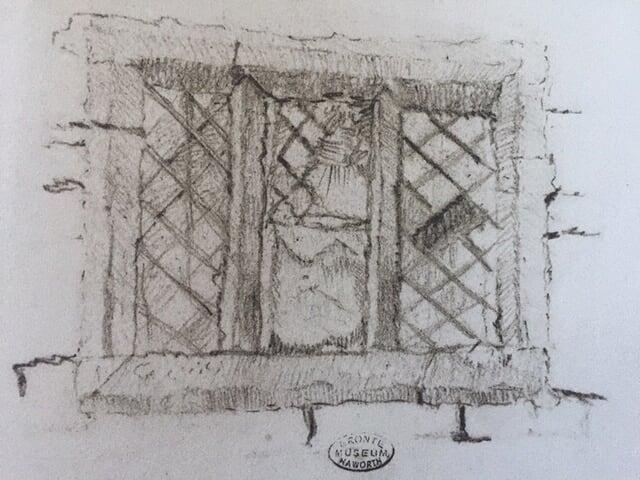
Charlotte fu la prima artefice dello stereotipo che consegnò al mondo Emily come una scrittrice ingenua e che, con gli “homely tools” di un’inesperta giovinetta della brughiera che nulla sapeva della vita vera, aveva inopinatamente licenziato un romanzo feroce e “ardente” (cfr. Prefazione del 1850 a Cime tempestose, di cui segnaliamo la nuova edizione, licenziata alla fine del 2019 presso Einaudi, a cura di Monica Pareschi, con una traduzione di attenta finezza, coraggiosa nella resa di una lingua che resta ostinatamente moderna). Un secondo colpo fatale all’esegesi biografica relativa all’intera famiglia Brontë venne dalla penna risentita della prima biografa ufficiale Elisabeth Gaskell, amica di Charlotte, la quale, in odio al pastore Patrick Brontë, padre delle ragazze, che aveva avuto l’ardire di declinare l’invito a riceverla per parlare di moglie, figli e sorelle morte, alimentò una serie di piste svianti che, fino a oggi, inquinavano la ricerca degli studiosi, dando vita anche a divertenti deliri complottistici, di grande moda soprattutto negli anni ’30 del secolo scorso, per i quali, come raccontato ad esempio nel romanzo di Stella Gibbons La fattoria delle magre consolazioni (1932, trad. di B. Mora, astoria, Milano, 2010), il vero autore dei romanzi delle sorelle Brontë sarebbe stato il fratello, Branwell – nella realtà estremamente versato per la pittura e l’autodistruzione.

Ripulendolo dalle diverse inesattezze biografiche, Paola Tonussi ricompone con perizia certosina il puzzle della formazione dei fratelli Brontë, per cominciare mettendo a fuoco Patrick Brontë che, ben lungi dall’essere un padre severo e arcigno come tramandato, fu un didatta attento e illuminato. D’origine irlandese, egli aveva studiato a Cambridge e, sostenuto dal sussidio per poveri, si addottorò in teologia e studi classici, prima di essere ordinato pastore. Rimasto presto vedovo con sei pargoli, ormai di stanza presso la parrocchia di Haworth, Patrick Brontë avrebbe adottato per i figli un’educazione sperimentale rispetto ai tempi e alla società. Assecondando le inclinazioni artistiche e intellettuali dei bambini, egli parlava di politica e filosofia anche con le figlie benché femmine, senza censurare nessuna sezione della biblioteca privata, accessibile a tutti, così come lo era la lettura dei giornali. Approfondì con loro lo studio della musica – Emily era una pianista provetta – e della pittura: il solo ritratto delle sorelle Brontë giunto a noi è per mano di Branwell che, in un momento di disperazione, decise di cancellare il proprio volto lasciando al centro della tela, in luogo dell’autoritratto, un’eloquente macchia. Il reverendo insegnò ai figli le lingue antiche e moderne e un giorno Emily avrebbe tradotto parti intere dell’Eneide. Anche la zia Branwell viene ricordata come una sorta di strega del focolare che con le sue riviste metodiste spaventava i bambini, per poi in realtà dedicar loro vita e risparmi. Un’altra vulgata nata dalla memoria di Charlotte dipingeva Emily come una scrittrice sprovveduta e priva di una reale formazione letteraria, incapace di imbrigliare i personaggi da lei inventati che, autonomamente, avevano finito per sfuggirle di mano, come ricordato nella Biographical Notice per la ripubblicazione di Cime tempestose due anni dopo la morte della sorella.
Gli scritti autobiografici lasciati da Emily si limitano a qualche pagina di diario, poche lettere e i Devoirs del periodo di Bruxelles; così lo scavo biografico è costretto alle pieghe delle opere ed è nelle pagine dedicate alla esegesi dei testi, alle fonti e ai modelli ispiratori (Ossian, Blake, Wordsworth, Walter Scott, Mary Shelley, e il totemico Lord Byron sopra tutti), alla lingua di Emily (allergica alla aggettivazione, quanto definitiva nella scelta dei sostantivi, e il felice matrimonio di cime con tempestose ne è simbolo assoluto), alla scrittura moderna, alla costruzione dei personaggi, al paesaggio (l’erica piegata dal vento, l’aria gelida della brughiera, la terra arida e ghiacciata) che la scrittura di Paola Tonussi aggancia il pensiero di Emily facendosi una sola voce palpitante.

Una sera d’inverno, finito di desinare, Patrick Brontë inventò un gioco intorno al tavolo: perché quei figli, così timidi e impacciati, si sentissero liberi di rispondere con la verità alle sue domande, fece indossare loro una maschera. “Ragiona con mio fratello e, se non vorrà ascoltar ragione, frustalo,” fu la risposta di Emily dopo un battibecco che aveva coinvolto il genitore e Branwell. Il mascheramento libera le parole nette di Emily che divide il mondo in due e, tra il chiaro e lo scuro, non ammetterà mai la sfumatura della via di mezzo. Le parole saranno la sua fortificazione, la fantasia la maschera che nella scrittura la salverà dalla prosaicità di quanto accade all’esterno e dai vili rapporti sociali. Come le sfide a soldatini con i fratelli, il mondo inventato nelle pagine di Emily è il regno della permanenza, mai raggiunto dalla morte che condanna l’uomo e la sua carne alla finitudine. Nel suo immaginario l’ordine della consuetudine è sovvertito, e se la madre biologica giacerà per sempre sotto le lastre della chiesa calpestate dai fedeli a ogni messa, la vera nutrice sarà la terra, la sola culla che non tradisce e che aspetta paziente di poter cullare di nuovo i figli che tornano a morire per rinascere nel suo grembo. La nostalgia di casa che divorò tutta la vita Emily era il richiamo alla casa madre, alla natura che, nella mise en abyme dei cani e di tutti gli animali che Emily salvava, le offriva l’autenticità dei sentimenti, la crudezza di rapporti estranei a qualsiasi compromesso.
Oltre alle poesie e al romanzo, il saggio di Paola Tonussi dedica molta attenzione a Gondal, la saga infantile che per la studiosa italiana fu “l’apprendistato di Emily come autrice.” Il ciclo, che segnerà la narrazione della maturità artistica, fu scritto e inventato insieme alla sorella minore, Anne, e permette di seguire l’evoluzione di una immaginazione che, inizialmente fantasiosa e fatata, negli ultimi anni segnati da fatica, dolore, perdite, delusioni e malattia, si fa visionaria e spietata, raccontando di omicidi efferati, prigioni, guerre, violenze e sangue ovunque: in Emily la cognizione del male ha ucciso anche l’ultima speranza.
Il saggio si chiude su Heathcliff, l’eroe di Cime tempestose che entra nel mondo senza cognome, come un dio. Il suo nome parla dei luoghi prediletti dalla scrittrice: heath, la brughiera, cliff, la vetta. Heathcliff si materializza nel gelo della bufera, figlio del vento, padre seduttore e paziente, che unisce e separa con la tempesta, che isola la casa nella brughiera dal resto del mondo e violenta i rapporti tra i protagonisti. Già mortalmente malata, allo stremo delle forze, quasi fino agli ultimi giorni di vita Emily non rinuncerà alle passeggiate, per sentire ancora una volta gli aghi del gelo attraversarle il corpo, ormai quasi liberato dalla vita terrena.

In vita sua Emily Brontë non si rassegnò mai alla perdita, rifiutò l’addio, negò il distacco da chi le moriva accanto. Nella sua opera i morti non sono mai del tutto morti, ma vivono più dei vivi, anche dopo che la carne non sente più le catene del corpo, “una prigione in rovina.” Heathcliff è l’innamorato maledetto per antonomasia, il quale, incarnando la disperazione del rifiuto d’amore, trasforma la ferocia di una passione bianca in sempiterno vessillo contro la morte e il gelo della vita.
Con lui si assiste alla cristallizzazione ordita da Emily Brontë dell’archetipo dell’orfano, un bambino innocente eppure crudele perché svezzato con la sofferenza. La passione tra lui e Catherine risponderà all’inganno che l’amore possa salvare dal vuoto atavico di un’infanzia tradita dalla felicità, il sentimento più fragile d’un regno ormai perduto.
Durante il loro ultimo incontro, mentre Catherine sta varcando per prima la soglia che separa i vivi dai morti, Heathcliff la maledice, accusandola del peccato più grave che, secondo Emily, è l’infedeltà. Catherine ha tradito il loro sacro patto infantile, perché lei, e non Satana né Dio, li ha separati: “Tu mi amavi – che diritto avevi allora di lasciarmi?”. Sì, perché l’amore è un dovere inalienabile che esige responsabilità, e Catherine è rea di essersene dimenticata sposando l’uomo delle convenienze.
La condanna che Heathcliff reclama per entrambi è che la morte non chiuda la loro partita, e che l’eterno affanno li tenga per sempre avvinti. La morte di Catherine sarà così la rinascita dei due amanti, insieme, dove passato e presente si scioglieranno nell’aria gelida della brughiera, in quello stesso vento che accarezza le tombe dell’ultimo paragrafo del romanzo che si chiude sull’immagine di una terra finalmente quietata sui due tormentati protagonisti.







