Autoritarismo, conformismo, deresponsabilizzazione / La normalità del male
In un mondo soffocato da libri dedicati al piacere, dall’estetico al gastronomico, riflettere sul male pare fuori luogo. Ad eccezione di occasioni programmate e rituali, la nostra società si presenta impegnata nella rimozione del male, al suo oblio grazie a dosi massicce di beni di consumo, pillole, creme, compendi tecnologici. Eppure il male è esistito ed esiste e rintanarlo all’inferno non risolve il problema. Il Novecento è stato il secolo del male assoluto e ogni giorno lo vediamo incarnato nel dolore, nella violenza, nella crudeltà dei rapporti, nelle nuove malattie sociali. Non è quindi un caso che molti, e questa rivista lo ha ben presente (da ultimo F. Bellusci, “Come fare del male e continuare a vivere bene”, e dello stesso autore, “Il male si espande nel mondo come un fungo”) si siano interrogati sulla sua presenza, sulla sua diffusività, su chi lo pone in essere, sui meccanismi che lo generano, lo giustificano, lo rendono intollerabile, lo pesano. E l’editoria non dimentica l’argomento con saggi filosofici (I concetti del male, Einaudi, 2002) o psicologici (Il male, Raffaello Cortina, 2000), stimolando l’attenzione con una suggestiva gamma di declinazioni, dalla classica ‘Banalità’ della Arendt alla “Umiltà” di Cassano (Laterza,2011), dalla “Stupidità” di Bencivenga (Feltrinelli 2018), alla “Fragilità” di Banhoffer (Piemme 2015), all’“Identità” di Burgio e Zamperini (Franco Angeli 2013). Non si sottrae a questo catalogo La normalità del male di Isabella Merzagora edito da Raffaello Cortina, 2019, con una prospettiva che si nutre della cultura criminologica dell’autrice.
L’esame iniziale è dedicato ai temi classici, alla presenza del male nell’uomo come componente strutturale o come accidente, alla realtà concreta del suo manifestarsi, al suo controllo e al suo superamento. L’interesse dell’autrice si rivolge però principalmente alla tempesta che ha travolto il Novecento con le efferatezze del nazismo. La domanda che si pone è ancora una volta: come è stato possibile che interi popoli si siano resi responsabili di massacri e di genocidi? Come comprendere una condotta collettiva, con taluni sprazzi di umanità individuale che non hanno falsato la disumanità collettiva? Le analisi della Merzagora sono approfondite, differenziando le cause tra quelle che non hanno impedito il genocidio e quelle che hanno contribuito a generarlo.
Le prime sono rilevanti ma non determinanti. Vi sono state motivazioni sociali conseguenti alla Grande Guerra, ma non esclusive, perché diffuse anche in altri paesi che non si sono macchiati di queste efferatezze. Un posto autorevole ha avuto la cultura, ma anche questo indicatore sfuma presentando la Germania una galleria di nomi illustri e celebrati, lontani dalla galassia nazista. L’autrice menziona ancora gli squilibri mentali, che saranno stati talora pure presenti, ma esclusi perlopiù dagli psichiatri interpellati e incompatibili con la diffusione quantitativa di un fenomeno che porterebbe a ritenere l’intera collettività tedesca folle, affermazione palesemente implausibile. Potrebbe infine aver contribuito il processo di civilizzazione tedesco, ma l’argomento è debole perché la nazione era incastonata al centro dell’Europa e all’apice del progresso.
Più solide sono le cause che l’autrice menziona per aver contribuito allo sterminio.
La prima è l’autoritarismo, il conformismo, la deresponsabilizzazione. Come ha osservato Milgram sulla base dei suoi esperimenti (Obbedienza all’autorità, Einaudi, 2003), chi entra in modo volontario in un sistema percepito come legittimo si sente obbligato. I concetti di lealtà e dovere diventano imperativi categorici morali che travalicano il rapporto con la vittima e si trasformano in strumenti del volere altrui. L’obbedienza all’autorità è divenuta un fattore determinante per spiegare l’acquiescenza di tanti cittadini alle atrocità secondo l’antico adagio “Potenti con i deboli e deboli con i forti”. Essa può essere avvenuta anche per paura, per i rischi nell’opporsi al nazismo anche se maggiore peso può aver avuto secondo l’autrice il conformismo, l’opportunismo (carriera, interesse, profitto), la pressione dei gruppi dei pari, il bisogno di approvazione sociale, il crearsi della ‘ coscienza sostitutiva’ nel poter sostenere che la responsabilità non è propria ma di chi ha dato l’ordine. Con il trionfo della deresponsabilizzazione.
La seconda causa è la sordità della coscienza. La burocrazia, quando si preoccupa dell’esecuzione di un compito, narcotizza la coscienza allorché si muove in termini di mezzi e non di fini, cioè senza porsi domande. Le società moderne, imbullonate in rigide strutture burocratiche, attenuano il senso di responsabilità personale di chi realizza le direttive. Il gruppo di riferimento esercita pressione sul comportamento, stabilisce norme morali, si erige a padre. Questo comporta la frantumazione esasperata dei compiti, la diluizione delle responsabilità in quanto ogni partecipe alla catena si sente responsabile solo del segmento che gli appartiene. Inoltre chi è incline alla deresponsabilizzazione ha interiorizzato regole e non valori, è portato ad aver bisogno di un sostegno esterno che gli fornisca promesse attraenti, accoglibili perché drastiche ed elementari.
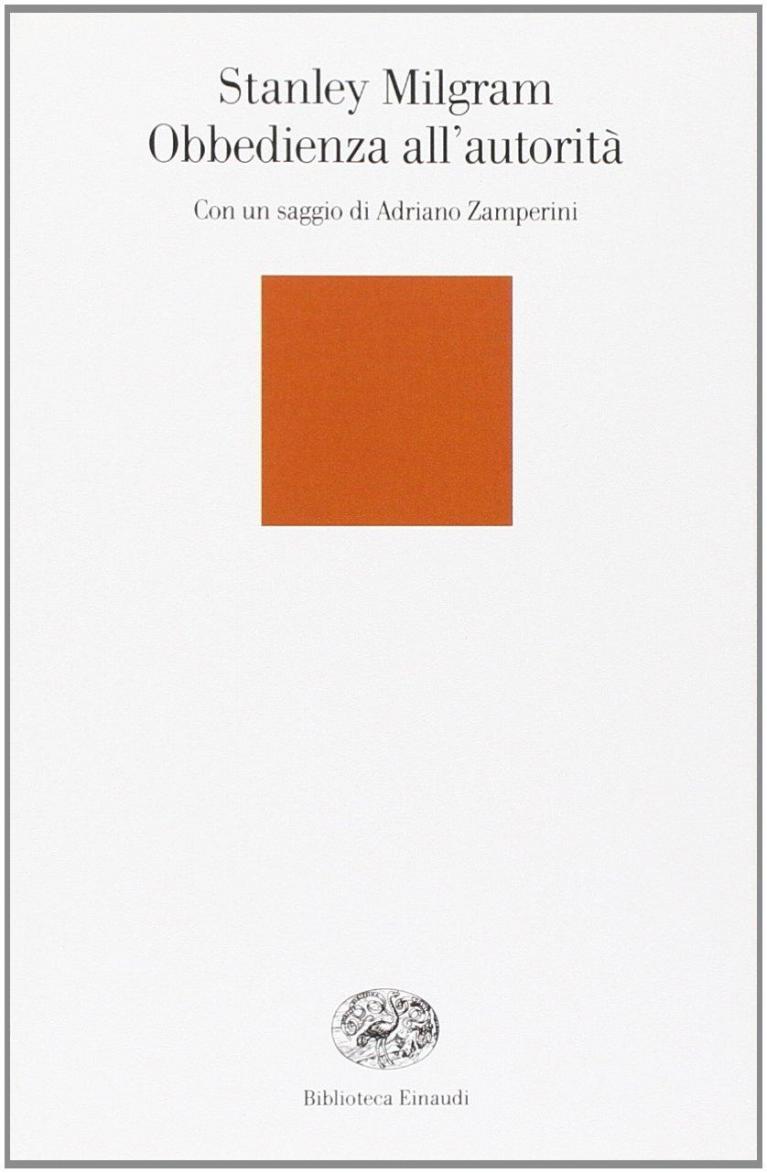
E di qui nasce l’attrattiva per il pensiero magico, superstizioso, antiscientifico. Sono messi in disparte coscienza e valori con la tecnica dello sdoppiamento, del ‘confronto vantaggioso’ cioè del proteggersi da mali maggiori, senza indagare troppo finemente sul costo in termine di vittime. È la ricorrente e mai esaurita logica del ‘capro espiatorio’ che riprende vigore quando convergono il rancore verso chi è indicato immeritatamente avvantaggiato (le ‘caste’), la frustrazione, la rivendicazione, il timore per la propria incapacità.
Ulteriore causa è l’altrismo, termine coniato da Taguieff (L’antisemitismo, Raffaello Cortina, 2014) per indicare la forza asfissiante del pregiudizio. Nei totalitarismi il razzismo e l’antisemitismo sono coesistiti, la loro bandiera è comune come ricorda biecamente Céline, “L’ebreo è un negro”. E acutamente Adorno, in La personalità autoritaria, nota che ai soggetti cui non piacciono gli ebrei non piacciono neanche le altre minoranze. Si radica la classica e irrigidita contrapposizione tra Noi e Loro, tra chi è il meglio e chi non lo è perché cattivo, appartenente a un raggruppamento umano diverso e proprio per questo da rifiutare. Una razza diversa, meno nobile, inquinante, da respingere, nella sostanza anche un avversario, un nemico, un soggetto inaccettabile perché non ha partecipato alla fondazione della città e del patto sociale e quindi ad esso estraneo e pericoloso.
Esiste poi un problema collegato al precedente. È quello degli ‘uccisori di massa’, dei carnefici che erano al contempo buoni padri di famiglia, dal volto mite in casa e con il mitra nei campi di concentramento. Ma chi sono, si chiede l’autrice riprendendo gli interrogativi del Semelin in Purificare e distruggere (Einaudi, 2007). Innanzitutto è arduo applicare distinzioni rigide tra esecutori e spettatori, in quanto il clima di quel periodo mescolava sentimenti e condotte, proprio quelle che hanno costituito lo zoccolo del regime nazista. Del resto solo di rado, e in termini insufficienti, si riflette sull’equiparazione giuridica e sostanziale tra chi esegue materialmente le direttive sul campo o gli assassini da tavolino che non vedono le vittime e chi agevola, tollerando, che quelle direttive e quelle condotte operative vengano poste in essere. Si è trattato di un agire legale a fronte di regole illegali?
Comunque vi sono stati, e in grande quantità, persone, militari e non, che sono passati all’atto delittuoso, conducendo ‘a latere’ dei propri misfatti vite all’ apparenza normali, regolari, familiari, tra musica, cultura e amore per gli animali. È in questo senso indicativa l’indagine di Browning (Uomini comuni, Einaudi, 2004) sul battaglione n.101 composto da 210 riservisti, di umili radici, privati, che assassinarono tra il 1942 e il 1943 circa 38.000 persone, partecipando anche al rastrellamento di 45.000 ebrei poi condotti a Treblinka. Fu aperta dopo la guerra un’inchiesta e costoro furono interrogati tra 1962 e 1967 parlando di spirito di emulazione, carriera, sentimenti banali. Mostrarono di essere stati desensibilizzati dalla divisione del lavoro tanto che dopo il primo massacro divennero più avvezzi alla crudeltà, favoriti dalla parcellizzazione dei compiti. Alcuni studiosi reagirono ritenendo quelle considerazioni riduttive a causa del violento antisemitismo eliminazionista che fa parte integrante della identità tedesca (Goldhagen, I volenterosi carnefici di Hitler, Mondadori 1998).
Come hanno potuto comportarsi in quel modo? Nell’affrontare la questione diviene assorbente il tema, già indicato, dell’obbedienza come ossequio all’ordine ricevuto, come passaporto muto e cieco. Per agire in quei modi criminali, si chiede l’autrice, il male era ed è ‘dormiente’? Esiste cioè dentro di noi come una bestia che può risvegliarsi e azzannare inaspettatamente, come una sorta di vocazione al male? Gli studiosi dell’anima oscillano, ma non escludono che l’esecuzione di genocidi sia espressione della ‘mancanza dell’anima’, di un vuoto morale, di una tensione endogena. Come si è affermato, noi siamo divisi nell’interno in due e talora un sé parziale funziona da sé intero (Bollas, Il lavoro dell’inconscio, Raffaello Cortina, 1996).
Ma in quella situazione era possibile disobbedire, reagire, disattendere quegli ordini iniqui? Reagire, secondo le parole della Arendt, allo Stato di delitto? Documentate indagini rispondono affermativamente, segnalando che così è stato e che le conseguenze non sono state così negative come nei processi gli imputati hanno voluto far intendere (Burgio – Lalatta Costerbosa, Orgoglio e genocidio, Deriveapprodi 2016). È l’eterno conflitto tra i doveri legali e quelli di coscienza, tra le leggi dello stato e loro contestabilità, e più in particolare la sindacabilità degli ordini ricevuti e ritenuti illegittimi, come ammette il nostro attuale codice penale. Questione ancor più delicata se il tutto avviene in tempo di guerra.
L’autrice accenna anche a un altro versante, più esplorato in altri suoi precedenti saggi: come la malvagità influisce sulla sanità mentale? Può intaccarla e ridurla o escluderla? Non entra in gioco, al proposito, il giudizio morale, se cioè una persona possa essere buona o cattiva, se sia animata da un istinto di morte o da pulsioni distruttive, ma è decisivo accertare come quella persona sia giudicabile dallo Stato in funzione di giudice penale? E quale pena applicar loro se colpevoli? Le opinioni sono le più diverse. L’approccio nosografico rinvia alle classificazioni e solo rientrando in quei ‘range’ la malattia è riconosciuta. E se riconosciuta, la colpevolezza deve essere esclusa perché non si è colpevoli se non si è in grado di scegliere e di volere. L’approccio sociologico invece ritiene che siano tutti responsabili e imputabili perché espressioni di un disagio che la società non è in grado di superare. Ma questi esecutori di massa erano consapevoli della loro malvagità? Sapevano quello che facevano e lo volevano? Se la risposta è positiva, quale pena applicare loro e come recuperarli?
Torna di attualità il regista Kubrick con la sua Arancia meccanica, laddove il protagonista Alex (nome non casuale perché ‘senza legge’) è condizionato strutturalmente alla violenza e solo i trattamenti, violenti e disumani, cui è sottoposto gli impediscono di agire. Diverso l’approccio del suo ispiratore Burgess, secondo cui scegliere la malvagità è un’impresa personale, non condizionata socialmente o organicamente. Alex è cattivo di suo e deve essere punito perché ha agito con lucidità. Il tema è aperto, le neuroscienze lo alimentano, la legge confida nella libertà dell’uomo. Fino ad oggi.







