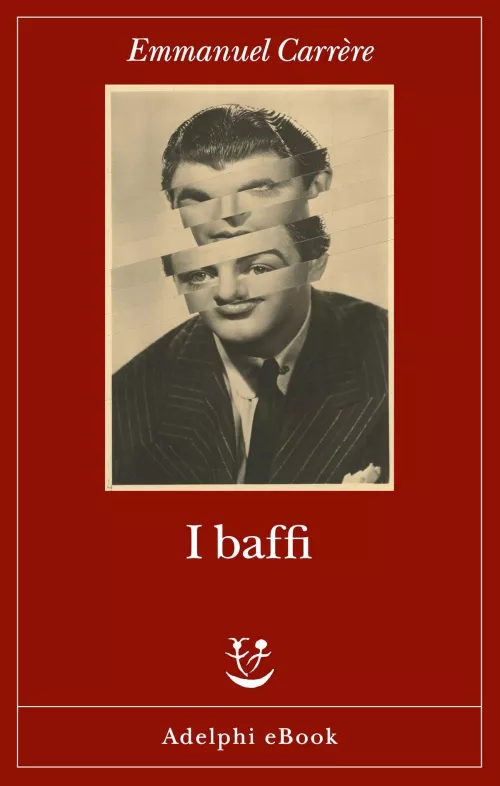Un contagio d'irrealtà / I baffi di Emmanuel Carrère
Cominciamo con qualche citazione:
“L’assessore di collegio Kovalèv si svegliò abbastanza presto e con le labbra fece Brr…, cosa che faceva sempre quando si destava, sebbene nemmeno lui sapesse spiegare perché. Kovalèv si stirò, ordinò di dargli un piccolo specchio che stava sul tavolo. Voleva guardare un foruncoletto che la sera prima gli era spuntato sul naso; ma, con suo sommo stupore, vide che al posto del naso aveva uno spazio perfettamente liscio”. (Gogol, Il naso, trad. P. Zveteremich, Garzanti, 1967).
“– Che fai? – mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. – Niente – le risposi, – mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo dolorino. Mia moglie sorrise e disse: – Credevo ti guardassi da che parte ti pende. Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda: – Mi pende? A me? Il naso? E mia moglie, placidamente: – Ma sì, caro. Guardatelo bene: ti pende verso destra”. (Pirandello, Uno, nessuno e centomila, ed. a cura di G. Mazzacurati, Einaudi, 1994).
“Professore, perché non mi racconta bene la storia dei suoi baffi?
Ma è semplicissimo. Me li lasciai crescere prima della scoperta del rasoio elettrico per diminuire la sofferenza quotidiana dell’abrasione. Naturalmente nessuno credette, neanche in famiglia, alla vera ragione: comunque entrarono nella mia fisionomia. E appunto per questo, quando fui colpito dalla mia prima vera malattia, il 14 luglio del 1970 (ma sì, un “quatorze juillet”!), me li tolsi, per significare che ero un altro”. (Diligenza e voluttà, Ludovica Ripa di Meana interroga Gianfranco Contini, Mondadori, 1989).
Questi tre brani ci sono subito venuti in mente, leggendo l’attacco di I baffi, romanzo di Emanuel Carrère, uscito nel 1986 (da cui lo stesso autore trasse anche un film nel 2005, titolo italiano: L’amore sospetto) e ristampato oggi da Adelphi nella traduzione di Maurizia Balmelli.
Qui, in effetti, un giovane e brillante architetto, una bella mattina davanti allo specchio in bagno, decide di tagliarsi i baffi, la moglie approva. Poi lei esce a fare la spesa. Lui, mentre è dentro la vasca, esegue l’operazione con la gioia di un bambino che ne stia combinando una delle sue. Chissà come reagirà Agnès? Si domanda, quasi preoccupato, quasi il taglio dei baffi equivalesse a un tradimento. Ma Agnès non reagisce, non si dimostra sorpresa, non si accorge di nulla, né al rientro dalla spesa, né quando i due, lui e lei, si recano in macchina dagli amici Serge e Véronique che li aspettavano per cena. Del resto anche loro paiono non aver notato affatto il cambiamento in lui, l’architetto (che nel film si chiama Marc, ma nel romanzo è, se non ci inganniamo, un personaggio senza nome) e si comportano come sempre. Quando lui, per provocarli, fa allusioni al socialismo glabro imposto da Fabius, o ai baffi che Duchamp aveva aggiunto alla Gioconda, restano impassibili, non abboccano minimamente all’esca. Lui è ferito come un bambino, ma, questa volta, un bambino che gli adulti si ostinano a trascurare.
A casa, di notte, non resistendo più al silenzio della moglie sul taglio dei baffi, gliene parla lui esplicitamente, sbotta: “Ma insomma, i miei baffi!”. Lei casca dalle nuvole. “Ma tu non hai mai portato i baffi!”. Telefonano nel cuore della notte ai due amici della cena. Sconcerto, stupore, anche da parte loro, e nessuna ammissione sui baffi tagliati.
Il protagonista, a questo punto, pensa di essere vittima di uno scherzo di gruppo, di una macchinazione collettiva, ideata dalla moglie, dato che Agnès era specialista in burle atroci di questo tipo. Le chiede di smettere. Il bel gioco dura poco. Ma lei nega la beffa e gli consiglia di rivolgersi a uno specialista. Anche nello studio in cui lavora, i colleghi Jérôme e Samira non notano nulla. Solo che lui ha la faccia strana. Forse negli ultimi tempi ha lavorato troppo. Probabilmente è esaurito. Dovrebbe prendersi un periodo di vacanza.

Riprende il sopravvento, nei suoi pensieri, la parola “farsa”, associata alla parola “congiura”.
A noi vengono in mente altri celebri testi come la Novella del grasso legnaiuolo o, ancora meglio, il Maistre Pathelin, farse rinascimentali, dove il tema fondamentale è proprio questo: “noi gli faremo credere che fusse diventato un altro”. Perché anche in essi si parte dalla pura e semplice burla, che sfocia poi però in un’autentica crisi epistemica, che pare minare alla base le fragili fondamenta dell’io.
Lui, il quadro dinamico e performante, l’architetto parigino di successo pare quindi dubitare di tutto. Della sua salute psichica e di quella della moglie. Nonostante una di quelle notti abbiano fatto l’amore con foga travolgente, e lei nell’apice dell’atto gli abbia gridato “Sei tu! Sei tu!”, lui la crede addirittura in combutta con il collega Jerôme, di cui pensa sia l’amante. L’eterno triangolo, lui, lei, l’altro. Dove lei e l’altro vogliono far passare lui per pazzo. Farlo internare. Addirittura eliminarlo. Lui giunge a temere per la propria incolumità fisica.
Quando lei successivamente nega delle assolute evidenze, come la conoscenza con gli amici Serge e Véronique, una recente vacanza a Giava e relative foto di lui con baffi o l’esistenza in vita del padre di lui (era morto? Da un anno? No, non è possibile!) capisce che l’unica via di salvezza è la fuga.
Andarsene via, lontano. Il più presto possibile. Prima che l’irreparabile accada.
Togliersi subito da quell’atmosfera da incubo che gli evoca atmosfere degne di film come I diabolici o Piano, piano dolce Carlotta e anche, a dire il vero, L’esorcista, per certe somiglianze che lui immagina possibili tra l’efferata bambina posseduta e sua moglie: stesso bagliore di un occhio aperto in agguato. (A costo di commettere quella che certi critici d’antan sanzionavano come “fallacia biografica”, ricordiamo che Emanuel Carrère ha un notevole passato di critico cinematografico).
Anche la partenza improvvisa da Parigi per mete distanti viene vissuta con l’occhio del cinefilo: è come in certi film di guerra, pensa, quando un personaggio lascia un riparo per lanciarsi allo scoperto, sotto una raffica di pallottole. Inutile dire che si esce a comprare le sigarette (tra l’altro è appena ricaduto nel vizio), meglio darsi alla fuga senza tante storie.
Dopo uno scalo nel Bahrein, atterra a Hong Kong. Lì trova un’occupazione che riesce a calmarlo. Passa le sue giornate sul traghetto che da Kowloon va a Hong Kong e viceversa. La traversata, nella sua totale reversibilità, lo placa. Ripetitività e contesto adeguato alle sue esitazioni pendolari lo affascinano. Sì, perché lì è in parte riassalito dai suoi dubbi. A volte gli pare di essere solo contro tutti, ossia Agnès, Jérôme e gli altri, che lo vogliono defraudare di ogni cosa, compreso il suo passato (in cui sono naturalmente inclusi i baffi). Altre volte pensa di essere ancora innamorato della donna, al punto che se lei gli avesse puntato contro la tempia una pistola, lui l’avrebbe amata ugualmente, che è un po’ la versione laica dell’etiam si occiderit in ipso sperabo, parole di Giobbe secondo la Vulgata (religione perfetta, ma non è il testo, come scrive Ceronetti).
Comunque rimanendo a Hong Kong, sempre o quasi sul traghetto avanti e indietro, sente lentamente avvicinarsi uno stato di assenza di responsabilità, responsabilità verso se stesso, il proprio nome, il proprio passato che lo avvicina ai pazzi del manicomio, quelli di un certo posto del Sud-Ovest della Francia di cui aveva vaga notizia, anche loro imbarcati su un traghetto interiore mai stanco di andare e venire.
Nel frattempo si lascia ricrescere i baffi. Pensa che la loro ricomparsa possa annullare in certo senso tutti i misteri e le incongruenze legate al loro taglio.
Ogni giorno che passa procede verso una condizione di maggiore intorpidimento, di annullamento di sé. La leggenda di cui si pensava protagonista si va pian piano avvolgendo di brume.
Un giorno s’imbarca per Macao in seguito al consiglio di un turista australiano che aveva incontrato sul molo.
Giunto nella colonia portoghese, sceso all’Hotel Bela Vista il suo stato di narcosi giunge a maturazione. Non fa nulla se non camminare, dormire lunghe sieste e bere vinho verde. Se il dolce far niente secondo un vecchio detto consiste nell’ascoltare crescere la propria barba, lui ascolta crescere i suoi baffi. Pare quasi sereno. Quasi.
Del resto anche a Parigi uno dei pochissimi momenti di beatitudine lo aveva avuto un pomeriggio, quando si era messo a letto: il sole filtrava attraverso le veneziane, non si sentiva nessun rumore se non quello di una lavatrice in funzione da qualche parte nel palazzo.
A Macao gli tiene compagnia il rumore costante del vecchio e scassato condizionatore dell’albergo.
Un giorno però, in bagno, anzi quando è dentro la vasca, esattamente come nella scena iniziale, decide di tagliarsi i baffi di nuovo.
Non diremo come va a finire questa volta.
Un romanzo degli anni Ottanta dunque, dove però c’è già quella paura di perdersi, di scoprire che dietro la facciata sociale non si è niente, che sarà tematizzata successivamente in L’Avversario. E in Limonov poi non sarà anche lì questione di misurarsi con un’identità improvvisamente revocata in dubbio (“Non mi raccapezzavo. Il suo caso mi sembrava passato in giudicato, senza appello: Limonov era uno sporco fascista, a capo di una milizia di skinhead. E invece adesso una donna che dalla sua morte era unanimemente considerata una santa parlava di lui, e dei suoi, come di eroi della lotta democratica”)?
Insomma un libro, questi I baffi, spaesante, inquietante, perturbante (davvero unheimlich) come i giorni che stiamo vivendo. Buona lettura.